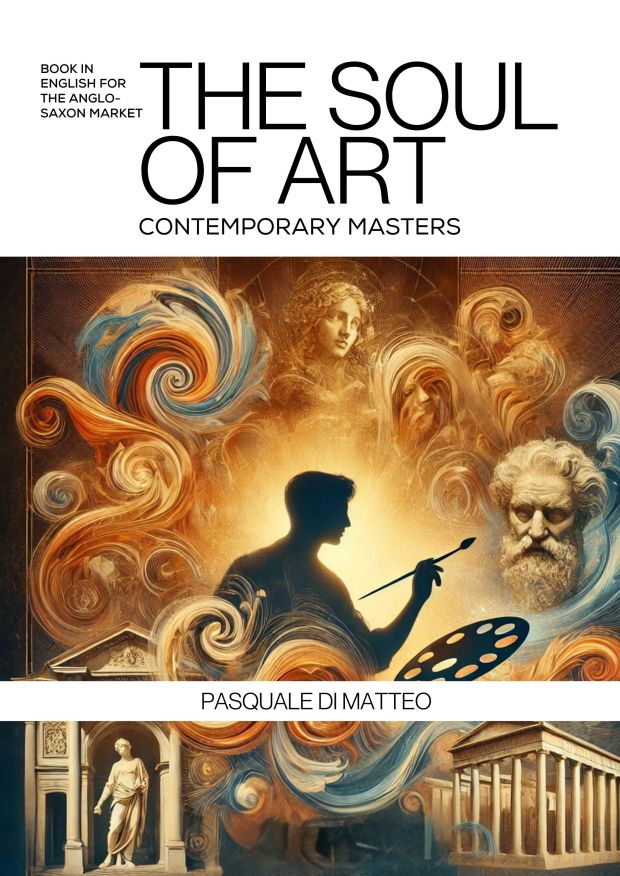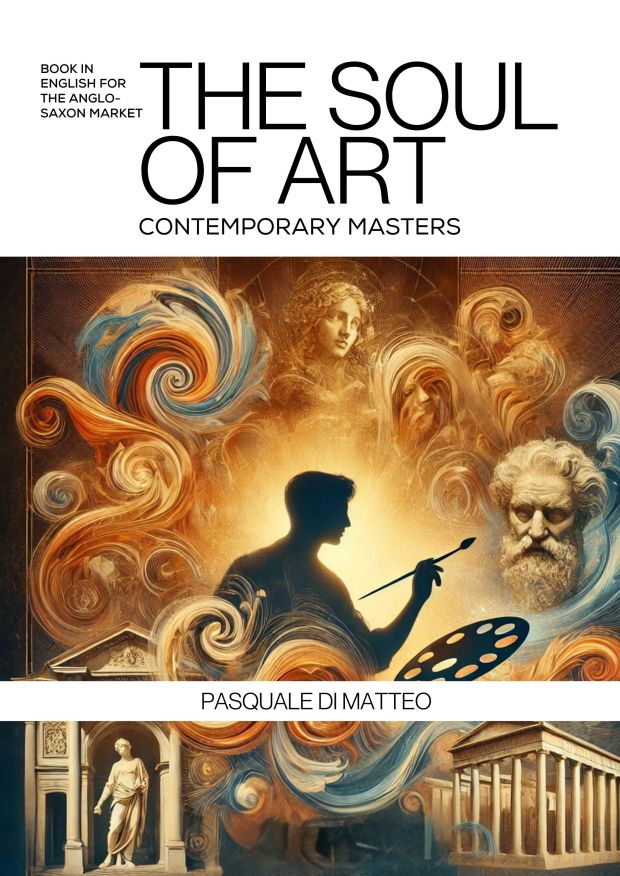
The Soul of Art è un libro pubblicato nel mercato anglosassone, in lingua inglese. Il volume è disponibile anche in Italia, su tutte le piattaforme online (Mondaddori, Feltrinelli, Hoepli, Amazon…) e può essere ordinato in qualsiasi buona libreria tradizionale.
All’interno ci sono alcuni dei più iconici maestri d’arte che operano in Italia, raccontati dal Dott. Pasquale Di Matteo, critico d’arte internazionale, vicedirettore del magazine Tamago-Zine e analista geopolitico, rappresentante per l’Italia della società culturale giapponese Reijinsha.
L’INTRODUZIONE DI PASQUALE DI MATTEO
In qualità di critico d’arte, sono da tempo convinto che il compito dell’artista non sia semplicemente decorare il mondo, ma rivelarlo.
Per questo motivo, ho scelto di riunire in questo volume trentacinque artisti italiani, le cui voci considero essenziali per comprendere la complessità del nostro tempo presente.
Ciascuno di essi parla attraverso un linguaggio personale – a volte lirico, a volte crudo, a volte sperimentale – che cerca di penetrare oltre la superficie delle apparenze, scoprendo le tensioni, le contraddizioni e le aspirazioni che definiscono la nostra epoca.
Nel corso della storia, gli artisti sono stati testimoni e interpreti della propria epoca.
Otto Dix e George Grosz, con i loro mordenti ritratti della Germania del dopoguerra, o Picasso, con la sua angosciata denuncia della guerra in Guernica, ci ricordano che l’arte può essere uno specchio senza compromessi delle fratture della società.
Oggi, forse più che mai, abbiamo bisogno di artisti che resistano alla tentazione di creare soltanto oggetti gradevoli per interni domestici. Abbiamo bisogno di artisti che osino confrontarsi con le dissonanze della realtà, che sappiano interrogare, provocare e risvegliare il pensiero critico.
Gli artisti qui raccolti incarnano questa responsabilità. Le loro opere non si limitano al diletto estetico; sono atti di riflessione, testimonianza e resistenza. Dimostrano che la bellezza, quando è autentica, non è mai superficiale – è sempre legata alla verità, alla memoria e allo sforzo incessante di dare un senso alla condizione umana.
Presentare queste trentacinque voci italiane a un pubblico internazionale significa affermare il ruolo dell’arte come strumento vitale di dialogo, coscienza e trasformazione. È mia speranza che il lettore incontri in queste pagine non solo opere d’arte, ma anche l’energia vitale di una società che continua a interrogarsi attraverso i suoi artisti.
Di seguito, le traduzioni in italiano delle critiche in inglese su ciascun artista.
GLI ARTISTI
GIULIANA AMBROSECCHIA



MATERIA E ANIMA
Analizzare il corpus delle opere di Giuliana Ambrosecchia significa intraprendere un percorso ermeneutico dentro una dialettica fondamentale: quella che oppone, e al contempo unisce, la densità caotica della materia all’essenza intangibile dell’anima.
La sua non è una pittura che si limita a rappresentare; è un atto di scavo, un’archeologia del sentimento che riporta alla luce frammenti di verità interiore dal magma dell’esistenza, cosicché ogni tela diventa insieme un campo di battaglia e, simultaneamente, un tempio che veicola messaggi esistenziali.
È in questo ossimoro che risiedono la forza propulsiva e la cifra inconfondibile della ricerca dell’artista.
La visione di Ambrosecchia trascende la mimesi del reale per abbracciare un espressionismo che si potrebbe definire “esistenziale”, in cui il mondo esterno – le sue asperità, le sue ferite, la sua complessità inesorabile – viene trasposto sulla tela attraverso una gestualità vigorosa, quasi una lotta fisica con il pigmento e il supporto.
Incontriamo fondi costruiti per successive stratificazioni, dove la spatola non stende ma incide, graffia, accumula e a volte sottrae, lasciando affiorare i substrati come memorie geologiche dell’esperienza vissuta.
In un’opera, con le sue sbarre verticali color ruggine che s’innalzano da un fondo nero e ocra che evoca la sabbia, ciò che vediamo non è un paesaggio ma la percezione di un paesaggio interiore: forse una prigione, o i resti di una struttura che un tempo offriva riparo ed è ora ridotta a scheletro e memoria.
Qui la materia è pesante, palpabile, satura di tempo.
Allo stesso modo, nelle opere puramente astratte, si percepisce un’esplosione di energia cromatica – arancio, oro, viola – orchestrata in pennellate che non descrivono ma costituiscono l’evento stesso: un’eruzione emotiva, un istante di catarsi cristallizzato nella sua dinamica irripetibile.
Eppure, da questo universo materiale, da questo caos primordiale, emerge quasi sempre una figura. È questo il punto di svolta, il fulcro semiotico di tutta la sua produzione.
Le figure di Ambrosecchia, quasi esclusivamente femminili, non sono corpi in senso anatomico, ma ideogrammi dell’anima, epifanie di pura essenza che appaiono con una grazia luminosa, quasi calligrafica.
Sono quasi sempre bianche, o segnate da un contorno netto eppure impalpabile, come composte di luce o silenzio condensati. Questo contrasto non è meramente estetico ma profondamente filosofico.
Se il fondo incarna l’essere-nel-mondo, con il suo peso, il suo rumore, la sua violenza, la figura rappresenta l’essenza: il nucleo inviolabile del sé, la coscienza che osserva, sente, resiste.
La figura accovacciata contro un fondo turbolento di neri, blu e gialli è fissata in una postura fetale – un gesto di autoprotezione, un ritrarsi in se stessi per resistere alla tempesta del mondo.
Eppure, la sua bianchezza non è segno di fragilità ma di resilienza. È un vuoto che si fa colmo di significato, un’isola di quiete in un mare tempestoso.
La pittura di Ambrosecchia suggerisce che l’identità più profonda non si trova nella dispersione ma nel raccoglimento; non è definita da ciò che la circonda, ma dalla sua capacità di rimanere intatta nonostante ciò che la circonda.
Questo tema della trascendenza interiore evolve attraverso molteplici declinazioni. La donna vista di spalle, contro un fondo bruno terroso solcato da striature d’oro, acquista una sacralità quasi bizantina.
Il corpo, sempre traslucido e spiritualizzato, non è più in una postura difensiva ma di contemplazione, circondato da fioriture bianche che sembrano scaturire direttamente dalla sua aura.
Qui il rapporto tra sé e mondo è meno conflittuale, più armonioso, e suggerisce una fase di accettazione e di fioritura interiore. La materia non è più avversaria ma humus fertile.
L’apice di questa evoluzione spirituale si manifesta nell’opera dominata dall’acquamarina, dove la figura perde ogni peso materiale per farsi pura linea, pura danza.
Si leva da un loto – simbolo per eccellenza di purezza e rinascita – e in un gesto di gioia solleva verso il cielo un’altra vita, un bambino tratteggiato con la stessa leggerezza immateriale.
Il mondo qui non è più caotico e denso ma un gradiente fluido e vitale, un grembo cosmico. È la rappresentazione della grazia, della creazione, della liberazione totale dai legami della materia.
A questo punto l’artista rivela una notevole versatilità stilistica, abbandonando spatola e impasto per il pennello e la velatura, dimostrando come per lei la tecnica non sia mai fine a se stessa ma solo veicolo di senso.
La semiotica di Ambrosecchia si costruisce dunque su questa polarità fondamentale: cromatismo denso contro superficie levigata; tinte terrose e scure contro il bianco luminoso; gesto violento contro linea delicata.
Come nella vita, dove il bene e il male sono solo due facce della stessa medaglia.
Anche nelle opere dove la figurazione si fa più complessa, questa dialettica persiste. Ci imbattiamo in un mondo acquatico, forse sottomarino, saturo di bianchi spugnati e blu profondi.
Da un lato, una figura stilizzata è imprigionata in una sorta di scatola prospettica, simbolo di costrizione razionale o isolamento.
Dall’altro, un’altra figura prorompe esultante da un’esplosione di verde, le braccia levate verso due grandi fiori simili a creature fantastiche.
È la narrazione di un percorso: dalla stasi alla liberazione, dalla riflessione all’azione estatica.
La filosofia che sorregge questa produzione è una forma di umanesimo resiliente. Ambrosecchia non nega il dolore, la difficoltà, il peso dell’esistere; anzi, li rende tangibili, quasi tattili, sulle superfici delle sue tele.
Eppure la sua indagine non si ferma alla constatazione del caos. È una ricerca appassionata e lucida del centro di gravità permanente dell’essere umano: la capacità di trovare, o di creare, uno spazio interiore di pace, silenzio e significato.
La sua arte è un atto di fiducia nella capacità dello spirito di non farsi sommergere, di fiorire anche nel terreno più inospitale.
Giuliana Ambrosecchia è un’artista dalla voce autentica e potente, capace di coniugare la forza tellurica dell’Espressionismo Astratto con una sensibilità figurativa di rara eleganza spirituale, veicolando messaggi esistenziali di profonda risonanza filosofica
Le sue opere non sono semplici immagini da contemplare ma esperienze da attraversare, che invitano a toccare con gli occhi la scabrosità del mondo e poi a posare lo sguardo sulla purezza levigata di un’anima che ha trovato il suo posto.
La sua pittura è la cronaca di questa ricerca, un diario di bordo scritto non con parole ma con pigmento, materia e luce.
È testimonianza che anche nella notte più densa, basta un contorno di bianco per affermare l’indomita presenza dell’umano.
ANNA BELLINAZZI



LA MITOPOIESI DELL’ANIMA
La pittura di Anna Bellinazzi è un atto di mitopoiesi.
In un’epoca che ha proclamato la morte delle grandi narrazioni in favore della superficialità delle immagini, la sua arte rappresenta un tentativo audace – quasi anacronistico – di ricostruire un cosmo simbolico personale, uno spazio dove le forze archetipiche dell’anima assumono forma e colore.
Questa non è mera pittura fantastica, né un derivato del Simbolismo storico; piuttosto, è la nascita di una cosmogonia privata, una cartografia dell’inconscio che impiega un linguaggio visivo sontuoso e stratificato per mappare i territori della trasformazione interiore.
L’arte di Bellinazzi rifiuta la superficie del reale per intraprendere un’immersione verticale nelle profondità dell’essere, riportando alla luce visioni dotate della densità del sogno e della perentorietà del mito. La sua visione artistica appartiene a dimensioni parallele e ai labirinti dell’anima. La realtà fenomenica non è il suo soggetto, ma al massimo un vago punto di partenza: un lessico di forme – fiori, acqua, il corpo femminile – viene immediatamente decontestualizzato e riassemblato in una sintassi ultraterrena. In una dimensione parallela, appunto.
Il suo approccio al mondo non è quello di un’osservatrice ma di una sciamana; le sue tele sono portali, spazi liminali dove il velo tra il visibile e l’invisibile si assottiglia, quasi si fa trasparente. La personalità che emerge è quella di un’artista che crede fermamente nel potere salvifico e cognitivo dell’immaginazione, intesa non come fuga dalla realtà ma come strumento gnostico per coglierne l’essenza più nascosta.
Sul piano stilistico, Bellinazzi orchestra una sintesi complessa e altamente personale di correnti diverse. Vi si trova l’opulenza cromatica e la sinuosità decorativa del Liberty, l’intensità emotiva del
Simbolismo fin de siècle, ma animate da una gestualità e una presenza materica che appartengono inequivocabilmente all’esperienza contemporanea. La sua tecnica è alchemica: il colore non è semplicemente steso ma accumulato, graffiato, velato, spesso deposto con una densità d’impasto che conferisce agli elementi naturali una tridimensionalità tattile, quasi scultorea.
Questa carnalità del pigmento crea un drammatico contrasto con la levigatezza eterea con cui sono resi i corpi delle sue figure femminili. È una dialettica fondamentale nella sua opera: la materia pesante, organica del mondo naturale contrapposta alla sostanza luminosa e intangibile dello spirito.
Le sue peculiarità stilistiche convergono in un lessico iconografico ricorrente. Il motivo più pervasivo è la figura femminile alata, articolata in innumerevoli varianti – angelo, farfalla, fata, fenice. Le ali non sono mai un mero attributo decorativo ma il significante primario della trascendenza, della metamorfosi, della capacità dell’anima di elevarsi sopra la condizione terrena.
Che siano le ali composite di una figura in preghiera, o le ali fiammeggianti di una donna-fenice che sorge da un mondo infranto, segnalano sempre un superamento di stato, una liberazione. Una catarsi.
Un altro elemento chiave è l’acqua, spesso popolata di ninfee, simbolo universale di purezza nata dal fango – metafora perfetta del percorso spirituale. Il cosmo, con i suoi pianeti e le sue nebulose, non è uno sfondo astronomico ma la proiezione esteriore di un universo interiore, vasto e misterioso.
La sua palette è audace e antinaturalistica: rossi ardenti, ori sacrali, blu profondi, turchesi spirituali non descrivono la luce ma sono luce stessa, un’irradiazione emotiva e psichica emanata dai nuclei energetici della composizione.
Dal punto di vista semiotico, ogni tela è un’allegoria densa. Bellinazzi non illustra storie; mette in scena stati dell’anima.
L’opera che raffigura una donna alata di spalle, divisa tra un lato oscuro e uno luminoso, con un gatto nero ai suoi piedi (simbolo dell’istinto e del mistero) e un fiore di loto che rappresenta la rinascita, è un potente emblema della dualità intrinseca all’esistenza, della scelta tra ombra e luce, tra il rimanere ancorati alla terra e lo spiegare le proprie ali.
L’artista riesce a trasformare la materia pittorica in veicolo di messaggi profondi che parlano direttamente all’inconscio di chi guarda. La figura che si dissolve in un’esplosione di fiori e schizzi di colore incarna il rapimento estatico della fusione del sé con l’energia vibrante del cosmo – un’immagine di pura gioia creativa.
La sua opera più astratta, un vortice di colore che ricorda il simbolo dell’infinito, è forse la più esplicita nel rappresentare l’energia primordiale, il caos generativo da cui tutte le forme e tutte le vite originano.
La filosofia che sorregge questa produzione magniloquente è una celebrazione della resilienza e della capacità di trasformazione dello spirito – in particolare dell’energia femminile, concepita come forza creativa e rigeneratrice.
La sua visione della vita è fondamentalmente ottimista, seppur mai ingenua. La presenza della distruzione – il mondo infranto da cui sorge la fenice – e dell’oscurità testimonia una consapevolezza della sofferenza e della lotta. Eppure il messaggio ultimo è sempre di rinascita, della possibilità di trasmutare il piombo della sofferenza nell’oro della consapevolezza.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è diretto, viscerale. Bellinazzi non media, non intellettualizza; la sua passione si manifesta nel cromatismo esuberante e nel tocco vigoroso, mentre la sua lucida osservazione del mondo interiore emerge nella coerenza e precisione del suo linguaggio simbolico.
Anna Bellinazzi è una mitografa moderna, un’artista coraggiosa abbastanza da confrontarsi con i grandi temi universali – vita, morte, rinascita, spiritualità – attraverso un linguaggio pittorico insieme antico e contemporaneo.
Le sue opere sono icone per un’umanità in cerca di nuovi ancoraggi simbolici. Non offrono facili risposte ma aprono finestre su mondi interiori di abbagliante bellezza e complessità. Osservare una sua pittura significa accettare un invito a intraprendere un viaggio verso l’interno, a riscoprire quella dimensione mitica, onirica dell’esistenza che la razionalità moderna ha troppo a lungo cercato di soffocare.
La sua arte è un potente promemoria che, per capire chi siamo, dobbiamo prima imparare a volare.
MARISA BELLINI



L’EPICA DELLA TERRA
In un panorama artistico contemporaneo spesso dominato dall’astrazione concettuale e dalla smaterializzazione dell’opera, l’espressione pittorica di Marisa Bellini si afferma con la forza imperiosa, inattesa, di un canto della terra.
La sua ricerca costituisce un atto di resistenza alle contaminazioni del nostro tempo: un’affermazione potente, tenace, della centralità della figura umana e del suo indissolubile legame con il tempo, il lavoro, il paesaggio. La sua è un’etica del realismo.
Non siamo di fronte a una mera documentazione etnografica, bensì a una trasfigurazione poetica che eleva la fatica, la vecchiaia, il legame ancestrale con la terra a categorie universali dello spirito umano, conferendo una monumentalità quasi sacra a volti e gesti troppo spesso relegati dalla storia ufficiale ai margini.
La visione di Bellini affronta il reale come un terreno da scavare per l’archeologo.
Il suo approccio al mondo è infatti quello di un’archeologa dell’anima, che disotterra storie e dignità da sotto le stratificazioni del tempo. La sua personalità, riflessa in ogni tela, è quella di un’artista dotata di una rara forma di compassione, nel senso etimologico di “patire con”.
Nei suoi ritratti non c’è distacco, non c’è compiacimento estetizzante nella rappresentazione della povertà o della vecchiaia.
Al contrario, si percepisce un rispetto profondo, un dialogo silenzioso tra pittrice e soggetto, raffigurato sulla tela come custode di un’antica sapienza e di una forza indomabile.
Sul piano stilistico, Bellini dimostra una padronanza tecnica che le consente di modulare il linguaggio pittorico in base al soggetto e al messaggio.
Nella sua pratica emerge un’affascinante dualità. Da un lato, in opere come il ritratto della neonata, incontriamo una pittura più levigata, quasi accademica, dove delicate velature costruiscono la sottigliezza degli incarnati e una luce soffusa avvolge la purezza di una vita appena sbocciata nel mondo. È una pittura che carezza – una poesia per lo sguardo.
Dall’altro lato – e forse con maggior potenza e carattere – Bellini adotta un espressionismo materico, un verismo tellurico dove il colore si fa denso, grumoso, tattile.
Qui la superficie pittorica stessa diventa componente significante dell’opera, metafora delle vite dei soggetti rappresentati.
L’epidermide della tela, corrugata e spessa, è la pelle stessa dei volti segnati dal sole e dal vento; è terra arata, corteccia d’albero. Questa scelta tecnica non è mai casuale, ma un modo per fondere significante e significato, rendendo tangibilmente presenti la fatica e la resilienza.
I suoi tratti stilistici ricorrenti costituiscono un vero e proprio atlante umano e simbolico. L’artista elegge la vecchiaia a soggetto privilegiato, non per indugiare nella nostalgia, ma per celebrare la vita nella sua pienezza. I volti dei suoi anziani sono mappe esistenziali, dove ogni ruga è un cammino percorso, ogni solco un racconto di gioie e dolori.
Le mani, quasi sempre in primo piano, sono nodose, deformate dal lavoro, mai inerti; sono mani che hanno sostenuto, coltivato, costruito.
Le figure femminili, in particolare, si elevano a ruolo di cariatidi di un mondo rurale e ancestrale.
La donna che porta la legna sul capo non è semplicemente una contadina, ma un archetipo della forza, simbolo della capacità femminile di reggere il peso del mondo con regale dignità. Le lavoratrici chinate sui campi, quasi fuse con la terra che lavorano, compongono un fregio moderno che ricorda la solennità delle Spigolatrici di Millet, ma percorso da un’immediatezza carnale e una crudezza materica del tutto contemporanee.
La palette di colori di Bellini aderisce a questa visione: dominata dai bruni, dagli ocra, dai verdi smorzati, dai grigi – i colori della terra e della pietra. Eppure, questi toni sono improvvisamente squarciati da un rosso vibrante, dall’azzurro intenso di un cielo terso – lampi di vitalità che lacerano il quotidiano e ne rivelano l’energia nascosta.
La semiotica delle opere di Marisa Bellini è potente perché radicata nell’universale.
L’artista riesce a trasformare la materia in qualcosa di più profondo, svelando l’essenza del reale attraverso una rappresentazione fedele ma mai servile. L’anziano che posa col suo bastone non è solo un ritratto, ma l’incarnazione della memoria storica, custode di un sapere a rischio di scomparsa.
L’uomo barbuto – forse artigiano, forse pensatore – assorto nel suo lavoro, incarna la concentrazione, la dedizione, il valore dell’attività manuale e intellettuale come contraltare alla frenesia del mondo moderno.
Bellini non cerca di commuovere con la narrazione, ma con la pura presenza. Le sue figure ci guardano, o si ritraggono nella propria dimensione, e in entrambi i casi ci interrogano sulla nostra stessa esistenza – sul nostro rapporto con il tempo, con il lavoro, con le radici.
La filosofia che anima la sua espressione artistica è un umanesimo profondo, radicato nella convinzione che ogni vita, specie la più umile e appartata, possieda un nucleo inviolabile di sacralità. La sua visione parla della ciclicità dell’esistere, dal neonato all’anziano, e trova l’epico non nelle gesta grandiose ma nella perseveranza dei gesti quotidiani: fare il pane, coltivare la terra, camminare in montagna.
Il suo rapporto con l’emozione è diretto, mai sentimentale. La sua passione si traduce nel gesto vigoroso della spatola, la sua osservazione lucida nella precisione anatomica e psicologica dei ritratti.
È un equilibrio sapiente tra partecipazione emotiva e controllo formale, che impedisce alle sue opere di scadere nel patetico e le eleva invece a testimonianze universali della condizione umana.
Marisa Bellini si colloca nella grande tradizione figurativa che da Courbet giunge a Guttuso, ma la reinterpreta con una sensibilità e una tecnica del tutto personali.
Il suo lavoro è un canto polifonico dedicato agli umili, ai dimenticati, a coloro che con le loro vite silenziose e laboriose hanno costruito – e continuano a reggere – il mondo.
In un’epoca di immagini fugaci e identità fluide, la sua pittura ci ancora a una verità primordiale, ricordandoci che la nostra essenza più profonda è inscritta nella terra che calpestiamo e nei volti di chi ci ha preceduto.
Le sue tele non sono finestre su un mondo passato, ma specchi che riflettono la nostra umanità più autentica.
CARLA BERTOLI



L’IDENTITÀ RITRATTA
L’arte di Carla Bertoli è un punto interrogativo che si libra sulla natura del volto in un’epoca di infinita riproducibilità e frammentazione. Carla Bertoli nasce come mosaicista, una tecnica mista che fonde ricerca, cultura, pittura e mosaico moderno.
Carla Bertoli trasforma l’uso di materiali riciclabili in forma artistica, utilizza elementi riciclati con la tecnica del mosaico e li trasforma in elementi pittorici e volumetrici che compongono le parti del supporto in 3D.
La sua espressione artistica non è ritrattistica nel senso classico, ma piuttosto un’indagine critica – una dissezione quasi chirurgica della superficie facciale, intesa non come specchio dell’anima ma come palcoscenico effimero sul quale si rappresenta il complesso dramma dell’identità contemporanea.
Attraverso un linguaggio che fonde l’impatto grafico della Pop Art, l’urgenza emotiva dell’Espressionismo e una vocazione materica altamente personale nutrita da una grammatica di oggetti ritrovati, Bertoli smaschera la maschera, esponendo le dense stratificazioni che costituiscono – e talvolta imprigionano – il nostro senso del sé.
La sua visione si distanzia deliberatamente da ogni tentazione di imitazione, scegliendo invece di raffigurare icone del nostro tempo attraverso le quali svela il tessuto della società contemporanea. Bertoli non è interessata a cogliere la somiglianza, ma a interrogare il fenomeno del volto in quanto costruzione sociale, culturale e psicologica: cosa c’è dietro di esso, e cosa esso rappresenta
Che si tratti di un’icona pop come David Bowie, di un archetipo come il clown, o di un volto anonimo, il suo sguardo non è mai neutro. Funziona come uno strumento di analisi che frammenta, isola dettagli, esalta tensioni cromatiche, lacera la superficie per rivelare lo sforzo sottostante. La sua personalità artistica è quella di un’osservatrice acuta e disincantata della commedia umana, acutamente consapevole della fragilità delle nostre maschere e catturata dalla bellezza dissonante che da esse emerge.
Sul piano stilistico, il lavoro di Bertoli si distingue per una sintesi audace e originale. La base è spesso riconducibile a un’estetica Pop, evidente nell’uso di campiture piatte e antinaturalistiche e di contorni netti che definiscono le forme con precisione grafica, come nel suo ritratto di Marina Abramović.
Eppure questa composizione quasi da poster viene sistematicamente “contaminata” e complicata da interventi diversi che testimoniano la sperimentazione incessante dell’artista nel forgiare il suo idioma peculiare.
In primo luogo, c’è un Espressionismo cromatico e gestuale: il colore a volte cola, si scontra e si mischia impetuosamente, come nel volto del clown, dove il trucco si dissolve in una maschera di dolore liquido. In secondo luogo, l’artista innesta sulla tela elementi eterogenei – frammenti di realtà che irrompono nella finzione pittorica, generando un cortocircuito percettivo e concettuale, manifestazione del suo impulso polimaterico essenziale.
Lo sfondo a mosaico frantumato dietro il volto di Bowie non è una mera decorazione ma una metafora visiva di una celebrità scheggiata in mille riflessi dall’industria culturale e dall’adorazione dei fan. Il trucco sulle guance di Twiggy, famosa modella del passato, diventa un elemento dirompente e potente, come una medicazione, segno di una ferita reale, sulla superficie artificiale del cosmetico, producendo una dissonanza cognitiva che indaga il rapporto tra apparenza e sofferenza, tra cosmetico e cura.
Queste strategie stilistiche ricorrenti servono un più ampio programma di decostruzione.
I tagli compositivi sono spesso estremi, quasi fotografici, isolando il volto dal suo contesto e forzando un confronto intimo, a volte brutale, con l’osservatore. Lo sguardo è un elemento cruciale: quello diretto e asimmetrico di Bowie sfida e interroga, mentre altri volti levano gli occhi al cielo in pose di estasi o supplica, o si volgono di profilo, persi in una dimensione interiore inaccessibile.
Lo spettro cromatico di Bertoli è audace, spesso elettrico: blu glaciali, rossi sanguigni, gialli acidi, neri profondi. Il colore non descrive carnagioni ma stati emotivi; è colore psicologico, che traccia la temperatura dell’anima.
La semiotica dell’opera di Bertoli si focalizza dunque sul tema della maschera e dell’identità come performance. Il clown è l’archetipo più esplicito: il suo volto è un campo di battaglia tra l’allegria richiesta dal ruolo e la tragedia che trapela dalle colature di pigmento. Eppure per Bertoli ogni volto è una maschera. Trucco pesante, pose studiate, persino l’iconicità di un volto famoso – tutte sono forme di mascheramento, ruoli assunti all’interno della società.
Con il suo bisturi pittorico, Bertoli non tenta di strappare la maschera in cerca di un volto “vero” sottostante; piuttosto, ci mostra che l’identità contemporanea è la maschera stessa: un collage instabile di ruoli, immagini, ferite e artifici, tutti sostenuti dall’effimera economia delle immagini consumate in poche ore e valutate in base al numero di like ricevuti più che dai ricordi o dagli ideali che ispirano.
Così Bertoli riesce a trasfigurare la sua sintassi cromatica in una riflessione profonda sulla natura fragile e costruita del nostro essere-nel-mondo. Le emozioni che suscita non sono mai univoche, ma invariabilmente ambivalenti: ammirazione e pietà, fascino e repulsione, glamour e decadenza.
La filosofia che emerge da questa indagine è inconfondibilmente postmoderna. Se l’umanesimo classico vedeva il volto come luogo della verità individuale, Bertoli lo rappresenta come luogo della rappresentazione – e spesso, dell’alienazione. La sua è una visione che abbraccia complessità e contraddizione senza cercare facili sintesi.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è sempre mediato da un lucido intelletto critico; la passione è evidente nel gesto e nel colore, eppure è costantemente governata da un preciso intento analitico. Non c’è abbandono lirico, ma piuttosto una tensione costante tra l’impulso a esprimere e la volontà di proporre significato.
Carla Bertoli è una delle voci più originali e necessarie sulla scena artistica italiana, poiché la sua pratica artistica trascende la ritrattistica per diventare una forma di saggio visivo sull’identità in un’era di dilagante crisi identitaria. Attraverso un linguaggio ibrido che contamina la purezza della pittura con la concretezza dell’oggetto, ci costringe a guardare oltre la superficie levigata delle immagini e a confrontarci con la natura complessa, stratificata e spesso ferita di ciò che chiamiamo “volto”.
Le sue tele ci parlano, rivelando la nostra stessa condizione umana.
PAOLA BRADAMANTE

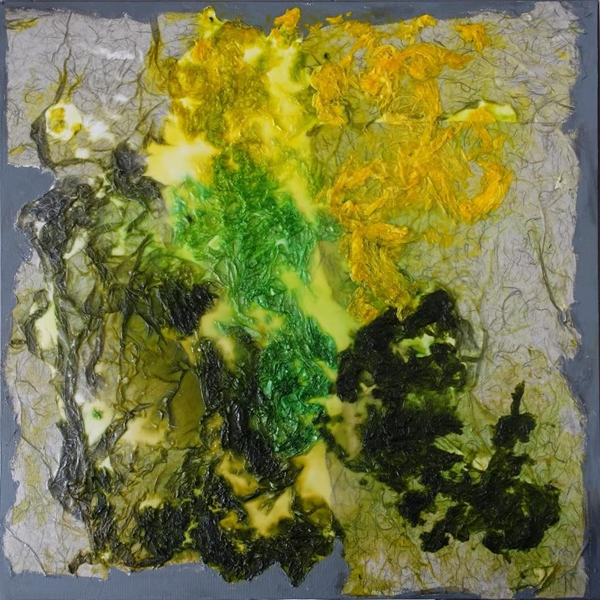
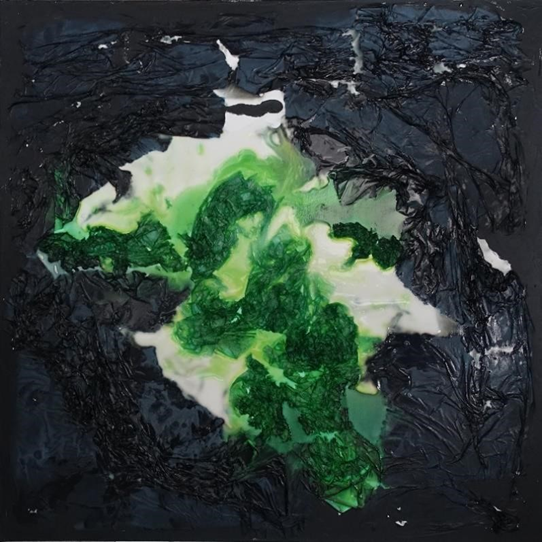
GEOLOGIA DELL’EVENTO
La ricerca artistica di Paola Bradamante non aspira a rappresentare il mondo, ma piuttosto a ricreare, in vitro, sulla superficie della tela, i processi energetici e le dinamiche tettoniche che al mondo danno forma e sostanza stessa.
La sua è un’astrazione che rifiuta l’autoreferenzialità del segno per farsi indagine ontologica: un’immersione audace, viscerale, nelle forze primordiali che governano l’universo.
Ogni sua opera è un tentativo di restituire vita alla nascita dell’universo – non attraverso la produzione di una mera immagine, ma mettendo in scena una narrazione visiva di un evento colto nel momento stesso del suo accadere.
La visione artistica di Bradamante trascende la dicotomia tra figurazione e astrazione, posizionandosi invece in una terza dimensione – quella della “presentazione”.
L’artista non imita la natura ma ne emula i processi generativi, approcciandosi al mondo come una geologa dell’anima, che osserva fratture, eruzioni, sedimentazioni e cristallizzazioni non solo come fenomeni esterni ma come potenti metafore di dinamiche interiori.
La sua personalità, riflessa nel gesto vigoroso e nella complessa stratificazione delle sue opere, è quella di un’artefice che non teme di lottare con la materia – trovando nella sua densità, nella sua resistenza, nella sua imprevedibile reattività la fonte stessa del suo linguaggio.
Sul piano stilistico, siamo nel dominio dell’Art Informel e del matiérisme, una tradizione che da Fautrier e Burri giunge alle più recenti esplorazioni, ma che Bradamante reinterpreta con un rigore compositivo e una sua personale, unica sensibilità cromatica.
La sua tecnica è un processo alchemico, una manipolazione controllata di elementi eterogenei. La superficie pittorica diventa un bassorilievo: impiega impasti densi, quasi cementizi, che modella, incide, corruga, creando una “pelle” pittorica dotata di una propria topografia, di una propria ineludibile fisicità.
A questa epidermide ruvida e opaca si contrappongono spesso aree di colore più fluido, smaltato, o velature traslucide ottenute con resine e altri materiali – generando un dialogo teso e affascinante tra solidità e liquidità, tra opacità della terra e trasparenza della luce o dell’acqua.
In diverse opere si intuisce l’incorporazione di materiali recuperati o sperimentali – carte accartocciate, membrane tessili – non semplicemente applicati, ma sommersi nel pigmento, divenendo parte integrante e strutturale dell’opera stessa.
I suoi tratti stilistici ricorrenti definiscono una sintassi visiva di grande coerenza e forza. La struttura compositiva di molte opere si fonda su una dialettica fondamentale, quasi archetipica: una massa scura, pesante – prevalentemente nera o blu notte – occupa la parte inferiore della tela.
È un fondamento ctonio, la rappresentazione della materia primordiale, indifferenziata, il caos o l’abisso tellurico.
Da questa oscurità – o contro di essa – irrompe l’evento cromatico: un’esplosione di colore puro che prorompe, si espande, lacera la superficie. Non è un colore che riempie una forma, ma una forza che crea la forma con la sua stessa manifestazione.
Il verde non è un prato, ma l’energia della vegetazione, la forza tellurica che si erge.
Il giallo e l’arancio sono energie vitali, nuclei di potenza solare o vulcanica che si liberano da un contenimento oscuro.
Nel suo dittico, dalle potenti falcate di blu e bianco, la dinamica cambia: non più verticale ed eruttiva, ma vorticosa, ciclonica. È l’energia dell’acqua o dell’aria, un confluire di forze che spiraleggiano su se stesse in moto perpetuo.
La semiotica di questa pittura è dunque radicata negli elementi primari dell’esistenza. Paola Bradamante non narra storie, ma mette in scena forze pure. Lo spettatore è posto davanti a un dramma senza attori umani: il dramma della creazione stessa.
Ella riesce a trasfigurare la materia – pigmento, gesso, carta – in un processo vivente, rivelando l’essenza del reale come incessante trasformazione.
Le emozioni che le sue opere suscitano non sono legate all’aneddoto ma più profonde, quasi fisiologiche: si sente la tensione, la pressione, la frattura, il rilascio di energia.
È un’arte che parla un linguaggio preverbale, connettendosi direttamente con la nostra memoria ancestrale dei grandi fenomeni naturali.
La filosofia che sottende questa pratica è una forma di naturalismo astratto, un panteismo materiale che colloca il sacro non in una dimensione trascendente ma nell’immanenza della materia e delle sue leggi. La visione della vita di Bradamante è dinamica, conflittuale, ma infine generativa.
Ogni sua opera è la rappresentazione di una crisi che conduce a una nuova forma, di un caos che si cristallizza in ordine.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è mediato dalla fisicità del gesto: la passione dell’artista non è illustrata ma inscritta direttamente nella violenza controllata con cui aggredisce e modella la superficie.
La sua osservazione lucida, al contrario, si manifesta nell’impeccabile equilibrio delle composizioni, nella maestria con cui gestisce pesi, vuoti, volumi e contrasti cromatici.
L’espressione artistica di Paola Bradamante esalta la capacità di unire la sperimentazione materica a un profondo senso della forma e della struttura.
La sua è un’arte severa ma sontuosa, che invita a guardare oltre la superficie delle cose per contemplare le forze invisibili che le animano. Le sue tele non sono oggetti da osservare a distanza, ma campi di energia che ci attraggono, ci interrogano, ci ricordano la nostra stessa natura di esseri fatti della stessa materia stellare e tellurica che vediamo lottare, e trovare pace, dentro i suoi dipinti.
La pittura di Bradamante non ha bisogno di parole per spiegarsi, perché parla il linguaggio universale e primordiale della creazione.
DANIELA BUSSOLINO



LE SCENE DELL’ANIMA
L’universo artistico di Daniela Bussolino non è un mondo ma un palcoscenico, sul quale ciascuna delle sue opere – sia essa dipinta con la densità degli acrilici, tracciata con la delicatezza della matita, o composta attraverso pixel digitali – si presenta come una scena tratta da un dramma o un poema non scritto, un fotogramma sospeso che allude insieme a un prima e a un dopo.
Analizzare la sua espressione artistica significa accedere al repertorio di una regista dell’anima, di un’artefice che non si vuole confinare in un unico linguaggio, ma modula stili e tecniche con un’espressività poliedrica per dar voce ai registri diversi, e a volte contraddittori, dell’esperienza femminile.
La sua pittura, e più in generale la sua arte, è un atto di narrazione per frammenti, una polifonia visiva la cui coerenza risiede nella costante e appassionata esplorazione della grazia, della solitudine e della forza interiore.
Bussolino interpreta la realtà non come un dato oggettivo da replicare, ma come un’eco emotiva da mettere in scena. Il suo approccio al mondo è teatrale, guidato dalla percezione e saturo d’emozione.
Le sue figure sono quasi sempre protagoniste isolate, o assorbite in un dialogo coreografico, colte in un momento di rivelazione, attesa o celebrazione.
È qui che emerge la sua doppia natura di pittrice e scrittrice, poiché la sua mano non si limita a descrivere ma evoca, suggerisce, narra, costruisce un’atmosfera densa di potenziale narrativo.
La donna in rosso, avvolta in un nimbo di luce angelica, non è semplicemente una figura col calice ma un’eroina tragica, una moderna Medea sospesa tra perdizione e redenzione, il cui dramma interiore si materializza nel vortice di pennellate che la circondano.
Sul piano stilistico, l’artista dimostra una versatilità notevole e coraggiosa, che è la chiave di volta per comprendere l’intera sua ricerca.
Daniela Bussolino non è un’artista legata a un solo stile, ma una sperimentatrice che adatta medium e maniera alla storia che intende svelare.
Nella sua produzione pittorica si possono identificare almeno tre registri principali.
Il primo è un Espressionismo drammatico, caratterizzato da un cromatismo audace, un chiaroscuro teatrale e una pennellata energetica, tattile.
A questa vena appartengono opere come la ballerina sulle punte o la già citata dama in rosso, dove il colore – soprattutto il rosso, significante di vita e pericolo – diventa il protagonista emotivo della scena.
Il secondo registro è una sintesi lirica, quasi musicale, che richiama certe eleganze moderniste.
Le danzatrici stilizzate su fondo arancio ne sono l’esempio perfetto. Qui l’anatomia si astrae, i volti scompaiono, la figura si trasforma in un ideogramma di pura grazia e movimento. La linea diventa essenziale, il colore è steso in campiture piatte e vibranti.
Non è più il dramma dell’individuo a essere messo in scena, ma la gioia di un ritmo collettivo, un’ode alla leggerezza e alla fratellanza. Anche le tre danzatrici in abiti dai colori primari su fondo nero partecipano di questa logica, seppure con una maggiore ricchezza materica nel panneggio.
Infine, emerge un terzo registro: quello del realismo poetico.
Il ritratto della fanciulla incoronata di fiori svela un’altra mano, capace di estrema delicatezza e di un’indagine psicologica profonda. Qui la pittura a olio cede il passo al disegno, alla grafite, forse alla sanguigna. Il tumulto espressionista tace per lasciare spazio a una quiete contemplativa. In quest’opera si intravede un ponte diretto con l’altra sé dell’artista, la scrittrice di tenere favole come Un Amore a Quattro Zampette.
C’è la stessa innocenza, la stessa attenzione alla purezza e alla delicatezza che, pur meno appariscenti, costituiscono chiaramente un nucleo fondamentale della sua sensibilità.
Questi diversi modi espressivi non sono segno di incertezza ma di una ricchezza e libertà non comuni. Attestano un’artista che pensa come una regista, selezionando l’inquadratura, l’illuminazione, lo stile di recitazione più adatti alla scena.
La sua recente esplorazione della Digital Art non è altro che il naturale proseguimento di questo approccio, una nuova cassetta degli attrezzi con cui continuare a narrare storie, forse attraverso linguaggi ancora altri.
La semiotica delle opere di Bussolino è complessa e stratificata. La figura femminile è il suo soggetto quasi ossessivo, ma non è mai un oggetto passivo di contemplazione; è invece sempre un soggetto attivo, anche nella sua immobilità.
Il motivo ricorrente della figura vista di spalle (come nella donna in bianco seduta su un drappo blu) è una scelta semiotica potente, perché nega allo spettatore l’accesso all’espressione facciale e allo sguardo psicologico, trasformando la figura in uno schermo su cui proiettare le proprie emozioni e narrazioni.
Quella schiena nuda diventa un paesaggio, un territorio di vulnerabilità e forza insieme.
La filosofia che sorregge la sua opera è una profonda esplorazione dell’universo femminile, colto nelle sue dualità: forza e fragilità, esuberanza e malinconia, solitudine e comunità.
La sua è una visione della vita che riconosce ed esalta la complessità. Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è diretto, viscerale, ma sempre governato da un’eleganza formale che impedisce alla passione di dissolversi nel disordine.
La sua osservazione lucida si traduce nella precisione del gesto, nell’equilibrio delle composizioni – anche le più dinamiche.
Daniela Bussolino è un’artista completa, una narratrice che si esprime attraverso una pluralità di linguaggi.
La sua espressione pittorica è un teatro affascinante in cui ogni tela è un atto unico, capace di passare dai toni della tragedia a quelli della commedia, dal dramma psicologico al balletto lirico, fino alla favola delicata. La sua forza non sta in una formula ma nella capacità di reinventarsi continuamente, spinta dall’urgenza di concedere a ogni emozione, a ogni storia, la sua forma e il suo colore più autentici.
Il suo percorso, arricchito dalla scrittura e ora dalla sperimentazione digitale, si annuncia come un viaggio continuo attraverso le infinite scene del teatro umano – di cui lei è, a tutti gli effetti, una delle interpreti più sensibili e poliedriche del nostro tempo.
FEDRA – FRANCESCA CALZONI


L’ALCHIMIA DELLA SUPERFICIE
L’arte di Francesca Calzoni, in arte Fedra, è una raffinata e multiforme indagine sulla dialettica tra superficie e sostanza, tra gesto decorativo e persistenza dell’archetipo.
La sua non è un’arte che si lascia confinare entro i limiti di una singola disciplina o di uno schema predeterminato; piuttosto, costituisce un ecosistema creativo in cui pittura, mosaico e arte applicata intrattengono un dialogo costante, generando un linguaggio al contempo antico ed estremamente contemporaneo – al di là delle mode, al di là degli stereotipi.
Fedra non sceglie un medium, ma un’intenzione: quella di trasfigurare la materia – che sia tessera vitrea, pigmento, tessuto o supporto metallico – in una epifania di bellezza tattile e visiva, un ponte tra lo spazio dell’arte e lo spazio del vivere.
La sua visione artistica interpreta la realtà non come un repertorio di soggetti da imitare, ma come una grammatica di forme da stilizzare e trasporre in un ordine superiore, quasi musicale.
Il suo approccio al mondo è quello di un esteta nel senso più nobile del termine, erede di quella tradizione che, da William Morris all’Art Nouveau, ha cercato di smantellare la barriera tra arti “maggiori” e “minori”.
La sua personalità artistica si manifesta nella vocazione a creare oggetti non solo da contemplare, ma da abitare; così, un paravento dipinto non è una tela forzata in una funzione, ma un dipinto che diventa architettura, una cortina che si trasforma in una cascata di luce e colore.
Nel suo lavoro c’è un profondo rispetto per l’artigianalità, intesa come processo meditativo attraverso cui l’idea prende forma e l’oggetto acquista un’anima.
Sul piano stilistico, la sua produzione è un crocevia di influenze colte, reinterpretate attraverso una sensibilità inconfondibile. L’eco del Simbolismo e del Decadentismo risuona nella scelta di soggetti come la rosa nera, archetipo di una bellezza assoluta e misteriosa, la cui silhouette scura e materna si staglia su un fondo in foglia di rame che evoca la sacralità delle icone bizantine.
La linea bianca che ne definisce i contorni, nitida e grafica, è un gesto moderno che dialoga con l’antica preziosità del fondo.
In opere come questa, Fedra dimostra una piena padronanza del contrasto: tra opaco e lucido, tra nero profondo e luce metallica, tra forma stilizzata e ricchezza interiore del colore, che all’interno della rosa si accende con insospettate venature azzurre.
Altrove, particolarmente nelle sue creazioni tessili, emerge una chiara fascinazione per il Giapponismo e la sinuosa eleganza dell’Art Nouveau.
I rami di salice piangente e i viticci di vite che si dispiegano su fondi rosa antico o oltremare non sono resi con intento naturalistico, ma tradotti in un arabesco calligrafico. Qui la linea diventa serpentina, fluida, contenente il colore secondo una logica che ricorda il cloisonné o il batik.
Il supporto tessile non è un compromesso ma una scelta programmatica: la sua leggerezza, la dimensione traslucida e la capacità di muoversi e interagire con la luce e l’aria conferiscono a queste opere una qualità eterea e dinamica, trasformandole in “dipinti nomadi” che ridisegnano lo spazio che occupano.
La pratica del mosaico costituisce un altro pilastro fondamentale della sua ricerca, dove l’approccio dell’artista cambia registro: la fluidità della linea cede il passo alla paziente costruzione dell’immagine attraverso il frammento.
Il suo albero autunnale non è una visione istantanea ma un tempo lento, accumulato. Ogni tessera è una sillaba di un complesso discorso visivo; l’effetto quasi puntinista del fogliame e del cielo, vibrante di luce, rivela come Fedra impieghi questa tecnica antica non per creare immagini statiche e ieratiche, ma per catturare la fugacità di un istante – la caduta di una foglia, il tremore della luce.
È un affascinante paradosso: utilizzare uno dei media più duraturi e “pesanti” per esprimere leggerezza e transienza.
I suoi ricorrenti tratti stilistici distintivi sono dunque un amore per la linea definita e sinuosa, una predilezione per motivi tratti dal regno vegetale – fiori e alberi – e una palette che spazia dai toni preziosi di metalli come oro, rame e argento a tinte più delicate e arcaiche come i rosa polverosi e i blu profondi.
Eppure, forse l’elemento più distintivo è la sua ossessione per la superficie. Che sia la ruvidezza granulare di un impasto materico, la fredda levigatezza della foglia metallica, la luminosa vibrazione del mosaico o la morbidezza del tessuto, la pelle dell’opera è per Fedra un campo primario di esperienza sensoriale.
La semiotica del suo lavoro risiede proprio in questa celebrazione della materia trasfigurata. Il messaggio non è proclamato, ma sussurrato attraverso la squisitezza della fattura. Fedra ci invita a riscoprire il valore della bellezza come nutrimento per lo spirito. La sua arte non cerca di scandalizzare o denunciare, ma di incantare, offrendo un rifugio dalla volgarità e dalla fretta del mondo contemporaneo.
Lei riesce a trasformare la materia in un talismano, un oggetto dotato di un’aura che arricchisce sia l’ambiente che chi lo abita. L’emozione che cerca di trasmettere è quella della meraviglia, della contemplazione silenziosa, del piacere estetico inteso come forma di conoscenza.
La filosofia che anima la sua arte è una forma di panteismo estetico: la convinzione che una scintilla del divino risieda nella perfezione di una forma naturale, e che il compito dell’artista sia rivelarla e celebrarla attraverso un atto di devozione artigianale.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è mediato da un filtro di eleganza e controllo formale. La passione è presente, ma è una passione distillata, interiorizzata, espressa nella meticolosa cura del dettaglio, nell’infinita pazienza richiesta dal mosaico, nella grazia del gesto pittorico.
Fedra è un’artista che naviga con rara maestria tra le correnti dell’arte, del design e dell’alto artigianato, trascendendone le distinzioni in nome di un ideale di bellezza integrata.
Il suo lavoro è un antidoto alla dematerializzazione dell’arte e alla banalità del quotidiano. Fedra ci invita non solo a guardare, ma a toccare, ad abitare la sua arte, riscoprendovi la possibilità di un’esistenza trasfigurata dalla bellezza e dalla silenziosa poesia della materia.
SABRINA CERUTI


ANATOMIA DELL’ANIMA
L’espressione artistica di Sabrina Ceruti si impone all’attenzione critica come una meditazione profonda e coerente sulla dualità dell’essere, esplorata attraverso l’icona quasi ossessiva della figura femminile immortalata di spalle, in una indagine che non è un esercizio di anatomia, né una mera celebrazione del nudo, quanto piuttosto un’investigazione ermeneutica che utilizza il corpo come sismografo dell’anima, un paesaggio su cui tracciare le complesse e variegate geografie dell’interiorità.
Ogni tela è una dichiarazione perentoria: il vero volto dell’emozione non si trova sul viso, ma nell’energia che irraggia dalla materia.
La visione di Ceruti attua una divisione fondamentale, una dicotomia visiva che è al contempo una dichiarazione filosofica.
Lei interpreta la realtà separando in modo netto lo spazio interiore – il Sé – dallo spazio esteriore – il mondo.
Il suo approccio alla vita, riflesso in questa scelta radicale, sembra suggerire che l’essenza dell’individuo sia un universo cromatico, energetico e turbolento, contenuto in un involucro che si confronta con un contesto esterno spesso neutro, freddo, quasi astratto.
La personalità artistica di Ceruti è quella di una creatrice dalla doppia natura: un’espressionista selvaggia, quasi da arte fauve, nella resa dell’anima, eppure una rigorosa minimalista nella messa in scena di questo dramma interiore.
Sul piano stilistico, questo dualismo si traduce in un linguaggio pittorico inconfondibile e dirompente. Da un lato c’è il corpo – quasi sempre l’unica forma organica sulla tela – non trattato con verismo mimetico, ma trasformato in un supporto per un’esplosione di puro colore, steso con pennellate dense, tattili, a volte quasi violente.
La sua tecnica evoca una sorta di tassellatura cromatica, in cui macchie di rosso, blu, giallo, verde e arancione si accostano senza fondersi, creando una superficie vibrante che nega la levigatezza della pelle per rivelarne l’intensità emotiva.
È un corpo composto di puro sentire, un mosaico di stati d’animo coesistenti simultaneamente.
Opposta a questa detonazione cromatica c’è lo sfondo, il palcoscenico su cui la figura si staglia, dove il registro cambia totalmente, poiché Ceruti predilige superfici monocrome o bitonali, dominate da grigi, argenti e bianchi sporchi. La pennellata si appiattisce, la materia si fa più rarefatta, arricchita in modo significativo da inserti in foglia d’argento, che conferiscono allo sfondo una qualità preziosa ma fredda – una luce quasi lunare, senza tempo.
L’artista costruisce così uno spazio astratto, un non-luogo che isola la figura e ne amplifica la presenza, trasfigurandola in un’icona moderna sospesa tra corporeità e simbolo.
Le opere in bianco e nero rappresentano una variazione cruciale all’interno di questo sistema. Privando la scena del colore, l’artista ci costringe a focalizzarci sulla forma, sulla postura, sulla linea. E proprio in questa assenza, il singolo, minuto dettaglio del piccolo cuore rosso alla nuca emerge come elemento di straordinaria potenza – il fulcro emotivo dell’intera composizione.
Queste opere confermano il principio per cui il colore, nelle altre tele, non è un abbellimento decorativo, ma il vero soggetto del discorso. I tratti stilistici ricorrenti diventano dunque segni potenti.
La scelta di raffigurare la donna quasi sempre di spalle è un atto semiotico di primaria importanza, poiché nega allo spettatore l’accesso al volto, sede tradizionale dell’identità e della psicologia, imponendo invece una modalità di lettura diversa – più profonda, più complessa da decifrare.
La schiena diventa il vero volto dell’anima. La colonna vertebrale, spesso evidenziata dalla luce e dalla composizione, si trasforma nella struttura assiale non solo del corpo ma della sua energia. I capelli raccolti in uno chignon scoprono la nuca – luogo di vulnerabilità e sensualità, ma anche di concentrazione e forza interiore.
Il messaggio che emana da questa configurazione è un’esaltazione dell’invisibile reso visibile.
Sabrina Ceruti ci dice che la nostra vera identità, la nostra ricchezza, la nostra complessità, non risiedono nell’immagine che presentiamo al mondo, ma nell’incandescente magma di emozioni, pensieri e sensazioni che ci abita.
L’artista riesce a trasformare gli impasti cromatici in un’allegoria della condizione umana, in un’immanenza della vita narrata attraverso la sua irriducibile e caotica vitalità.
Lo sfondo argentato è la trascendenza – o forse la fredda neutralità del cosmo, la solitudine esistenziale in cui ogni individuo è immerso. La filosofia che anima la produzione dell’artista è un umanesimo radicale e introspettivo.
La visione della vita di Ceruti è quella in cui la vera arena risiede all’interno.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di totale e bruciante coincidenza: l’arte non descrive l’emozione; piuttosto, l’emozione diventa colore e forma.
La sua passione si traduce nel gesto febbrile con cui costruisce i suoi corpi vibranti, la sua lucida osservazione, d’altro canto, si rivela nel rigore quasi ascetico della composizione, nel perfetto equilibrio tra figura e sfondo, nel controllo magistrale di una palette che, pur esplosiva, non cade mai nel caos.
Sabrina Ceruti ha forgiato un linguaggio visivo di rara potenza e coerenza, un archetipo contemporaneo di straordinaria forza evocativa.
Le sue donne viste di spalle non sono ritratti ma universi, icone silenziose che ci invitano a distogliere lo sguardo dalla superficie delle apparenze per contemplare l’abbagliante complessità del nostro mondo interiore.
Sono un invito a scendere in profondità, ad afferrare l’essenza.
La sua pittura è un atto di coraggio, che ci mostra che per conoscerci veramente dobbiamo avere la forza di voltare le spalle al mondo e guardarci dentro – lì, dove risiede la nostra vera natura incandescente e iridescente.
DAVIDE CUPOLA
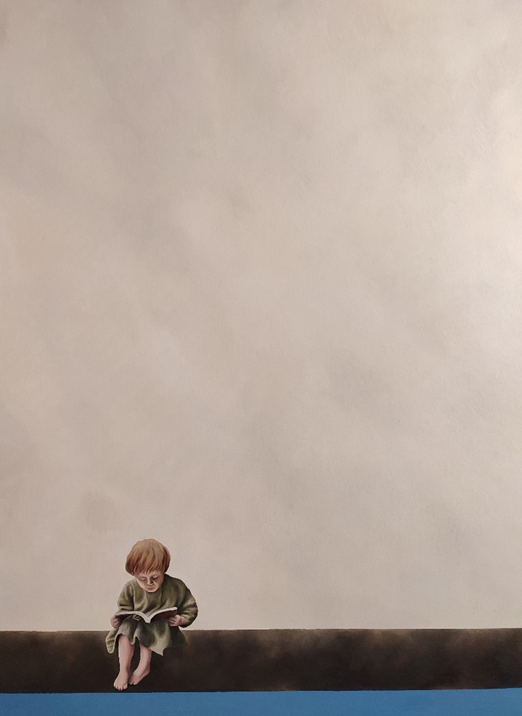

TEATRI DELL’ESSERE
L’espressione artistica di Davide Cupola non è pittura, ma una vera e propria ontologia visiva, per cui ogni tela è un’ipotesi filosofica, articolata con il rigore di un trattato e l’ammaliante, silenziosa eloquenza di una visione.
Ci troviamo di fronte a un artista che trascende la mera rappresentazione visiva per farsi vero filosofo del nostro tempo, un pensatore che impugna il pennello come strumento d’indagine esistenziale.
I suoi dipinti sono teatri dell’essere: vaste distese acromatiche evocano insieme la tabula rasa della coscienza e il vuoto indifferente del cosmo. Al loro interno, figure solitarie inscenano drammi tanto più potenti nella loro quiete e nella loro assenza di narrazione esplicita.
La visione artistica di Cupola interpreta la realtà come un palcoscenico metafisico, con un approccio che non è riprodurre il visibile, ma estrarne l’invisibile essenza della condizione umana, ponendo interrogativi fondamentali attraverso allegorie visive di disarmante purezza.
La sua personalità artistica è quella di un asceta, di un osservatore che ha distillato la passione in una lucidità quasi tagliente. Nelle sue opere non c’è traccia di sentimentalismo; piuttosto, vi si trova una profonda forma di empatia, una pietas intellettuale verso la creatura umana, colta nella sua irriducibile solitudine e nella sua caparbia, commovente ricerca di senso.
Sul piano stilistico, Cupola ha forgiato un linguaggio di assoluta coerenza e riconoscibilità – che potremmo definire “Realismo Concettuale” o “Realismo Metafisico”.
La sua tecnica si fonda su una dialettica radicale. Le figure umane sono rese con una padronanza quasi iperrealista, con una precisione fiamminga nella delineazione del dettaglio anatomico, delle pieghe del tessuto, del gioco di luce sulla pelle.
Questa concretezza quasi tattile del corpo – la sua presenza innegabile nel mondo – viene sistematicamente decontestualizzata e posta in dialogo con fondali astratti, superfici minimaliste, spesso monocrome e materiche, che negano qualsiasi riferimento a un tempo o a un luogo specifici. Questo contrasto non è un espediente estetico, ma il fulcro della sua indagine filosofica: l’essere concreto, finito, dell’individuo, gettato in un’esistenza astratta, infinita, senza coordinate.
I suoi tratti stilistici ricorrenti costituiscono gli elementi di una precisa sintassi filosofica, dove il vuoto – il vasto spazio negativo che circonda le sue figure – non è assenza ma presenza carica di significato. È il silenzio del cosmo, la pagina bianca su cui ogni vita deve iscrivere la propria storia.
All’interno di questo vuoto, irrompono pure forme geometriche: quadrati, rettangoli, piani trapezoidali.
Questi non sono motivi decorativi ma intrusioni platoniche, simboli di ordine, di legge, di costrutto umano – che sia gioco, dogma, prigione o utopia – imposti al flusso indifferenziato dell’esistenza.
Il bambino che pesca seduto su un quadrato rosso non è solo al gioco, ma attinge la sua immaginazione (il pesce azzurro) da una realtà artificiale, da un mondo definito e delimitato dall’uomo.
Il soldato che avanza verso un rettangolo blu all’orizzonte non marcia verso una meta, ma verso un’astrazione: il dovere, la pace, la morte, il nulla.
La semiotica di Cupola è un sistema complesso e stratificato che indaga le tappe della vita umana e le sue strategie di sopravvivenza ontologica. L’infanzia è il tempo della creazione del mondo. La bambina che costruisce con cubi azzurri sopra un plinto grigio non sta semplicemente giocando, ma esercita il potere demiurgico della mente, imponendo ordine e significato a uno spazio altrimenti informe. Il ragazzo nero con il mantello da supereroe incarna la potenza dell’immaginazione come strumento di trascendenza, la capacità di proiettarsi oltre la propria condizione, di sognare un potere e una libertà che la realtà potrebbe ben negare.
Per Cupola, sognare è vivere pienamente.
L’età adulta e la vecchiaia, al contrario, sono rappresentate come il tempo della consapevolezza, del peso della storia e della vulnerabilità.
Il profilo dell’uomo rugoso che si dissolve nel buio non è un ritratto ma la personificazione della memoria, del dolore, della mortalità – la carne che si fa archivio del tempo vissuto.
La ragazza scalza in primo piano è un’immagine di vertiginosa potenza, che esprime lo sforzo, la precarietà dell’aggrapparsi alla trave dell’esistenza – la nostra condizione di esseri perpetuamente in equilibrio, vista in una prospettiva che sottolinea insieme la gravità e la fatica.
La donna che fluttua su un catafalco azzurro è forse l’immagine più enigmatica e commovente: un’Ofelia moderna, sospesa tra il sonno e la morte, contenuta in uno spazio sacro, acquatico, che è ancora una volta un costrutto geometrico – una zattera, una tomba, un portale verso un’altra dimensione.
La filosofia che emerge da questa ricerca è una forma di Esistenzialismo stoico e profondamente umanista.
Cupola contempla la condizione umana post-nichilista: in un universo che non offre più garanzie né significati prestabiliti, l’individuo è insieme condannato e benedetto dalla libertà di creare senso.
Le sue opere non sono pessimistiche; al contrario, sono una celebrazione della resilienza dello spirito umano, della sua inesauribile capacità di giocare, sognare, leggere, lottare e aggrapparsi alla vita – persino di fronte all’assoluto silenzio del vuoto circostante.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è intellettuale e distillato.
La passione non erompe in un urlo di colore o in un gesto violento, ma nella tensione quasi insopportabile tra la figura vulnerabile e l’immenso vuoto; nella devozione ossessiva, quasi monastica, con cui l’artista rende ogni dettaglio, atto d’amore per la concretezza dell’essere individuale.
Davide Cupola è una delle menti più lucide e originali dell’arte contemporanea.
Le sue opere sono parabole visive per il nostro tempo, icone di un pensiero critico che riscopre il sacro nella solitudine e nella fragilità dell’esistenza.
Guardare uno dei suoi dipinti significa essere costretti al silenzio interiore, a confrontarsi con le domande ultime che raramente osiamo porci.
In un mondo assordato dal rumore e saturo di immagini insignificanti, l’arte di Cupola è un necessario, potente inno al silenzio, al vuoto, e alla piccola, immensa figura umana che lo abita.
TERESA DE SIO

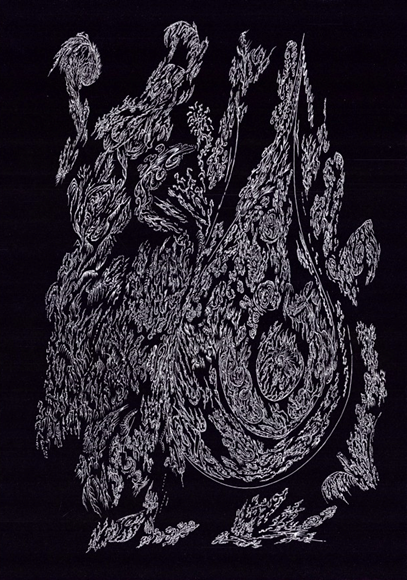
SISMOGRAFIA DEL SEGNO
L’arte di Teresa De Sio è una sismografia dell’anima.
Non è disegno nel senso convenzionale del termine, inteso come rappresentazione del mondo esterno, quanto piuttosto un atto di pura estroflessione, una traduzione diretta – quasi brutale nella sua onestà – di un’energia interiore che preme, vibra, ed infine erompe sulla superficie del foglio.
Ci troviamo di fronte a un’artista che ha trasformato la linea in un linguaggio primordiale, in un codice genetico dell’emozione, dando vita a un universo visivo insieme ossessivamente controllato e ferocemente libero.
Tutto si compie attraverso una visione singolare e un linguaggio del tutto originale. Ciascuna sua opera è la cronaca di una conflagrazione interiore, la traccia febbrile di ciò che brucia sotto la pelle della coscienza.
La visione artistica di De Sio sfugge completamente alla mimesi per abbracciare un approccio che si potrebbe definire “energetico-creazionista”.
La realtà per lei non è un repertorio di forme da copiare, ma un magma incandescente di forze da liberare.
Il suo atteggiamento verso la vita e il mondo è quello di un medium, che convoglia – attraverso il gesto ossessivo della mano – le correnti invisibili del suo paesaggio psichico.
La sua personalità, riflessa in questa pratica quasi rituale, è quella di un’asceta della passione: la sua non è un’esplosione caotica, ma un’eruzione vulcanica incanalata in percorsi di una complessità e precisione quasi inimmaginabili.
C’è una lucida follia nel suo lavoro, una paradossale coesistenza di abbandono totale e controllo maniacale.
Stile e tecnica sono la chiave di volta per accedere a questo universo.
Il suo strumento è la linea, quasi sempre tracciata a penna, che non ammette pentimenti.
È una linea che non delinea contorni ma costituisce essa stessa la materia dell’immagine attraverso l’accumulo parossistico.
La sua tecnica è una forma di scrittura automatica elevata a sistema, dove il tratto è nervoso, rapido, ripetuto all’infinito fino a generare scabrosità, volume, ombra e vibrazione ottica.
Da vicino, si osserva un groviglio di filamenti energetici; da lontano, questi filamenti si compattano in forme organiche, vortici cosmici, archetipi che sembrano emergere spontaneamente dal caos.
È un’arte costruita per sedimentazione, dove il tempo del fare diventa parte integrante e visibile dell’opera finita.
I particolarismi stilistici ricorrenti funzionano come ideogrammi di questo linguaggio profondamente personale, in cui il vortice – la spirale – è forse l’archetipo più potente e pervasivo.
Non è un mero motivo decorativo, ma il nucleo generativo dell’opera, il buco nero da cui l’energia prorompe o in cui viene risucchiata.
Rappresenta l’origine, l’inconscio, il nucleo incandescente dell’essere.
Attorno a questi centri di gravità, la linea si organizza in pattern che evocano strutture naturali su scale diverse: dalla delicatezza di un piumaggio alla durezza di una cristallizzazione, dall’intricatezza di una rete neuronale alla struttura frattale di una felce.
Spesso, da questa trama astratta, emergono figure per pareidolia: il profilo di un leone ruggente, la sagoma di un volto umano, la forma di un cuore.
Queste apparizioni non sono programmate, ma diventano l’esito inevitabile di un’energia che, accumulandosi, non può non assumere una forma riconoscibile, come se cercasse un nome per la propria urgenza.
La palette è prevalentemente acromatica: il nero dell’inchiostro, il bianco o l’ocra della carta, concentrando tutta l’attenzione sulla dinamica del segno. Quando il colore fa capolino – come il giallo elettrico di un fondo, o i sottili filamenti rossi e blu in un volto – è un evento, un’alterazione dello stato emotivo, una febbre improvvisa che interrompe il flusso della normalità.
L’opera in negativo, bianco su nero, è un’accecante inversione cosmica, dove non è più l’energia a iscriversi sul vuoto, ma la luce stessa ad essere estratta dall’oscurità.
La semiotica di Teresa De Sio è complessa perché non si basa su un codice condiviso di simboli, ma sulla trasmissione diretta di uno stato pre-verbale.
Il messaggio non è ciò che l’opera rappresenta, ma come l’opera è stata fatta, l’energia che essa incarna.
L’artista non cerca di raccontarci una storia; vuole farci sentire una frequenza.
L’emozione che trasmette è quella della tensione estrema, dell’energia compressa che fatica a trovare forma, di una bellezza nata da un processo quasi doloroso nella sua intensità.De Sio riesce a trasformare il materiale più semplice – inchiostro su carta – in un organismo vivente, pulsante, rivelando l’essenza della realtà non nel suo aspetto statico, ma nel suo incessante, vibrante divenire.
La filosofia che sottende questa ricerca è una forma di vitalismo radicale.
La sua visione della vita è quella di un flusso continuo di energia che deve esprimersi pena l’implosione.
L’arte diventa una necessità biologica, un apparato respiratorio dell’anima. Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di trasparenza assoluta, quasi terrificante. Non c’è mediazione, non c’è filtro intellettuale. La passione bruciante si traduce direttamente nella densità maniacale del tratto. La sua lucidità, d’altro canto, si manifesta nella straordinaria intelligenza compositiva, nella capacità di orchestrare questo caos apparente in equilibri dinamici di straordinaria eleganza, impedendo al magma di traboccare incontrollato.
Teresa De Sio è una creatrice unica nel panorama contemporaneo, un’artista che ha avuto il coraggio di forgiare un linguaggio che è l’impronta digitale della sua anima – dunque, un linguaggio davvero unico.
Le sue opere non sono immagini da guardare, ma campi di forza da esperire. Ci costringono a una modalità diversa di visione, a sentire piuttosto che a capire, a percepire il vertigine di un’interiorità che si fa paesaggio.
In un’epoca dominata dalla freddezza del concetto e dalla riproducibilità dell’immagine, la sua ostinata, febbrile, quasi anacronistica fede nel gesto della mano come sismografo del cuore costituisce un atto di resistenza di una potenza e di una bellezza travolgenti.
FARG²


FARG², SINTESI DI ORDINE E CAOS
La proposta artistica di Farg², progetto nato dalla fusione simbiotica di Alessandro Rinaldoni e Francesca Ghidini, non è una mera collaborazione ma un’alchimia, una figura di Giano che guarda simultaneamente negli abissi liquidi dell’inconscio e verso le architetture cristalline del mito.
Ciascuna loro tela è insieme un campo di battaglia e una camera nuziale, il luogo sacro e violento in cui due forze cosmiche primordiali – il caos generativo e il logos ordinatore – si scontrano, si fecondano a vicenda, e danno infine vita a un linguaggio visivo di un’originalità e densità concettuale quasi senza precedenti.
Analizzare Farg² significa assistere, in tempo reale, alla genesi di un cosmo, all’atto stesso con cui la forma emerge dal magma informe, con cui la storia si iscrive sulla superficie del flusso primordiale.
Per Farg² la realtà non è un dato statico ma un incessante processo di emersione; così, in questa visione, si rivela la perfetta complementarità dell’anima duale del progetto.
Alessandro Rinaldoni agisce come un rabdomante dell’inconscio: la sua arte liquida, misteriosa, prepara il campo, evoca il caos, la prima materia dell’esistenza.
I suoi fondi, creati con tecniche di pittura fluida, non sono sfondi ma dimensioni – nebulose cromatiche, membrane cellulari, correnti abissali, la rappresentazione visiva di quel flusso preverbale e prerazionale che Jung avrebbe chiamato “inconscio collettivo”.
Su questo palcoscenico magmatico interviene Francesca Ghidini, che agisce come una mitografa, un’ordinatrice del sacro.
La sua arte, che attinge al repertorio della fiaba, del tribale e a una profonda indagine sul femminile, non impone un ordine arbitrario ma ascolta il caos sottostante e ne fa emergere le forme latenti.
Il suo gesto è maieutico, poiché aiuta il mondo a nascere, tracciando i contorni di creature, archetipi e storie che già dormivano nel colore liquido.
Sul piano stilistico, questa fusione si traduce in una tecnica a due fasi divenuta la loro inconfondibile firma. La prima fase è dominata dall’aleatorietà controllata: Rinaldoni orchestra la danza dei pigmenti fluidi, lasciando interagire il caso e la chimica nella creazione di universi cromatici unici e irripetibili.
È un processo di abbandono, di immersione. La seconda fase è un atto di pura volontà e precisione quasi maniacale: Ghidini interviene su questa superficie organica e imprevedibile con un bisturi grafico.
Maneggia la linea – spesso nera, bianca o metallica – per definire, circoscrivere, narrare. Le sue figure – sirene, fate, amanti, farfalle – e i suoi intricati pattern, a volte reminiscenze di incisioni rupestri o dell’ornamentazione dell’Art Nouveau, non galleggiano sopra il fondo ma vi sono indissolubilmente legati.
La linea segue le correnti del colore, i pattern riempiono cellule cromatiche, le sagome emergono come isole solide in un mare di pura energia.
È una simbiosi perfetta tra pittura gestuale, informale e un grafismo illustrativo di una precisione quasi calligrafica.
I tratti stilistici ricorrenti formano un lessico denso di significato. L’elemento femminile è centrale: sirene, fate, profili femminili sono gli archetipi attraverso cui Farg² esplora le dinamiche delle relazioni umane, della creatività, del legame con la natura e con il mistero. Questi esseri non sono mai eterei o passivi ma potenti, ieratici, spesso adornati da elementi tribali e preziosi (foglie d’oro e d’argento) che ne sottolineano la sacralità.
Altri simboli – la farfalla (metamorfosi), l’orologio (il tempo come vincolo e ritmo), gli elementi naturali – vengono innestati in questo universo sospeso tra sogno e incubo.
La palette è audace e antinaturalistica: i viola profondi, i rossi sanguigni, i blu cosmici di Rinaldoni creano un’atmosfera notturna, onirica, squarciata dalla luminosità grafica degli interventi di Ghidini.
La semiotica di Farg² è una potente allegoria della psiche umana. Il loro lavoro mette in scena il rapporto tra l’Io – la figura definita, la coscienza, la narrazione di Ghidini – e l’Es – il fondo caotico, l’inconscio, le pulsioni di Rinaldoni.
L’opera non propone la vittoria dell’uno sull’altro, ma la loro necessaria e a volte ardua coesistenza.
Gli artisti diventano mediatori, sciamani che viaggiano tra i due mondi e li tengono in equilibrio.
Il messaggio che emerge è profondo: non c’è coscienza senza inconscio, non c’è storia senza un magma pre-narrativo da cui attingere, non c’è forma senza un’energia informe che la sostenga.
L’emozione veicolata è una sorta di vertigine controllata, la meraviglia di fronte alla complessità dell’esistenza, la tensione tra la libertà assoluta del possibile e la necessità della scelta, della definizione.
La filosofia che sostiene questa produzione è un dualismo integrato, una visione che riecheggia le grandi polarità del pensiero umano: il Dionisiaco e l’Apollineo, il Caos e il Cosmo, il femminile e il maschile – incarnate, non a caso, dai due artisti stessi.
La loro non è una visione conflittuale ma sintetica, e il loro approccio alla vita sembra invitarci a danzare con le proprie ombre, a dare nome e forma alle nostre correnti interiori senza presumere di esaurirle.
La passione bruciante, quasi “maniacale” nella sua spinta espansiva, è l’energia stessa di Rinaldoni che si riversa sulla tela.
La lucidità cristallina è l’infinita pazienza, la mano ferma di Ghidini che tesse i suoi pattern complessi, trasformando l’urlo in canto, il groviglio in arabesco.
Farg² non è semplicemente un duo di talento ma un progetto artistico di fondamentale importanza nel panorama contemporaneo, perché è riuscito a creare un linguaggio che è già, di per sé, una teoria della creazione e della coscienza.
Le loro opere sono mappe di un territorio intermedio, l’interregno tra sogno e veglia, istinto e ragione, caso e destino. Ogni tela è un atto di coraggio – il coraggio di affrontare il caos e di trovarvi non il vuoto ma il grembo di ogni bellezza possibile.
In questo senso, Rinaldoni e Ghidini sono veri alchimisti del ventunesimo secolo che, tuttavia, non trasmutano il piombo in oro, ma qualcosa di ben più prezioso: il flusso indifferenziato dell’essere nell’oro scintillante del senso.
NELLY FONTE


SENTIMENTO E NARRAZIONE
L’universo di Nelly Fonte è una sfacciata e sontuosa affermazione del sentimento sulla forma, della narrazione sulla plasticità delle cose.
La sua espressione artistica non è un monolite, fermo e immutabile, bensì un diario di bordo fatto di tanti toni, un atlante emotivo che traccia i diversi territori dell’esperienza umana attraverso una molteplicità di linguaggi visivi.
Analizzare le opere di Nelly Fonte significa entrare in una dimensione cromatica dove ogni tela è una dimensione a sé, una scena carica di un’intensità che rifiuta la tiepidezza e l’anestesia emotiva del nostro tempo.
La pittura di Fonte, che osa essere romantica, espressionista, simbolista e persino materica, a seconda delle esigenze della narrazione, trova la sua profonda coerenza non in una “maniera” ripetuta, bensì in una incrollabile fede nel potere dell’arte di dare corpo e colore alla vita interiore, all’inconscio.
La visione artistica di Fonte interpreta la realtà come un’esplosione cromatica, con un approccio al mondo che non è quello di un’osservatrice neutrale, ma di una testimone appassionata.
Ogni soggetto, che sia una ballerina di flamenco, un mare in burrasca o una donna assorta in un caffè parigino, viene filtrato da una sensibilità che ne amplifica la carica emotiva, traducendola in un linguaggio di pura vibrazione cromatica.
La sua personalità, riflessa in questa esuberanza, è quella di una “celebrante” della vita, un’artista che crede che la bellezza, la passione, la malinconia e la forza non siano concetti astratti, ma energie tangibili che si possono rendere visibili sulla tela.
Sul piano stilistico, la grande forza di Nelly Fonte è la sua eterodossia, quella capacità di modulare la tecnica in risposta all’anima del soggetto e nella sua arte, infatti, si possono individuare più correnti intrecciate, a volte coesistenti nella stessa opera.
Dalla sua grammatica del colore emerge una potente vena espressionista-gestuale, in cui il colore è steso in maniera vigorosa, quasi aggressiva, conferendo la forma e il movimento dall’interno.
La ballerina di flamenco ne è l’emblema: il suo vestito rosso non è solo tessuto, ma un vortice di fuoco, un’irruzione di passione resa con una gestualità che è già di per sé danza. Analogamente, i suoi paesaggi astratti sono sinfonie di forze naturali, grovigli di energie telluriche dove il tratto si fa vento, terra e vegetazione.
Accanto a questa corrente convive un registro più lirico e narrativo, dove il disegno si fa più preciso e la composizione più studiata.
Le figure delle geishe, immerse in paesaggi onirici, o la donna parigina, sono esempi di una pittura che cede al piacere del racconto, dell’atmosfera, enciclopedie visuali in cui l’artista dimostra una notevole abilità nel fondere la precisione del dettaglio con la libertà impressionistica dello sfondo, creando scene che possiedono il fascino di un’illustrazione d’autore o di un fotogramma di cinema d’epoca.
Infine, si incontrano incursioni nel materico e nel simbolista. Il paesaggio del Golden Gate Bridge sotto un cielo tempestoso è un’opera di straordinaria potenza fisica: il mare è un bassorilievo di cromie dense, un’ondata di materia che minaccia di traboccare dalla tela, conferendo alla scena un dramma quasi palpabile.
La dimensione simbolista affiora in opere come la donna che si confronta col proprio doppio nello specchio, o quella che rinasce accanto a una fenice, dipinti in cui il fatto pittorico trascende il reale per addentrarsi nei regni del mito, del sogno, dell’indagine psicologica.
I tratti stilistici ricorrenti formano gli elementi di un coerente vocabolario emotivo, all’interno del quale la figura femminile è il fulcro quasi assoluto della sua ricerca. Non è mai un oggetto passivo, ma sempre un soggetto colto nel pieno di un’azione o di una condizione interiore intensa: la passione della danza, la quiete contemplativa, la malinconia sognante, la forza della rinascita.
La donna di Fonte è un archetipo della vitalità e la palette è il suo strumento prescelto per l’orchestrazione emotiva, dove i rossi sono passionali e vitali, i blu contemplativi o tempestosi, i verdi evocano la serenità della natura, mentre i gialli e gli aranci sono lampi di gioia o di calore in un mondo a volte in ombra.
La semiotica delle opere di Fonte è un inno alla resilienza e alla ricchezza dell’esperienza umana.
Il messaggio non è mai criptico, ma diretto, universale poiché l’artista riesce a trasformare i colori in veicolo di messaggi potenti e lucidi, che fanno riflettere.
La donna sulla spiaggia, con il suo ombrellone giallo che crea un cerchio di luce e sicurezza contro un cielo plumbeo, è una metafora perfetta della capacità umana di ritagliarsi un proprio spazio di serenità anche in mezzo alle avversità; la ragazza parigina, dalla cui mente si dipana una costellazione, rappresenta la potenza del sogno e della creatività, la capacità della mente di costruire universi che trascendono la realtà contingente.
L’emozione che cerca di trasmettere Fonte è sempre intensa e riconoscibile, un invito all’empatia, a riconoscere nella tela uno specchio, un frammento della propria vita emotiva.
La filosofia che anima l’arte di Nelly Fonte è una forma di umanesimo vitalistico e romantico, che denota una visione della vita che, pur non ignorando il dramma e la tempesta, nei i cieli scuriti e nei mari in burrasca, sceglie deliberatamente di volgere la sua attenzione alla luce, alla passione, alla bellezza e alla capacità di rinascita.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di totale immersione, così la passione si traduce nella vitale carnalità del colore e nel dinamismo del gesto. La sua lucida osservazione, d’altro canto, si manifesta nella maestria con cui costruisce le sue scene, nell’equilibrio compositivo, nella finezza psicologica con cui coglie le posture e le espressioni dei suoi personaggi.
Nelly Fonte è un’artista di notevole profondità e rara generosità espressiva, la cui arte è un potente antidoto al minimalismo concettuale e all’aridità emotiva della nostra società.
In un’epoca che spesso privilegia il cinismo e la decostruzione, Fonte osa essere una costruttrice di mondi, una narratrice, un’autrice capace di celebrare il complesso e meraviglioso spettro del sentimento umano.
La sua pittura non è una fuga dalla realtà, ma un’immersione nella sua essenza più profonda, un invito a guardare il mondo non solo con gli occhi, ma con tutto il cuore.
VIOLA FUSHA


LIRISMO, MUSICA E SINESTESIA
L’arte di Viola Fusha è un’elegante e appassionata rivendicazione della bellezza come forma di conoscenza e, in un’epoca spesso incline alla dissonanza e alla decostruzione, la sua pittura è un’oasi lirica, uno spazio dove la materia cromatica, la luce e la forma convergono in una sinfonia visiva che intende colpire le corde più profonde e universali della sensibilità umana.
Quella di Fusha non è una pittura di mera rappresentazione, ma di trasfigurazione.
Attraverso una sensibilità che intreccia la tradizione romantica a una coraggiosa sperimentazione tecnica, Fusha eleva i suoi soggetti, che siano bouquet di rose, strumenti musicali o un paesaggio silente, a simboli di una realtà superiore, una dimensione in cui il visibile diventa portale per l’invisibile regno delle emozioni e delle armonie, poiché la sua visione artistica concepisce la realtà come una partitura musicale.
Il suo approccio non è quello di una cronista, ma di una compositrice, che seleziona temi come la musica, la natura o la quiete, e li sviluppa in variazioni cromatiche e materiche.
La sua personalità artistica, rispecchiata in questa costante ricerca dell’armonia, è quella di un’esteta che crede nel potere taumaturgico dell’arte, cioè nella sua capacità di consolare, elevare, incantare.
Ogni tela reca il desiderio palpabile di dotare l’oggetto rappresentato di un’anima, di un’aura, trasformandolo da semplice cosa in presenza di vita.
Sul piano stilistico, Fusha dimostra una notevole versatilità, ma sempre riconducibile a un’unica matrice poetica anche se nella sua sintassi si distinguono più traiettorie stilistiche, che spesso si intersecano e arricchiscono a vicenda.
Dalla sua grammatica del colore emerge con forza una vena romantico-impressionista, evidente nel sontuoso bouquet di rose, dove il colore si libera dal vincolo della linea, fatta di pura luce e atmosfera.
Le pennellate sono rapide, vibranti, a costruire il volume dei fiori non attraverso il contorno, ma per giustapposizione di toni caldi e freddi, con un effetto di vitalità abbagliante. È una pittura che esalta la bellezza effimera e sensuale della natura.
Accanto a questa tradizione, si trova un’indagine simbolista e polimaterica per cui sono emblematiche le opere dedicate agli strumenti musicali. Un violino che erompe da un’esplosione di fiamme dorate, o un sassofono adagiato su un collage di spartiti e foglia d’oro, non sono semplici nature morte, bensì allegorie del potere creativo della musica, della sua capacità di infiammare l’anima e trascendere la materialità del quotidiano.
L’uso di materiali extra-pittorici, intrecciati ai pigmenti, conferisce all’opera una profondità tattile e concettuale, rendendo fisicamente presente la stratificazione della memoria e della cultura.
Un’altra direzione cruciale è quella di un iperrealismo magico, manifestato con sorprendente intensità nelle opere con ragnatele, in cui l’artista isola un dettaglio infinitesimale del mondo naturale, elevandolo a protagonista assoluto, come un gioiello cosmico.
La precisione quasi fotografica con cui sono rese le gocce di rugiada, i loro riflessi e le trasparenze, è un processo tecnico che trascende la virtuosità, poiché le tele diventano mandala, mappe stellari, simboli della fragilità, della perfezione geometrica della natura e dell’interconnessione di tutte le cose.
Infine, emerge una vena metafisica e silente, incarnata nel paesaggio con barca e albero, dove il ventaglio di colori si ammorbidisce, le cromie si fanno polverose, l’atmosfera diventa rarefatta.
Il tempo sembra sospeso. L’immagine richiama la pittura di Friedrich, ma spogliata del suo sublime romantico e tradotta in una quiete contemplativa, quasi zen, in una pittura del silenzio, dell’attesa, dell’anima di fronte al mistero dell’esistenza.
Questi tratti stilistici ricorrenti formano un lessico visivo di grande raffinatezza. La musica è un tema ossessivo, non solo come soggetto, ma come principio strutturale dell’opera: le sue composizioni hanno ritmo, le sue linee una melodia, i suoi colori un’armonia.
La natura è l’altro grande pilastro tematico, esplorato in tutte le scale, dal macrocosmo di un tramonto, al microcosmo di una goccia d’acqua.
La luce gioca un ruolo fondamentale: la luce calda e dorata del sole che filtra tra i papaveri, quella fredda e cristallina della rugiada, o quella diffusa e malinconica di un paesaggio nebbioso.
La semiotica dell’opera di Fusha è un invito a riscoprire la poesia del mondo. Il suo messaggio è una celebrazione della bellezza come forma di resistenza alla banalità e alla fretta. Il violino a mosaico, velato di trasparenza davanti a un tramonto, non è solo uno strumento, ma l’anima dell’arte, fragile e preziosa, che contempla l’infinita bellezza del mondo.
I fiori cinesi, con le loro gocce di rugiada simili a gioielli, non sono un semplice ornamento esotico, ma un’ode alla delicatezza, alla perfezione, alla caducità della vita.
L’emozione che l’artista cerca di trasmettere è quella dell’incanto, della meraviglia, quella peculiare forma di rapimento che si prova di fronte a un’armonia inattesa.
La filosofia che anima il suo lavoro è una forma di idealismo lirico, una visione della vita che cerca e trova il sacro nel quotidiano, la musica nel silenzio, l’universo in un filo d’erba, in un rapporto con l’emozione che è di profonda consonanza.
La sua passione si traduce nella ricchezza delle cromie e nella sensualità della materia pittorica.
La sua espressione artistica è un’osservazione lucida che si manifesta nell’impeccabile precisione tecnica, nella padronanza compositiva e nella capacità di orchestrare elementi diversi in un insieme armonioso e perfettamente bilanciato.
Viola Fusha si afferma come un’artista dotata del raro dono di coniugare un altissimo livello di maestria tecnica con un’autentica e profonda sensibilità poetica, con una proposta artistica che si pone come un antidoto alla superficialità, un invito a rallentare e a rieducare lo sguardo per percepire la bellezza nascosta ripiegata nella realtà.
Ogni tela non è una finestra su un paesaggio o un oggetto, quanto un affaccio su uno stato d’animo, su un’armonia ritrovata, su un istante di pura poesia, silente e abbagliante.
GIORGIA GASPERI


ESTETICA GOTICA E PSICHE
L’espressione artistica di Giorgia Gasperi è un sontuoso e inquietante vortice sulle meraviglie dell’anima femminile.
La sua sintassi cromatica è una colta e visionaria esplorazione dei territori liminali della psiche, un regno in cui la bellezza è indissolubilmente sposata al macabro, la grazia alla ferita, l’eleganza formale a una profonda turbolenza interiore.
Non si tratta di mera pittura ritrattistica, quanto piuttosto di una drammaturgia dell’inconscio, in cui l’artista orchestra un cast di eroine gotiche, creature notturne e icone emotive per mettere in scena le complesse e spesso contraddittorie sfaccettature dell’identità.
La visione di Gasperi interpreta la realtà come un palcoscenico letterario e dalle dinamiche del sogno, con un approccio al mondo che è quello di una curatrice di un museo immaginario, dove reliquie di epoche diverse, dal Rinascimento all’epoca vittoriana, dal Decadentismo, al Surrealismo, vengono estratte, decontestualizzate e riassemblate in nuove e inquietanti narrazioni.
La sua personalità artistica, riflessa in questa estetica erudita e dalle mille sfaccettature, è quella di un’intellettuale in costante dialogo con la storia dell’arte e della letteratura, tuttavia impiega questo vasto repertorio non tanto come un esercizio di sterile citazione, ma come lessico attraverso cui dare forma a ossessioni e interrogativi profondamente radicati nella contemporaneità.
Sul piano stilistico, Giorgia Gasperi dimostra un’eccezionale padronanza tecnica, che le permette di muoversi con disinvoltura tra registri apparentemente distanti.
Si evidenzia una chiara ascendenza nel Simbolismo e nella pittura dei Preraffaelliti, visibile nella precisione quasi miniaturistica del disegno, nella preziosità dei dettagli, nella resa levigata della carne e nella predilezione per un’eleganza formale quasi aristocratica. Ma queste fondamenta “classiche” vengono sabotate e rese più complesse da elementi tratti da altri universi.
Il Pop Surrealismo e l’estetica dell’arte Lowbrow affiorano nei grandi occhi liquidi e malinconici delle sue protagoniste, che ricordano le bambole di Margaret Keane, e in un gusto per il bizzarro e il grottesco che contamina la compostezza delle sue scene.
La sua tecnica è un raffinato amalgama di pittura a olio, acrilico e disegno. Molte opere, in particolare quelle in bianco e nero o seppia, rivelano la mano di una superba disegnatrice, capace di evocare profondità e materia attraverso il solo chiaroscuro.
Quando il colore irrompe, è quasi sempre carico di significato: il rosso vibrante delle calze o del sangue, il verde smeraldo di un abito, le tinte psichedeliche di una creatura steampunk…, tutto parla, tutto è significante, così come il colore, per Gasperi, non è mai naturalistico, ma emotivo, simbolico, impiegato per sottolineare uno stato d’animo o per focalizzare l’attenzione su un dettaglio cruciale.
I suoi tratti ricorrenti si coagulano in un vero e proprio dizionario iconografico.
La figura femminile è la protagonista indiscussa, un archetipo declinato in infinite variazioni: la nobildonna, la vampira, la femme fatale, la bambola rotta, la guerriera, la vittima, figure che evocano una donna in cerca di affermazione, una donna che chiede di essere compresa.
Accanto a queste donne, si incontrano spesso elementi che ne svelano la natura nascosta: il teschio, un memento mori (ricordo che tutti dobbiamo morire) che dialoga con la bellezza effimera; il gatto nero, emblema di indipendenza, mistero, sensualità notturna e magia; la maschera, che indaga il tema dell’identità e della messa in scena sociale, tema di bruciante attualità; la mela, archetipo biblico di conoscenza e tentazione.
Il motivo della frattura è pervasivo. Il volto che si incrina come porcellana, la maschera che si spacca… sono potenti metafore visive della fragilità dell’io, del trauma, della spaccatura tra l’apparenza esteriore e la realtà interiore.
La semiotica nell’arte di Gasperi è una profonda indagine sul dualismo delle dinamiche del mondo femminile, liberata da ogni stereotipo consolatorio, infatti, le sue donne sono potenti e vulnerabili, seduttive e minacciose, vittime e carnefici.
La nobildonna in verde, nella sua posa regale, stringe in mano la mela del peccato mentre un teschio le riposa accanto, condensando in un’unica immagine Eros e Thanatos, potere e mortalità.
La vampira esangue che si nutre di sangue non è un mostro ma una figura di tragica bellezza, metafora della necessità di nutrirsi delle emozioni altrui per sopravvivere. La donna che ride a bocca spalancata, con lacrime colorate che le solcano il viso, diventa un’icona bruciante di riso che si mescola a pianto, di gioia nata dalla consapevolezza del dolore.
La filosofia è una forma di Romanticismo gotico aggiornato al ventunesimo secolo, in una visione della vita che non ha paura di sondare le zone d’ombra dell’esistenza, anzi le trova esteticamente e intellettualmente più fertili della chiarezza della luce diurna.
Rifiuta una concezione monolitica e rassicurante dell’identità in favore della sua complessità, frammentazione e contraddizione. Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è mediato da un filtro di intellettualismo e distanza estetica, dove la passione non viene mai declamata, ma trattenuta nella perfezione del segno, nella compostezza delle sue eroine, anche nel loro momento più drammatico.
Il suo sguardo lucido si traduce nella coerenza del suo universo simbolico e nella precisione quasi clinica con cui seziona le patologie dell’anima.
Giorgia Gasperi è una delle voci più erudite e originali della nuova figurazione italiana, la cui arte è un antidoto alla banalità e un invito a un’esplorazione senza timori dei labirinti della psiche.
Con un linguaggio che fonde la grandiosità dell’alta tradizione pittorica con le risonanze della cultura underground, ha dato vita a un linguaggio profondamente personale e immediatamente riconoscibile, popolato da creature indimenticabili che ci guardano dai loro mondi crepuscolari e ci interrogano sulla nostra natura, sulle nostre maschere e sulle nostre ferite nascoste.
La sua arte è un elegante, letale sussurro, capace di farci sentire a nostro agio nel disagio.
MARIO GHIZZARDI


LA FISICA DELLA PITTURA
L’arte di Mario Ghizzardi è un’indagine radicale e intransigente sulla natura dell’atto creativo che non è pittura per rappresentare ma per narrare e alludere; è una pittura che accade.
Ogni tela di Ghizzardi è ciò che resta di un’eruzione, la cicatrice di un evento, il sismogramma di un’energia pura che, per un istante abbagliante, ha trovato sulla tela l’arena della sua manifestazione.
Rinunciando a ogni legame col mondo fenomenico, Ghizzardi si immerge in un’astrazione che è, nel senso più profondo, la forma più estrema di realismo, quel realismo dell’energia, colta nel suo stato nascente, primordiale e incontenibile.
La sua visione artistica trascende la realtà per accedere direttamente al processo della creazione, con un approccio al mondo che non è quello di un osservatore che ne decifra le forme, ma di un fisico delle particelle che ne scatena le forze.
La sua personalità artistica, riflessa in questa pratica quasi sciamanica, è quella di un orchestratore del caos, un coreografo dell’imprevedibile, nel suo lavoro, in cui si percepisce una violenza controllata, una furia lucida che non si abbandona mai del tutto al caso, ma danza con il caos, lo guida, lo provoca, e ne iscrive l’impronta indelebile.
Ogni opera di Ghizzardi è la testimonianza di una lotta e di una liberazione, un atto catartico che si consuma e diventa eterno al tempo stesso.
Sul piano stilistico, Ghizzardi si colloca nella nobile e radicale stirpe dell’Action Painting, ma ne spinge le premesse alle loro ultime conseguenze, grazie a una tecnica che è in sé sia soggetto che fine della sua indagine.
La sua sintassi del colore, con il lancio, lo schizzo, il gocciolamento, l’esplosione del pigmento, non serve a costruire un’immagine, perché è già l’immagine dell’essenza. La tela, come avrebbe detto Harold Rosenberg, diventa “un’arena in cui agire”.
Ne emerge una complessa stratigrafia di eventi dove, spesso, un fondo rarefatto, quasi nebuloso funge da spazio primordiale, un silenzio cosmico su cui si scatena la detonazione cromatica. Su questo palinsesto si sovrappongono dense esplosioni di colore, schizzi filamentosi, impatti materici che creano un bassorilievo di pura energia, in una resa pittorica che non è bidimensionale, ma uno spazio-tempo compresso in cui ogni strato conserva la memoria di un istante, di una decisione, di un impulso.
I tratti stilistici ricorrenti diventano elementi di un vocabolario energetico dove l’artista lavora per serie cromatiche che sembrano corrispondere a diverse “temperature” dell’emozione o a distinti stati della materia.
Incontriamo cosmogonie infuocate dominate da neri profondi squarciati da rossi, aranci e gialli incandescenti, al limite della fosforescenza: supernove, nuclei stellari in fissione, la rappresentazione della furia creatrice e della passione.
Altre opere virano verso registri più freddi, acquatici, con blu, turchesi e verdi dominanti, solcati da spruzzi di pigmento che evocano la spuma di un’onda cosmica o la bioluminescenza di creature abissali. In altri casi ancora, l’intero spettro cromatico viene convocato in un parossismo visivo, una sorta di Big Bang pittorico in cui tutte le forze primordiali si scontrano e interagiscono, generando un universo di complessità quasi infinita.
La semiotica di Ghizzardi è radicalmente autoriferita, ed è proprio qui che si trova la sua potenza filosofica, perché il messaggio non è un significato nascosto da decifrare, ma è l’energia pura.
L’artista non ci chiede di “capire” cosa rappresenti la sua arte, ma ci chiede di “sentire” l’impatto della sua creazione. Le sue tele sono condensatori di un’emozione che non è psicologica, come la tristezza o la gioia, ma ontologica: la pura emozione dell’esistenza, lo slancio vitale di Bergson reso materia visibile.
Ghizzardi riesce a trasformare il colore, sostanza inerte per definizione, nel suo esatto opposto, in un evento dinamico, un processo inarrestabile, nel senso che la sua pittura rivela l’essenza del reale non come fosse una collezione di oggetti stabili, ma come un campo di forze in perpetua, violenta e meravigliosa genesi.
La filosofia alla base di questa indagine è una forma di eraclitismo radicale in cui tutto scorre, e l’arte di Ghizzardi ne è la visualizzazione più pura.
La sua visione della vita non è di un universo ordinato e rassicurante, ma di un perenne stato di conflitto generativo, dove ogni forma nasce dalla distruzione di una forma precedente e ogni istante è una singolarità irripetibile.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di un’immediatezza quasi brutale, perché non c’è mediazione, non c’è filtro, non c’è rappresentazione, perciò l’impulso interiore si traduce istantaneamente in gesto, e il gesto in traccia permanente.
La sua passione si manifesta nella fisicità palpabile del suo approccio, nell’energia quasi tangibile che emana da ogni tela, d’altro canto, la lucida osservazione emerge nel sottile controllo di questo processo apparentemente caotico, dove la scelta della densità del colore, la direzione del lancio, l’equilibrio dinamico della composizione rivelano una mente non asservita all’impulso, ma che utilizza la libertà del gesto come partner in una pericolosa, quanto vitale, danza, per esteriorizzare le soluzioni generate dal suo stesso spirito critico.
Mario Ghizzardi è un esploratore solitario e coraggioso dei limiti estremi della pittura. Prima di essere concetto, narrazione o ornamento, la sua arte è un atto di pura affermazione esistenziale, le sue tele non sono finestre sul mondo, ma specchi che riflettono la nostra stessa natura fatta di energia, il nostro caos interiore, la nostra capacità di generare ordine dal disordine.
Non sono opere da contemplare in silenzio, ma da affrontare quasi fisicamente, lasciando che la loro energia primordiale risuoni con la nostra.
In un mondo che cerca costantemente di addomesticare, definire e neutralizzare tutto attraverso sistemi e tecniche, l’arte di Ghizzardi è un inno indispensabile, quanto liberatorio, alla forza indomabile e selvaggia, della creazione e dello spirito critico libero.
BRUNO GRECO


UNA VISIONE ECLETTICA DEL MONDO
L’arte di Bruno Greco è un audace manifesto contro la tirannia dello stile unico e della schematizzazione, perciò, analizzare l’essenza della sua pittura significa intraprendere un viaggio attraverso un arcipelago di linguaggi visivi, dove ogni isola rappresenta una distinta possibilità di visione, una diversa modalità d’interrogare la realtà.
Lontano dall’essere sintomo di incertezza, questo eclettismo programmatico è il nucleo stesso, metodologico e filosofico, della sua ricerca, perché Greco è un artista-esploratore, un poliglotta della pittura che rifiuta di cristallizzarsi in una “maniera” riconoscibile, per rivendicare la libertà assoluta di adattare il linguaggio all’essenza del soggetto che intende esplorare.
La sua coerenza non va cercata nella forma, ma nell’intenzione, nella convinzione che non esista una sola realtà, ma una molteplicità di realtà possibili, ciascuna delle quali esige la propria chiave visiva specifica.
La visione artistica di Greco è dunque plurale e il suo approccio al mondo è quello di un fenomenologo che sa che l’esperienza di un paesaggio innevato non può essere veicolata con gli stessi strumenti utilizzati per catturare l’energia di una forma astratta o il glamour di un ritratto Pop.
La sua personalità artistica, riflessa in questa sensibilità poliedrica, è quella di un intellettuale irrequieto e curioso, un umanista ugualmente a suo agio nel silenzio contemplativo come nell’esplosione cromatica, nella precisione del dettaglio realistico come nella sintesi geometrica.
Egli non cerca una verità unica, ma si compiace dell’inesauribile ricchezza delle sue molteplici manifestazioni.
Sul piano stilistico, l’opera di Greco costituisce un vero e proprio compendio ragionato della pittura del Novecento e del ventunesimo secolo, rielaborato però attraverso una sensibilità del tutto personale.
All’interno della sua traiettoria, possiamo individuare diverse linee di ricerca distinte: la prima è quella di un Iperrealismo lirico, manifestato in opere come i girasoli o la barca sulla spiaggia, dove l’artista dimostra un’impeccabile padronanza tecnica, un’abilità quasi fiamminga nel rendere la luce, la materia, il dettaglio.
Eppure, il suo iperrealismo non è mai freddo o fotografico, poiché c’è sempre una componente emotiva, una luce calda, avvolgente, una scelta compositiva che trasfigura il soggetto, elevandolo da mero oggetto a presenza di un’intensità quasi sacra.
Una seconda, potente vena è quella Espressionista-Fauve.
La barca nel paesaggio dai toni acidi, o la tela astratta con le sue lingue di fuoco cromatico, esemplificano una pittura che si libera da ogni vincolo mimetico per farsi pura espressione di uno stato interiore.
Qui il colore è antinaturalistico, violento, giubilante, dall’effetto cromatico denso, tattile, insistente.
È una pittura che non descrive il mondo, ma lo reinventa secondo le leggi dell’emozione.
Accanto a queste, si incontra una linea di ricerca Geometrico-Concreta, in dialogo con le avanguardie storiche dal Suprematismo al Concretismo.
L’opera con triangoli colorati e linee nere è un esercizio di rigore compositivo, un’indagine sulle pure relazioni di forma, colore e spazio, ma anche qui Greco introduce un elemento personale, dirompente: la cornice materica, simile a intonaco grezzo, creando un contrasto dialettico tra la purezza platonica della geometria interna e la rozza concretezza del mondo esterno.
Infine, vi sono incursioni nel Pop e nel Metafisico.
Il ritratto della donna col cappello rosso è un’icona Pop, dai colori vivaci e dai campi nettamente definiti, eppure è carica di una complessità e di una ricchezza cromatica che la distanziano dalla serialità warholiana.
Il paesaggio innevato con le due panchine vuote, al contrario, è un capolavoro di silenzio e sospensione metafisica, un mondo in cui tutto è soffocato, che esalta la meditazione, il pensiero, la filosofia.
Con una palette ridotta all’essenziale e una composizione di un rigore quasi cinematografico, Greco evoca un senso di solitudine, di attesa, di dialogo muto tra la presenza umana (le panchine) e l’immensità di una natura indifferente.
La semiotica dell’opera di Greco si trova proprio in questa capacità di far parlare linguaggi diversi.
Il messaggio sottostante è un’affermazione della complessità del mondo e della vita umana.
L’artista ci mostra che il mondo può essere, simultaneamente, un luogo di quiete assoluta, come le panchine nella neve, e di energia sfrenata, come nell’astrazione cromatica, così come un oggetto di contemplazione realistica, nei girasoli, e un’idea platonica, nella geometria.
La sua arte diventa una metafora della mente umana, capace di contenere ed elaborare la realtà attraverso registri logici, emotivi, intuitivi e analitici.
Le emozioni che veicola mutano radicalmente di tela in tela, dalla malinconia alla gioia, dalla quiete alla turbolenza, e, in questa varietà, si fonda la sua onestà intellettuale.
La filosofia che anima la sua produzione è una forma di relativismo gnoseologico, una profonda consapevolezza che ogni strumento d’indagine, che ogni stile pittorico, rivela solo una faccia della verità, mai la sua totalità.
La sua visione della vita è quella di un umanista rinascimentale proiettato nel postmoderno, un “uomo universale” che rifiuta la specializzazione a favore di un sapere integrato e polifonico il cui rapporto tra la sua arte e l’emozione è mediato da un lucido controllo intellettuale.
La passione è evidente nel gesto espressionista, eppure sempre bilanciata dalla precisione del realista o dal rigore del geometra.
È un equilibrio costante tra Dioniso e Apollo, tra l’impulso a esprimere e la volontà di comprendere, un equilibrio che fa di Bruno Greco un artista di rara intelligenza e libertà stilistica.
In un mercato dell’arte che spesso premia la riconoscibilità e la ripetizione di formule che funzionano, la sua scelta di essere un “pittore senza stile” non è l’infinita ricerca di un proprio linguaggio, ma un atto di coraggio e di profonda integrità intellettuale di un uomo dalle molte sfaccettature che non può essere rinchiuso in un’unica scatola.
La sua produzione artistica è un invito a non accontentarsi mai di una sola prospettiva, ma a coltivare la flessibilità dello sguardo e della mente, a mettere tutto in discussione. Sempre.
Ciascuna sua tela è una lezione di pittura, ma soprattutto, una lezione di vita che ci insegna che per cogliere la ricchezza del mondo, non bisogna cercare una sola chiave per aprire tutte le porte, ma possedere un intero mazzo di chiavi e la saggezza di scegliere, ogni volta, quella giusta per la porta che ci si para di fronte.
MARCO LOCATELLI


ONTOLOGIA DELLO SGUARDO
L’espressione artistica di Marco Locatelli è una radicale dimostrazione di amore per la perfezione del reale, in un’epoca satura di immagini effimere e di rappresentazioni mediate dalle App, per cui la sua pittura è una presenza intensa, quasi ingombrante.
In un’opera di Marco Locatelli si accende un iperrealismo che trascende la virtuosità tecnica per farsi strumento d’indagine ontologica, cioè un mezzo per restituire dignità e anima ad ogni frammento del creato.
Locatelli non dipinge semplicemente ciò che è ambito del senso visivo, ma l’atto stesso del vedere, elevandolo a un’intensità tale che la superficie pittorica diventa un varco, un’esperienza quasi tattile che costringe lo spettatore a ripensare il proprio rapporto col mondo.
Perché Locatelli ci rivela l’anima di ciò che dipinge non solo la superficie esterna.
La sua visione artistica poggia su un principio d’immanenza, in cui il sacro non va cercato in un aldilà trascendente, ma si manifesta qui e ora, nella ruvidezza tattile di un petalo, nel riflesso di una pupilla, nella tensione di un muscolo.
Il suo approccio al mondo è quello di un filosofo che, attraverso una pazienza e una concentrazione vicine al monastico, riesce a percepire e fissare sulla tela l’essenza vitale, l’anima delle cose, che pulsa in ogni creatura e in ogni elemento della natura.
La sua personalità è quella di un perfezionista animato da una profonda empatia, in quanto la sua non è la precisione fredda di una macchina, ma un’attenzione amorevole che si traduce in un rispetto quasi reverenziale per il soggetto rappresentato.
Sul piano stilistico, Locatelli opera ai vertici dell’Iperrealismo, movimento che ha da tempo superato la sua fase storica per divenire un linguaggio consolidato, ma che nelle sue mani acquisisce una nuova e sorprendente vitalità, grazie a una tecnica sbalorditiva, quasi incredibile nella capacità di replicare la realtà.
Ogni pelo del mantello di una tigre, ogni venatura di una foglia, ogni guizzo di luce in una goccia d’acqua è reso con precisione microcellulare.
Eppure, ciò che distingue il suo lavoro dalla mera replica fotografica è una serie di scelte sottili, eppure decisive. Innanzitutto, il magistrale uso del chiaroscuro, quasi caravaggesco, per cui i suoi soggetti emergono da fondali scuri, neutri, che ne isolano la presenza, la monumentalizzano e la caricano di una drammaticità quasi teatrale. Non lo sfondo accidentale di un’istantanea, ma uno spazio metafisico che esige concentrazione assoluta sulla forma.
In secondo luogo, la sua capacità di rendere importante la materia oltre alla forma, così si percepisce la morbidezza vellutata dei petali di una peonia, la ruvidezza umida del naso di un cane, la fredda liquidità dell’acqua.
Questi effetti non sono ottenuti solo con il disegno, ma attraverso una lavorazione del colore, stratificato in velature finissime e meticolose, con cui Locatelli riesce a simulare il modo in cui ogni superficie risponde alla luce.
Così, il suo iperrealismo non si ferma alla retina, ma stimola tutti i sensi e costringe alla riflessione.
I tratti stilistici ricorrenti definiscono un universo coerente, dove la scelta dei soggetti non è mai casuale.
Da un lato, ci sono i grandi felini, come la tigre, il leopardo, il leone, personificazioni di una bellezza selvaggia, della potenza, di una grazia indomita che Locatelli non ritrae in pose statiche, come in un documentario, ma ne cattura l’essenza psicologica, l’orgoglio, la concentrazione, la vulnerabilità.
Le sue inquadrature compositive sono spesso audaci, quasi cinematografiche, con il primissimo piano, quasi astratto, del muso di un leone bianco, e la tigre che emerge dal buio che ci mettono a confronto, quasi intimamente, con queste creature.
Dall’altro lato, c’è la delicatezza dei fiori, soprattutto le peonie, simboli di fragilità e opulenza, e degli animali domestici, il cui sguardo è impregnato di una commovente umanità, quasi umanizzazione.
Questa dialettica tra forza selvaggia e grazia della vulnerabilità costituisce uno dei cardini della sua poetica.
La semiotica dell’opera di Locatelli è un potente richiamo all’attenzione, in un mondo abituato a “scorrere” le immagini senza vederle, perché Marco Locatelli ci obbliga a fermarci, a guardare davvero. A pensare.
Il messaggio è un invito a riscoprire la meraviglia.
Lui riesce a trasformare il colore in un’esperienza quasi trascendente.
Nel suo leopardo specchiato su una superficie nera, non vediamo solo un animale ma il concetto stesso di eleganza, di solitudine, del dualismo tra l’essere e la sua immagine, così come, nelle sue peonie, non percepiamo solo fiori, ma la pienezza della vita e, insieme, la sua struggente caducità.
Locatelli investe il dettaglio iperrealista di un immenso peso simbolico, dimostrando che la via più diretta verso l’universale passa, paradossalmente, per la più scrupolosa fedeltà al particolare.
La filosofia che anima la sua pratica è una forma di panteismo naturalistico, una profonda convinzione che ogni forma di vita rechi in sé una scintilla di coscienza e una bellezza degna di contemplazione, comprensione e rispetto.
La sua visione della vita è un antidoto alla superficialità e all’antropocentrismo.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è mediato da una ferrea disciplina, con una passione che emerge prepotente nella dedizione quasi ossessiva, nell’amore per il mestiere, che si traduce in ore, giorni, settimane di lavoro su un singolo dettaglio.
La sua lucida osservazione è parte della sua arte, la capacità di vedere e di farci vedere il mondo con acume e profondità a cui non siamo più abituati.
Marco Locatelli non è solo un virtuoso dell’iperrealismo, ma un vero poeta della materia, un filosofo dello sguardo, la cui arte ci sfida a riconsiderare il significato stesso di “realismo”.
Non si tratta di copiare il mondo, ma di amarlo così intensamente da ricrearlo, atomo per atomo, sulla tela, per restituircelo imbevuto di un’aura di mistero e di sacralità che solo il grande talento artistico sa evocare.
Le sue opere non sono immagini, ma presenze, e, dinanzi a queste presenze, non possiamo non sentirci, a nostra volta, più presenti, più attenti, più vivi.
LAURA MANCARELLA


TOPOGRAFIE DELL’ANIMA
L’arte di Laura Mancarella è una sublime manifestazione metaforica e archeologica che non si limita a rappresentare paesaggi, ma li evoca come stati interiori, come mappe geologiche di una memoria ancestrale che risuona nel macrocosmo della natura quanto nel microcosmo della psiche, soprattutto, dell’anima.
Ciò che si nota è un’astrazione lirica, materica, che attinge alla grande tradizione dell’arte informale, eppure distinta da un idioma singolare in cui le cromie diventano manifestazione esteriore del paesaggio, del tempo e della percezione.
Ogni tela è un frammento di un mondo in formazione o in dissoluzione, un luogo in cui terra, acqua e luce non sono descritti come elementi, ma subiti come forze che si scontrano e si fondono in una sintesi di bellezza drammatica e silenziosa.
La visione di Mancarella interpreta la realtà come un processo di stratificazione, grazie a uno sguardo che non si sofferma sulla superficie delle cose, ma ne intuisce le profondità, le fratture, le sedimentazioni.
La sua personalità artistica, rivelata in questa costante ricerca della scabrosità e dello spessore tattile, è quella di un’alchimista che non teme di mescolare pigmenti preziosi a materiali grezzi, che scopre la poesia non tanto nella perfezione levigata, bensì nella bellezza imperfetta di una superficie, nell’incidente controllato di una colatura, nell’emersione improvvisa della luce da un buio denso e materico.
Sul piano stilistico, Mancarella si muove con straordinaria padronanza nel campo dell’astrazione materica.
La sua tecnica è un processo complesso, stratificato, che supera di gran lunga la mera applicazione del colore.
La superficie delle sue opere è un campo di eventi: impiega impasti densi, stucchi, sabbie, resine, stesi con la spatola per creare veri e propri rilievi topografici. Su questa prima pelle, aspra e tellurica, interviene con velature traslucide, colature liquide, pigmenti metallici e tecniche di invecchiamento che simulano la terra riarsa o il deterioramento di un affresco. Il risultato è una superficie palpabilmente reale e viva, che invita a una doppia lettura: da lontano, per cogliere l’armonia complessiva della composizione, e da vicino, quasi tattile, per scoprirvi un universo di dettagli, di micro-eventi nella materia.
Nel suo linguaggio cromatico si possono distinguere due traiettorie principali, la prima delle quali è quella dei paesaggi astratti orizzontali, opere in cui una linea d’orizzonte bassa, spesso drammatica, divide due mondi.
La parte inferiore è quasi sempre densa, materica, tellurica: terra, roccia, la città lontana. La parte superiore è più eterea, atmosferica: cielo, nebbia, acqua.
In queste opere, Mancarella orchestra con maestria i contrasti, con l’opacità della terra contro la trasparenza del cielo, la stasi della materia contro la fluidità del colore, l’oscurità del suolo contro la luce, spesso dorata o argentea, che si incrina all’orizzonte.
È una struttura compositiva quasi archetipica, che riecheggia i paesaggi romantici di Friedrich o Turner, ma spogliata dell’aneddoto e trasposta in un linguaggio dove contano di più materia e colore.
La seconda traiettoria è quella delle visioni aeree o sottomarine, dove l’orizzonte scompare e lo spettatore è proiettato al centro di un vortice. La composizione si fa più organica, cellulare: somigliano a mappe di isole viste dall’alto, fondali marini, sezioni di minerali preziosi.
Qui, la tecnica della colatura e le reazioni chimiche tra i colori giocano un ruolo decisivo, generando forme fluide, venature e cellule che evocano i processi generativi della stessa natura.
I suoi tratti stilistici ricorrenti formano gli elementi di un potente vocabolario emotivo e simbolico, dove la luce preziosa, che emerge dalla materia grezza, diventa metafora della speranza, della spiritualità, della memoria che illumina il presente.
La craquelure (tecnica di invecchiamento) non è solo un effetto tecnico, ma l’emblema del passaggio del tempo, della fragilità, della bellezza nata dalla ferita.
La sua palette di colori è sofisticata, mai banale, costruita su armonie di terre, come marroni, ocra, neri, improvvisamente accese da note vibranti di blu oltremare, verde smeraldo, rosa antico, magenta e, talvolta, bianco puro.
La semiotica dell’opera di Mancarella è una meditazione sulla memoria e sulla trasformazione, il cui messaggio non è esplicito, ma affidato al potere evocativo della materia. Le sue opere sono paesaggi dell’anima: la terra fratturata è la nostra fragilità; l’oro che affiora è la nostra resilienza.
Il cielo plumbeo che preme su un orizzonte luminoso è il dramma della speranza che lotta contro l’oscurità.
Lei riesce a trasmutare la materia pittorica in un’esperienza quasi sinestetica, in cui lo spettatore non vede solo un colore ma ne percepisce il peso, la temperatura, la storia.
L’emozione veicolata è un misto di stupore di fronte alla forza della natura, della pittura, e di un profondo, silenzioso conforto.
La filosofia che anima la sua espressione artistica è una forma di idealismo materiale. La sua visione della vita suggerisce che lo spirito non sia separato dalla materia, ma la sua manifestazione più intima e luminosa.
La sua arte è un atto di fede nella capacità del colore di parlare, di ricordare, di sanare; infatti il rapporto tra la sua arte e l’emozione è profondo, eppure sempre mediato da un controllo formale impeccabile.
La passione è presente nella densità degli impasti, nella violenza controllata del gesto.
La sua lucida osservazione esplode nella maestria con cui orchestra complessi equilibri cromatici e materici, trasformando quello che potrebbe essere un caos amorfo in una sinfonia perfettamente calibrata.
Laura Mancarella è un antidoto alla superficialità dell’immagine digitale, un invito a riscoprire la fisicità, la densità e i tempi della pittura.
Le sue tele non sono oggetti da consumare in uno sguardo frettoloso, ma territori da esplorare, spazi meditativi in cui ci si può perdere solo per ritrovarsi nuovamente, poiché, in ogni fessura, ogni colatura, ogni scintillio metallico, Mancarella ci racconta una storia antica, la storia della Terra, che è anche, inesorabilmente, la storia della nostra anima.
VLADIMIRO MARRAMA


L’ALCHIMIA DELLO SGUARDO
L’espressione artistica di Vladimiro Marrama è un’operazione filosofica radicale, condotta attraverso gli strumenti dell’arte.
La sua arte non si limita a esplorare i confini di una singola disciplina; piuttosto, li dissolve, operando in un territorio liminale dove pittura, scultura, fotografia e installazione scenografica rinunciano alla propria autonomia per divenire momenti inscindibili di un unico, coerente processo alchemico.
L’artista non lavora sulla materia, ma attraverso la materia, scegliendo come medium privilegiato non tanto un pigmento o un metallo, ma l’oggetto più carico di implicazioni metafisiche: lo specchio.
O, per usare le sue illuminanti parole, la sua “anima”, l’argentatura.
Ciascuna sua opera è un atto di creazione che non inizia dal nulla, ma da una dissoluzione, incarnando il principio ermetico del solve et coagula.
La visione artistica di Marrama è processuale e trasformativa al tempo stesso, infatti non considera la realtà come un dato stabile da rappresentare, ma come un campo di forze illusorie e percettive da interrogare, da svelare, con un approccio al mondo che è quello di un alchimista, di un filosofo, che sa che per accedere a una nuova conoscenza bisogna prima decostruire le certezze acquisite.
La figura che emerge è quella di un pensatore rigoroso, un intellettuale che unisce una profonda cultura filosofica a una competenza tecnica e scientifica non comune, la reazione chimica AgNO₃.
La sua non è un’arte dell’abbandono emotivo, ma della lucida, quasi spietata, manipolazione concettuale della materia per svelarne le verità nascoste.
Lo stile di Marrama non può essere definito da categorie tradizionali, perché non è un pittore, non è uno scultore, non è un fotografo in senso stretto. È un artista concettuale-materiale che raccoglie tutte queste pratiche in una, nella sua figura di creatore innovativo e originale.
La sua tecnica distintiva consiste nella corrosione e dissoluzione selettiva e controllata dello strato d’argento che trasforma una lastra di vetro in uno specchio.
Questo processo sottrattivo non è distruttivo, ma generativo. Dalla superficie perfettamente riflettente, paradossalmente “vuota”, poiché dipende da ciò che le sta di fronte, Marrama evoca immagini, forme, campi cromatici.
La sua mano non aggiunge colore, ma lo rivela attraverso la trasparenza; non traccia una linea, ma la incide attraverso la corrosione, perché l’artista opera in negativo, come un incisore che agisce sull’anima stessa del riflesso, sulla stessa meditazione.
Le peculiarità di questo linguaggio sono molteplici e avvincenti. In primo luogo, l’uso dello specchio non è mai puramente funzionale, ma diventa l’arena di un complesso gioco tra l’immagine creata dall’artista, l’immagine riflessa dello spettatore e l’immagine riflessa dell’ambiente circostante. L’opera non è mai un oggetto finito e autonomo, ma un dispositivo relazionale, un’entità in perpetua evoluzione che si completa solo nell’atto dell’essere guardata.
In secondo luogo, Marrama gioca magistralmente con il dualismo dato da trasparenza e opacità, da riflesso e visione.
In opere come il poliedro specchiante, le facce corrose permettono di vedere all’interno, mentre quelle intatte riflettono l’esterno, producendo un cortocircuito percettivo che destabilizza le nostre categorie di dentro e fuori, contenuto e contenitore.
La semiotica della sua produzione costituisce una profonda meditazione sulla natura della percezione, dell’identità e del tempo, per cui lo specchio, archetipo della vanità, dell’illusione, del doppio, nelle mani di Marrama, diventa uno strumento di conoscenza.
Dissolvendone l’“anima”, l’artista compie un atto sacrilego e liberatorio, perché uccide la funzione narcisistica dello specchio per trasformarlo in un portale.
L’Autoritratto con Cervello Esposto non è un’immagine macabra, ma una dichiarazione radicale sulla vera identità, che non sta nel volto che lo specchio ci restituisce, ma nel pensiero, nella coscienza che sta dietro l’esteriorità.
Marrama ci invita a “passare attraverso lo specchio”, come Alice, per scoprire che la realtà non è la superficie riflettente, ma lo spazio che si apre al di là.
Il tema dell’ombra e della proiezione è altrettanto cruciale. Impiegando specchi concavi o convessi, o superfici riflettenti non piane, l’artista crea proiezioni luminose che si manifestano sulla parete, come nell’opera con il sole nero che proietta un’aura luminosa. Qui, l’opera si raddoppia, esiste sia come oggetto fisico che come evento luminoso effimero.
È una potente metafora del rapporto tra l’essere e la sua manifestazione, tra la sostanza e la sua emanazione.
Marrama trasforma così la materia in fenomeno, rivelando che l’essenza del reale non è nell’oggetto statico, ma nel dinamico gioco di materia, luce e spazio.
La filosofia che sorregge questa ricerca è di una coerenza e profondità straordinarie, e Marrama incarna l’ideale dell’artista-pensatore, la cui arte non è un prodotto, ma la dimostrazione visiva di una tesi.
La sua visione della vita è ciclica e alchemica: tutto si dissolve per ricombinarsi a un livello superiore di consapevolezza.
Il suo rapporto con l’arte non è emotivo in senso romantico, ma intellettuale e appassionato; la sua passione non si manifesta nell’urlo del gesto, ma nella tensione glaciale e controllata del suo processo, nella dedizione quasi ossessiva con cui persegue la sua indagine. La sua osservazione acutissima si traduce nella precisione scientifica con cui governa la corrosione chimica, trasformando un processo potenzialmente caotico in un atto di creazione perfettamente calibrato.
Vladimiro Marrama è una figura singolare e accattivante nel panorama dell’arte concettuale contemporanea. La sua espressione artistica è un potente antidoto alla superficialità e all’estetismo fine a se stesso.
Attraverso un linguaggio che fonde in modo inedito sapere artigianale, rigore scientifico e profondità filosofica, ci obbliga a riconsiderare le nostre certezze percettive e a interrogarci sulla natura della realtà.
I suoi specchi violati non sono oggetti da ammirare, ma esperienze da vivere, macchine ottiche e mentali che ci sfidano a guardare oltre la nostra immagine, per percepire l’interiorità.
L’artista apre veramente una porta sull’infinito, e lo fa attraverso l’atto più coraggioso di dissolvere la superficie per rivelare l’abisso.
DANIELA MEZZADRI


LA GEOLOGIA DELLE EMOZIONI
L’arte di Daniela Mezzadri è un’indagine coraggiosa, quasi maniacale, sulla fenomenologia della percezione, del sentire, delle emozioni più profonde e autentiche della natura umana.
La sua non è una pittura che replica il mondo, ma una vera e propria enciclopedia visuale, che aggiunge un volume con ogni nuova opera creata, un’enciclopedia che ci racconta il mondo così come diviene, giorno per giorno, emozione dopo emozione, come un sismografo della coscienza umana, capace di registrare ogni minima scossa tellurica dell’emozione, per tradurre tutto in un linguaggio di pura materia, colore e segno.
Daniela Mezzadri è un’artista che ha oltrepassato la rappresentazione per avventurarsi nei territori più profondi e inesplorati della percezione pura, in quello spazio in cui l’immagine non si è ancora cristallizzata in forma riconoscibile, ma rimane magma ribollente di potenzialità dell’inconscio.
Ogni tela è un campo di forze, un’archeologia delle percezioni, in cui strati di colore, incisioni e accumuli materici non raccontano una semplice storia, ma incarnano l’esperienza della vita, nella sua complessità inestricabile e nella sua immediatezza irriducibile, talvolta addirittura brutale.
La visione di Mezzadri non interpreta la realtà come un insieme di oggetti esterni da riprodurre, bensì come un flusso continuo di percezioni impresse sulla lastra sensibile della coscienza.
Il suo approccio alla vita è introspettivo e viscerale, alla ricerca dei segreti dell’inconscio.
Per lei la vera realtà non è quella oggettiva e visibile, ma quella soggettiva, l’universo interiore in cui le emozioni non sono concetti astratti (gioia, dolore…), ma eventi fisici, quasi geologici: eruzioni, fratture, sedimentazioni che parlano di vicissitudini e tormenti, di gioie e tempeste, di solitudini e sconvolgimenti sismici dell’anima.
La sua figura di artista è quella di una speleologa della psiche, che discende con coraggio e senza filtri negli abissi del proprio mondo interiore, portando alla luce frammenti di un paesaggio psichico che, nella sua singolarità, si rivela universale.
Dal punto di vista stilistico, Mezzadri appartiene al mondo dell’arte informale e dell’arte materica, una tradizione che da Dubuffet a Tàpies ha esplorato le potenzialità espressive della materia e del segno di getto. Eppure, la sua interpretazione di questo linguaggio è del tutto personale, tanto che la sua sintassi cromatica è diventata il suo marchio distintivo.
La sua tecnica è un processo di continua costruzione e de-costruzione. La superficie pittorica è un campo di battaglia dove il colore viene applicato con forza, talvolta con violenza, anche al ritmo della musica. E lei non si limita a stenderlo sulla tela, ma lo modella, lo scava. Utilizza impasti densi che creano una topografia accidentata, un bassorilievo dell’anima.
Su questa epidermide materica, Mezzadri incide il segno, un gesto nervoso, quasi calligrafico, che non delinea forme, ma traccia percorsi, libera energie incidendo la materia come un graffito primordiale. Perché il suo non è un atto pittorico, ma un corpo a corpo con la tela per raccontare il mondo delle emozioni.
I suoi stilemi ricorrenti costituiscono gli elementi di una grammatica del colore con cui l’artista ha creato un proprio linguaggio personale, percettivo-emotivo, in cui la stratificazione del colore è la sintassi fondamentale.
Le opere di Mezzadri non si concedono a una visione immediata e superficiale, ma richiedono un tempo di esplorazione e un’attenzione critica e adulta. Sotto uno strato di colore se ne intravede un altro; attraverso una fessura del muro materico emerge una traccia, una linea, rivelando che per Mezzadri l’emozione non è mai un’entità semplice e definita, ma sempre un accumulo di esperienze, di memorie, di cicatrici.
L’artista crea costrutti cromatici che sono un “teatro nel teatro”, con cui isola la scena principale per dirci che ciò che vediamo non è una finestra sul mondo, ma una sezione trasversale della coscienza, l’inquadratura di un evento interiore.
La semiotica della sua produzione è un’affermazione potente della supremazia del sentire sul vedere.
Il messaggio di Mezzadri è una sfida radicale alla nostra abitudine di cercare forme e significati riconoscibili, perciò, le sue opere non devono essere “capite”, ma vissute.
L’artista riesce a trasmutare le emozioni in eventi psicofisici attraverso la sua inconfondibile grammatica del colore. L’accumulo di rossi e neri non rappresenta la rabbia, ma è l’energia primordiale della rabbia coagulata sulla tela. La delicatezza di certi blu e bianchi non descrive la malinconia, ma è la percezione di quell’emozione. Le sue tele ci costringono ad abbandonare il senso classico della vista per attivare lo spirito critico, per sentire la ruvidità, il calore, il peso di un’emozione.
Questa è la filosofia di Daniela Mezzadri: un’indagine fenomenologica sulla natura immediata della percezione, travolta dalle emozioni generate dalla vita quotidiana.
L’artista sembra dirci che prima di ogni nome, di ogni concetto, di ogni accadimento, esiste la pura sensazione.
La sua arte è un tentativo eroico di catturare questo stato nascente della coscienza, questo momento aurorale in cui mondo e Io inconscio non sono ancora distinti, ma sono un unico flusso energetico indifferenziato.
Il rapporto tra la sua arte e le emozioni è di totale e bruciante identificazione, così come la sua passione si traduce nella violenza controllata del gesto, nella carnalità della materia.
La sua lucidità osservativa, invece, si manifesta nella sorprendente maestria con cui orchestra questi apparenti caos, poiché le sue composizioni possiedono un equilibrio dinamico, un ritmo interno, una coerenza cromatica che rivelano una mente non travolta dall’emozione, nonostante la furia formale, ma che sa utilizzare proprio l’emozione come materia per costruire un nuovo ordine estetico.
Nelle opere di Mezzadri emergono forme archetipiche, come pesci, occhi, creature primordiali, che non sono un ritorno alla figurazione, ma la dimostrazione visiva di come, dal magma indifferenziato dell’inconscio, i simboli sorgano spontaneamente, come fosse pura energia.
Non è l’artista che decide di dipingere un pesce, ma è il pesce che affiora dal dipinto. Non è Mezzadri che vuole dipingere un occhio, ma è l’occhio che si manifesta, come un’allucinazione, un fossile dell’anima, una presenza quasi divina del suo inconscio.
Daniela Mezzadri è un’artista di straordinaria profondità e coerenza, una filosofa che pensa direttamente attraverso la materia.
La sua espressione artistica è un antidoto necessario all’anestesia percettiva del nostro tempo, un invito a riscoprire la dimensione fisica, tattile, quasi dolorosa del sentire con l’anima.
Le sue tele non sono oggetti da appendere a una parete, ma esperienze da attraversare, territori accidentati che ci mettono a nudo, costringendoci a confrontarci con il paesaggio spesso selvatico e sconosciuto della nostra stessa interiorità.
Guardare un’opera di Daniela Mezzadri non è semplice contemplazione, ma è un atto di coraggio e di conoscenza di sé.
LEONARDO NAPOLETANO

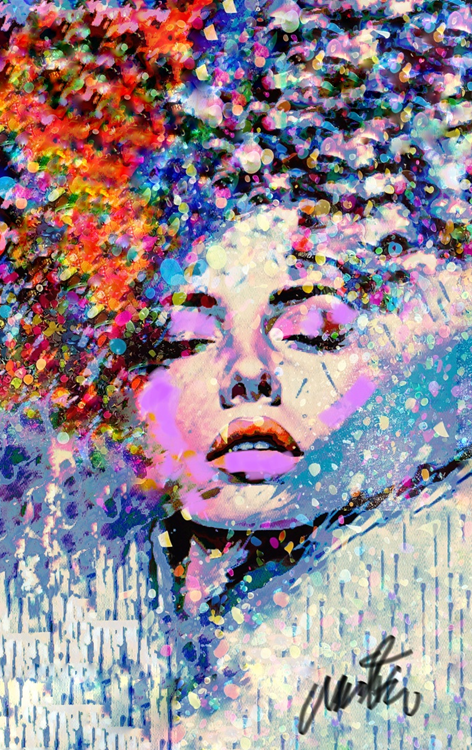
PERCEZIONE FLUTTUANTE
L’arte di Leonardo Napoletano è una vertiginosa immersione nella psicologia liquida del colore.
Il suo lavoro non è pittura in senso tradizionale, ma un atto di trasfigurazione, un processo alchemico che prende l’icona più riconoscibile, cioè il volto femminile, e la dissolve in un universo di luce sfavillante e di riverberi cromatici.
L’arte di Napoletano mette radicalmente in discussione la natura dell’immagine e della percezione nel nostro tempo.
Ogni sua opera è un sogno febbricitante, un’apparizione spettrale che emerge dal flusso incessante di dati visivi, una meditazione filosofica su cosa significhi “vedere” e “sentire” in un mondo dove il confine tra reale e virtuale è diventato irrimediabilmente poroso.
Napoletano concepisce la realtà come una sostanza liquida, un’interferenza, un segnale fluttuante.
Il suo approccio al mondo è quello di un poeta cibernetico: non descrive le cose, ma ne cattura l’aura, la traccia luminosa, l’eco delle emozioni che risuonano nel nostro apparato percettivo.
La sua personalità artistica, riflessa in questa estetica abbagliante e a volte allucinatoria, è quella di un romantico nell’era post-umana, che al centro del suo lavoro pone una profonda nostalgia per la forma umana, per la bellezza classica del volto, per la disciplina del disegno, eppure questa nostalgia è incessantemente minata, perfino violata, dalla consapevolezza che tali ideali di purezza e stabilità non possano più esistere, se non come fantasmi, come echi persistenti nel caos digitale della nostra epoca.
Sul piano stilistico, la produzione di Napoletano può essere definita un impressionismo originale, grazie a una tecnica che inizia spesso con una base figurativa, un disegno concepito quasi come un ritratto, che viene poi sistematicamente assalito, frammentato e arricchito attraverso un complesso processo di stratificazione.
Assistiamo a una sovrapposizione di effetti che insieme imitano e trasfigurano diversi linguaggi pittorici e digitali. Ci sono elementi che richiamano il Puntinismo, dove i punti diventano particelle di luce, “polvere di stelle” che simultaneamente costruisce e dissolve la forma.
Altri effetti generano scabrosità tattile, poi c’è l’elemento del glitch, l’errore, la distorsione del segnale, le linee verticali, le aberrazioni cromatiche, mai nascosti, ma esaltati come parte integrante del linguaggio, come la cicatrice visibile del processo.
I suoi tratti stilistici ricorrenti formano un vocabolario percettivo-emotivo, dove il volto femminile, quasi sempre con gli occhi chiusi o lo sguardo perso in estasi, si erge come archetipo centrale.
Non è un ritratto, ma un’icona dell’interiorità, un simbolo di estasi, di sogno, di trance meditativa.
Questo volto è in costante dialogo o in conflitto con un universo di elementi naturali, come fiori, farfalle, petali, anch’essi fatti di luce, di puro colore, che si fondono in un’unica sostanza cosmica, onirica.
La palette è psichedelica, costruita su toni saturi, luminescenti, spesso acidi: violetti, magenta, gialli elettrici, ciano.
Non sono colori che descrivono il mondo, ma colori che creano dimensioni parallele, stati cromatici che manifestano le emozioni vissute dall’artista nell’atto del dipingere.
La semiotica del suo lavoro articola una potente meditazione sulla frammentazione del corpo e sulla fluidità dell’identità nell’era digitale.
Il messaggio filosofico di Napoletano è una profonda riflessione sulla nostra condizione contemporanea: siamo ancora esseri fisici, o siamo diventati pura informazione, avatar luminosi alla deriva in un cyberspazio emotivo?
Le sue donne che si fondono con fiori e particelle di luce non sono fantasie decorative, ma attuazioni visive di questa dissoluzione dei confini, tra sé e mondo, organico e artificiale, realtà e finzione.
L’artista trasforma la sua grammatica del colore in un veicolo di messaggi profondamente spirituali.
La sua arte dimostra che, paradossalmente, è nel sognante e nell’irreale che si può trovare il percorso verso un’esperienza quasi mistica, un’immersione totale nel flusso della percezione pura, nella ricerca della verità.
È qui che la sua filosofia emerge con maggiore forza, come una forma di misticismo, una visione della vita che cerca la verità nelle sue rappresentazioni più effimere e immateriali.
Le opere di Napoletano diventano icone per un’epoca senza certezze, dove l’unica realtà è l’intensità della sensazione.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di totale immersione sinestetica. Le sue immagini non sono solo da guardare, ma da sentire, sono esperienze cromatiche progettate per indurre nello spettatore uno stato di trance, una sospensione del giudizio razionale, per concedere accesso a un livello di percezione più intuitivo, più emotivo.
La sua passione si traduce nell’esuberanza cromatica, in questa dimensione luminosa che inonda ogni superficie.
Eppure, la sua chiarezza di visione si rivela nella padronanza compositiva, nel perfetto equilibrio tra forma che svanisce e presenza che permane, tra il caos delle particelle e l’ordine segreto che le governa.
Leonardo Napoletano è un artista visionario, un cartografo dei nuovi territori della psiche, che ha forgiato un linguaggio del tutto contemporaneo e straordinariamente evocativo, capace di parlare della nostra condizione esistenziale con una bellezza seducente, quanto inquietante.
Le sue opere sono stati emotivi, istanti dell’essere.
Sono la visualizzazione di cosa significhi sognare, sentire, esistere in un mondo dove la nostra stessa identità è diventata un’immagine luminosa, fragile, e in perpetua, meravigliosa dissoluzione.
MARIO PERROTTA


LA LUCE DELLA PRESENZA
L’arte di Mario Perrotta è un atto d’amore per il mondo, una potente e quasi ostinata affermazione della presenza delle cose e degli esseri in un’epoca che tende alla dematerializzazione e alla superficialità.
Ogni tela di Perrotta è un’indagine fenomenologica sulla luce, intesa non come fenomeno fisico, ma come sostanza rivelatrice che scolpisce e dà vita alla materia.
Perrotta è un artista che rifiuta la freddezza del concetto e l’arbitrarietà dell’astrazione, puntando, invece, la sua ricerca sull’esperienza diretta, sul qui e ora di un paesaggio mediterraneo, di un volto assorto, di una natura morta satura di umori terrestri.
La sua espressione artistica non è una fuga dalla realtà, ma un’immersione nei suoi segreti, uno sforzo per catturarne e restituirne l’intensità percettiva e la risonanza emotiva.
La visione di Perrotta interpreta la realtà come un campo di forze cromatiche e luminose e il suo approccio al mondo ricorda quello di un cantautore o di un poeta che impugna il pennello per celebrare la bellezza del visibile, trovando sublime non tanto eventi eccezionali, ma la meraviglia ordinaria di una piazza al sole, di un corpo sotto una cascata, di un porto al crepuscolo, o la bellezza di barche assopite, cullate dalla marea.
La sua personalità artistica, riflessa in questa solarità, è quella di un umanista mediterraneo, erede della grande tradizione pittorica che, da Cézanne ai Macchiaioli, e attraverso alcune correnti del Post-Impressionismo, ha creduto nella pittura come mezzo di conoscenza sensuale del mondo.
Sul piano stilistico, Mario Perrotta si muove con sorprendente coerenza e maturità in un linguaggio che può essere definito Realismo Espressivo. Alla base del suo lavoro c’è una solida struttura realista, una padronanza del disegno, della prospettiva e dell’anatomia, che conferisce ai suoi dipinti una costruzione credibile e vigorosa.
Eppure, questo realismo di fondo è continuamente trasceso, quasi incendiato, da un uso del colore e della pennellata che si affaccia sull’Espressionismo.
Il colore nelle tele di Perrotta non è mai meramente descrittivo, ma sempre emotivo. La luce non si limita a illuminare, ma costruisce le forme attraverso audaci contrasti di toni caldi e freddi.
La pennellata è vigorosa, tattile, enfatica, i suoi dipinti non sono superfici levigate e pulite, ma superfici vibranti dove l’energia del gesto creativo è palpabile.
Questa sintesi di forma e colore, di costruzione e impulso, è il segno distintivo del suo stile. Si osserva nei suoi paesaggi, dove le rocce o le barche sono definite da ampie, risolute pennellate, come scolpite direttamente nel colore.
Nei suoi ritratti, pur preservando somiglianza e profondità psicologica, il contesto si dissolve spesso in costrutti cromatici quasi astratti o in fondali preziosi, come la foglia d’oro, per sottolineare che la figura abita non lo spazio fisico, ma anche una dimensione interiore e simbolica.
I tratti stilistici ricorrenti si coagulano in un vocabolario visivo che celebra la vita nella sua pienezza, così come il paesaggio mediterraneo, in particolare quello di Paola in Calabria, costituisce un tema centrale, non come immagine da cartolina, ma come organismo vivente.
Le sue piazze assolate, i vicoli fioriti, i mari… non sono luoghi generici, bensì spazi carichi di una storia e di una luce specifica, catturati con un’intensità quasi tattile.
Altrettanto ricorrente è l’omaggio di Perrotta a San Francesco di Paola, al quale il pittore è devoto.
La figura umana, soprattutto quella femminile, è l’altra colonna portante della sua ricerca.
Mai oggetto idealizzato, la donna appare come una presenza carnale, colta in momenti d’intimità, di abbandono sensuale, come nell’opera della donna sotto la cascata, o di riflessione malinconica.
La natura morta, infine, è trattata con una sontuosità quasi barocca, quasi un’ode alla fertilità e all’abbondanza della terra.
La semiotica del suo linguaggio espressivo forma un inno alla gioia dell’esistenza, una gioia che non esclude la malinconia, ma la integra in una visione più ampia e complessa, ricca di significati. E il messaggio di Perrotta è una riscoperta del valore della presenza.
In un mondo virtualizzato, i suoi dipinti ci ricordano la fisicità dei luoghi, la sensualità dei corpi, il sapore della frutta, i profumi dell’aria. Guardando le sue piazze, si sente il calore del sole sulle pietre.
Osservando il suo mare, si percepisce l’odore del sale e del legno bagnato. Contemplando i suoi ritratti, si entra in un dialogo silenzioso con un’anima.
Ecco la filosofia di Perrotta: una fenomenologia della presenza che non trova senso in astrazioni metafisiche, ma nell’intensità dell’esperienza di vita.
Perrotta sembra dirci che la via della conoscenza e della felicità si percorre con una piena e consapevole adesione al mondo che ci circonda. La sua arte è un esercizio di attenzione, un invito a “essere qui, ora”, perché il rapporto tra la sua arte e l’emozione è diretto, luminoso, generoso.
La sua passione si traduce nell’esuberanza del colore e nel vigore della pennellata; la sua lucida osservazione, d’altro canto, esplode nella solidità delle composizioni, nella sua capacità di cogliere l’essenza di un luogo o di uno sguardo con pochi tratti decisi.
Non c’è conflitto tra passione e controllo, ma piuttosto una felice e matura integrazione.
Mario Perrotta è un pittore di rara forza, autentico, un artista che ha forgiato un linguaggio personale e potente, fondando nella grande tradizione, eppure capace di parlare con immediatezza al nostro tempo.
La sua arte è un balsamo per l’anima, una chiamata a quella dimensione fisica ed emotiva dell’esistenza che la nostra civiltà è incline a trascurare.
Le sue tele non sono semplici immagini, ma luoghi dove la luce brucia più calda, i colori si fanno più intensi, e la vita diventa più piena.
E abitare, anche solo per un istante, dentro questi luoghi di visione è un’esperienza che arricchisce e rigenera.
SERENA PESCARMONA


SCRIVERE CON LA LUCE
L’espressione artistica di Serena Pescarmona è un’audace e luminosa ridefinizione dei confini della pratica artistica, poiché ci troviamo di fronte a una creatrice che ha deliberatamente abbandonato gli strumenti tradizionali della pittura, quali pennelli, spatole e pigmenti, per intraprendere un cammino radicalmente innovativo, dove l’arte non è più applicazione del colore su una superficie, ma un atto di sottrazione, un’incisione che rivela una luce interiore.
La sua pratica, dunque, non è né pittura né scultura, tanto meno mero artigianato, bensì una forma di cromo-grafia, una scrittura di luce che trasforma materiali umili come il legno, o inerti come il vetro, in portali verso una dimensione onirica, mitica e profondamente metafisica.
Pescarmona non è interessata a replicare ciò che vede, ma a interpretare la realtà come un archetipo da evocare, infatti il suo approccio al mondo è quello di un’alchimista moderna, che non mescola elementi chimici, ma trasmuta la materia opaca in sostanza luminosa.
La sua personalità artistica, riflessa in questa singolare fusione di maestria tecnica e sensibilità poetica, è, al tempo stesso, quella di un’inventrice e di una sognatrice.
L’invenzione del suo sistema di retroilluminazione a LED, da lei brevettato, non è un mero dettaglio tecnico, ma un atto programmatico, una dichiarazione filosofica che è già arte e parte integrante della sua espressione.
Rivela una mente che non si accontenta degli strumenti esistenti, ma forgia nuovi strumenti capaci di dare piena forma alla sua visione interiore.
Lo stile di Pescarmona è immediatamente riconoscibile, proprio grazie alla sua tecnica singolare.
Il suo strumento prescelto è l’incisore e il suo gesto sta a metà tra il disegno e la scultura a bassorilievo.
Sul legno, l’incisione scava nella superficie, creando solchi che dialogano con la venatura naturale del materiale, spesso lasciata volutamente a vista. Questi solchi vengono poi riempiti di colore, in un processo che ricorda l’intarsio, ma eseguito con una libertà e una morbidezza del tutto contemporanee.
Sul vetro, il processo è ancora più radicale, perché qui l’incisione diventa un graffio, una ferita che “cattura” la luce. È in questo contesto che il suo sistema di retroilluminazione smette di essere un accessorio per diventare elemento costitutivo dell’opera.
La luce non illumina l’opera dall’esterno, ma nasce al suo interno, incanalandosi attraverso i segni incisi e facendoli letteralmente incendiare, trasformando il disegno in apparizione, in una meraviglia quasi olografica.
I suoi tratti stilistici ricorrenti formano un vocabolario di simboli e di atmosfere cariche di profonda risonanza emotiva.
I suoi soggetti appartengono al regno della fiaba, del mito e del sogno: alberi della vita dorati, amanti sotto la luna, notturni incantati, fiori fantasmagorici.
C’è un distanziamento voluto dalla cronaca del quotidiano, a favore di un immaginario universale, senza tempo, dove la notte è il suo palcoscenico prediletto. Non una notte paurosa, ma magica, uno spazio che è, al tempo stesso, intimo e cosmico, costellato di stelle, lune e luci artificiali che non sono mai fredde, ma sempre piene di calore umano e di mistero.
Il suo ventaglio di colori, particolarmente nelle opere retroilluminate, è composto dalla stessa luce dei led: blu elettrici, violetti ultraterreni, rosa spettrali che non sono pigmenti, ma frequenze luminose che agiscono direttamente sul nostro apparato percettivo, scavalcando il filtro della razionalità.
La semiotica della sua produzione costituisce una potente meditazione sul dualismo di materia e spirito, visibile e invisibile.
Il messaggio filosofico di Pescarmona è di una coerenza cristallina, sulla vera essenza delle cose, che non abita nella loro superficie opaca, ma nella luce che “le cose” contengono, luce che solo l’atto artistico, come un gesto d’amore, può rivelare.
L’artista riesce a trasformare la materia in un simbolo vivente di questa idea. Allora, il legno, organico e caldo, legato alla terra, diventa il supporto di narrazioni celesti e oniriche; il vetro, freddo, trasparente, quasi invisibile, diventa la tela su cui si manifestano le presenze più abbaglianti.
L’opera colma di orologi e clessidre è un’allegoria vertiginosa del Tempo, non concepito come successione lineare, ma come groviglio di istanti, un “eterno presente” illuminato da una luce azzurra, il colore della meditazione e dell’infinito.
Qui la sua filosofia emerge con maggior forza, perché la sua arte diventa un tentativo di arrestare l’incantesimo, di dare permanenza a quel momento fugace di meraviglia che proviamo davanti a un cielo stellato, a un amore in fiore, a un fiore nell’oscurità.
La sua non è un’arte della rappresentazione, bensì della presentazione: non ci mostra semplicemente un’immagine dell’incanto, ma ci pone direttamente nella sua presenza.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è immediato, quasi magico. Le sue opere non suscitano semplicemente un sentimento, ma creano un’atmosfera, un ambiente emotivo in cui lo spettatore è invitato a entrare e perdersi.
La sua passione si traduce nell’infinita pazienza del gesto incisorio, un atto meditativo, quasi rituale, così come la sua lucidità si rivela nella precisione del segno grafico e, soprattutto, nell’intelligenza ingegneristica con cui ha piegato la tecnologia – in questo caso, i LED – al servizio della poesia.
Serena Pescarmona è una figura unica e visionaria nel panorama dell’arte contemporanea, una filosofa del nostro tempo, che ha avuto il coraggio di inventare non solo uno stile, ma un intero linguaggio, un nuovo modo di concepire l’opera d’arte, come oggetto luminoso, come fonte attiva di esperienza percettiva ed emotiva. Le sue creazioni sono talismani moderni, icone che ci ricordano la nostra capacità di sognare, di meravigliarci, di trovare luce anche nel buio più profondo.
In un mondo sempre più accelerato e disincantato, l’arte di Pescarmona è un invito a fermarsi, a contemplare e a riscoprire che la magia non è una fuga dalla realtà, ma la sua verità più intima e radiosa.
PREDA (DANILO PRETO)


L’ARCHEOLOGIA DEL FRAMMENTO
L’arte concettuale di Danilo Preto, in arte PREDA, è un’operazione di chirurgia concettuale sul corpo della cultura e della memoria, uno scavo nella coscienza della verità del nostro tempo.
PREDA è, al tempo stesso, un demiurgo iconoclasta e un generatore che riformula la realtà, un pensatore che agisce sui resti del nostro immaginario collettivo e personale, per compiere un gesto radicale di decostruzione e successiva ricomposizione.
Ogni sua opera obbedisce ai rigorosi, eppure irriverenti, dettami del suo Manifesto e costituisce un’indagine filosofica sulla natura effimera del significato, sulla violenza latente in ogni atto di preservazione e, paradossalmente, sulla necessità vitale di creare nuovi ordini dal disordine.
PREDA non produce oggetti, ma orchestra processi di metamorfosi, costringendo lo spettatore a confrontarsi non tanto con un’opera finita, ma con la traccia di una trasformazione, spesso brutale, sempre intellettualmente provocatoria.
La sua arte inscena una profonda rottura con mode e abitudini, forzando il pensiero critico al ragionamento.
La visione artistica di PREDA interpreta la realtà come un palinsesto saturo di segni, un archivio sovraccarico di narrazioni che hanno perso la loro vitalità.
Il suo approccio è quello di un archeologo del presente, che non scava nella terra, ma nei detriti della nostra cultura visiva e affettiva: le opere d’arte altrui, i feticci dell’infanzia, i ricordi personali, tutto viene distrutto per assumere nuova forma e nuova identità.
La sua personalità artistica fonde quella del satiro spietato con quella del moralista appassionato.
C’è un’ira fredda, controllata, nel suo gesto di frantumare, triturare, polverizzare oggetti, un’ira rivolta contro l’ipocrisia dei valori imposti, la mercificazione dell’arte, la banalizzazione dell’educazione. Eppure, da questa furia distruttiva emerge sempre un tentativo di rinascita, una “orgia di ripopolamento” che non rivela un’anima nichilista, ma una animata da una speranza disperata, quasi tragica.
Lo stile di PREDA è eminentemente concettuale, fondato su un processo che si potrebbe descrivere come metabolismo artistico. La sua tecnica sta nell’intelligenza di orchestrare la distruzione e la ricontestualizzazione.
Che il punto di partenza sia un’opera d’arte, un gadget giocattolo o un peluche, l’oggetto subisce una violenza fisica, letteralmente “trattato secondo i canoni del Manifesto”, spogliato della sua fisicità originaria, ridotto a frammenti, detriti, una sorta di DNA culturale polverizzato.
Il materiale generato attraverso questo atto distruttivo viene poi contenuto, archiviato, quasi mummificato, in nuovi contenitori: vasi di vetro, teche, bottiglie a forma di teschio, cornici.
Il contenitore diventa parte integrante dell’opera, un’urna dell’era postmoderna che non conserva le ceneri di un corpo, bensì i resti di un’idea.
I suoi dispositivi stilistici ricorrenti funzionano come strumenti di questa filosofia visiva: l’atto della frammentazione è il gesto semiotico centrale, una negazione dell’aura dell’opera d’arte, la desacralizzazione del feticcio, la riduzione di ogni narrazione complessa alla sua essenza materiale.
Il contenimento in un recipiente trasparente costituisce l’atto successivo, quello di archiviazione e di “quasi-scientifica” esposizione. L’oggetto non è più accessibile nella sua funzione originaria, ma diventa una reliquia, un esemplare da analizzare.
La preservazione di un frammento leggibile, come un pezzo di scontrino nella marmellata, o la sagoma riconoscibile di un peluche in Fidelio, non è un’affettazione ma una necessità crudele.
È l’ancora che lega il nuovo caos all’ordine precedente, la traccia che ci permette di misurare la distanza tra ciò che era e ciò che è diventato.
La semiotica di PREDA costituisce una feroce critica della nostra società dello spettacolo e del consumo.
Nella serie delle marmellate, l’atto di “introdurre nei vasetti” le opere di altri artisti funziona da metafora potente e ambigua: un omaggio compiuto attraverso la distruzione, una storicizzazione realizzata per assassinio simbolico.
È un gesto che interroga radicalmente le nozioni di paternità artistica e di valore.
Liberiamo i Pampìni recita una critica di spietata chiarezza, la polverizzazione del gadget giocattolo, feticci di un consumismo che manipola le menti infantili, diventa un atto di purificazione, un esorcismo contro la banalità del male educativo.
La bottiglia a forma di teschio colma di questi resti colorati funge da ricordo della fine della vita, del nostro tempo, un teschio ricolmo dei detriti tossici della nostra cultura pop, metafore delle intelligenze impoverite formate da tali pedagogie.
È qui che la filosofia di PREDA rivela la sua piena complessità. Il suo lavoro non è una mera denuncia, ma un’indagine sulla percezione e sulla memoria emotiva.
Opere come Fidelio o È LA VITA BABY mostrano un nucleo profondamente personale e sentimentale.
In Fidelio, la distruzione dei “nemici” e il trionfo dell’amore, incarnato dal peluche intatto, si dipana come una parabola quasi fiabesca, la cui tenerezza stride con potenza con la violenza del processo.
In È LA VITA BABY, il tronco d’albero che avvolge, e quasi stritola, la pietra è una scultura di uso comune, naturale, che diventa allegoria di simbiosi e conflitto nelle relazioni umane, di “abbracci e abbandoni”, un’opera dove l’emozione non è descritta, ma incarnata nella stessa materia.
PREDA ci obbliga a riflettere sul nostro rapporto affettivo con oggetti e immagini. Cosa resta di un’opera d’arte una volta ridotta a frammenti? Cosa resta di un ricordo d’infanzia una volta che il suo feticcio è stato distrutto?
La risposta dell’artista sembra essere che, inevitabilmente, qualcosa permane, non la forma, non l’immagine, ma un’energia, un colore, una sostanza da toccare, annusare, pesare.
Un’emozione.
La sua arte è un tentativo di distillare questa pura essenza emotiva, liberandola dalla prigione della sua forma originaria.
Il suo rapporto con l’arte è quello di un amante passionale e crudele, che, per possedere l’anima dell’amato, è costretto a distruggerne il corpo.
PREDA è una delle figure più radicali e intellettualmente intransigenti dell’arte concettuale italiana, la cui espressione artistica è sia un pugno nello stomaco sia una carezza alla mente.
Con un linguaggio che fonde la freddezza della procedura concettuale a una carica emotiva sotterranea, a volte quasi insopportabile, ci obbliga a confrontarci con il cimitero di segni e di oggetti che ci circonda, e a chiederci cosa valga davvero la pena di conservare.
La sua non è un’arte per gli occhi, ma per il pensiero, e il suo messaggio ultimo è, forse, di speranza: solo attraverso la coraggiosa decostruzione del passato e del presente possiamo sperare di sgombrare lo spazio per un futuro dotato di un significato nuovo, più autentico.
ENRICA PIRISI


GEOMETRIE DELL’ANIMA
L’espressione artistica di Enrica Pirisi è un’indagine sofisticata e, al tempo stesso, vertiginosa, sulla percezione, un’esplorazione filosofica articolata attraverso la sintassi della sua pittura.
Ogni tela diventa un campo di tensione dialettica, un luogo in cui la fredda lucidità della geometria si scontra e si fonde con il calore organico della figura, in cui la stasi della forma classica è travolta dal dinamismo vorticoso del colore.
Pirisi non è un’artista che si accontenta di rappresentare il mondo; piuttosto, lo decostruisce e ne ricostruisce le strutture visive, costringendo lo spettatore a un esercizio di visione attiva, a un interrogativo costante su cosa sia reale e cosa proiezione, cosa corporeo e cosa puro ritmo.
La visione artistica di Pirisi interpreta la realtà come un sistema complesso di strutture, visibili e invisibili.
Il suo approccio al mondo è quello di un’architetta della percezione, consapevole che la nostra esperienza del reale non è mai un flusso caotico, ma è sempre mediata da griglie, circostanze, strutture mentali che proiettiamo sulle cose per comprenderle.
La sua personalità artistica, riflessa in questa continua oscillazione tra rigore analitico e abbandono lirico, è quella di un’intellettuale che dialoga con l’intera storia dell’arte, dalla statuaria classica alle avanguardie del primo Novecento, fino al Surrealismo, non per citarla, ma per interrogarla, per metterne in crisi le certezze e forgiare un linguaggio nuovo, ibrido e profondamente contemporaneo.
Sul piano stilistico, l’opera di Pirisi si fonda su una sintesi originale tra Figurazione Metafisica e Astrazione Geometrico-Lirica. La sua tecnica è impeccabile, caratterizzata da una superficie liscia, quasi smaltata, in cui la pennellata spesso scompare, sottolineando la preminenza del concetto e del disegno sulla materialità.
La sua mano può essere precisa e quasi iperrealista nel delineare l’anatomia di un corpo o la superficie di una scultura, così come può essere audace e libera nel costruire i vortici cromatici e i campi geometrici che costituiscono l’ambiente, o meglio, la dimensione, in cui queste figure sono immerse.
Questa coesistenza di registri apparentemente opposti è la sua firma distintiva.
In un’opera come il ritratto del Bacco di Michelangelo, la perfezione classica della scultura è inscritta in una griglia geometrica quasi ottica che ne frammenta la percezione e la trasforma da oggetto storico a icona moderna, sospesa in uno spazio puramente mentale.
Altrove, come nel ritratto della donna dalla pelle ciano, l’eleganza quasi rinascimentale del profilo è giustapposta a elementi puramente astratti: cerchi rossi fluttuanti nello spazio come pensieri o pianeti, che introducono una nota di mistero e dissonanza.
I suoi tratti stilistici ricorrenti formano gli elementi di un vocabolario filosofico-visivo, in cui la figura umana, spesso femminile o androgina, e talvolta citazione diretta della statuaria classica, costituisce il centro gravitazionale della sua indagine.
Non è mai un semplice ritratto, ma un archetipo, un’idea platonica dell’umanità colta in uno stato di sospensione contemplativa.
Lo sfondo non è mai un semplice contesto, ma un co-protagonista attivo: che sia una griglia di forme geometriche, una costellazione di linee e cerchi che richiama l’Optical Art, o un vortice di colori che evoca visioni psichedeliche o campi di forza futuristi, lo spazio attorno alla figura non è un vuoto da riempire, ma una struttura energetica che interagisce con la figura, la contiene, la definisce e a volte minaccia di dissolverla.
Il vortice, in particolare, funziona come simbolo potente: del tempo, del pensiero, dell’influsso inarrestabile delle emozioni, dell’energia cosmica contrapposta all’apparente calma e pienezza del corpo.
La semiotica dell’opera di Pirisi è una profonda riflessione sul rapporto tra l’Io e il Mondo, tra la coscienza individuale e le strutture universali, che siano geometriche, sociali o cosmiche. Il messaggio non è mai didascalico, ma emerge dalla tensione visiva.
L’artista sembra chiederci: chi siamo, al di là delle griglie e dei cerchi in cui siamo iscritti? Siamo entità autonome, o siamo definiti dalle strutture che ci circondano?
La danzatrice, le cui forme si fondono con campi astratti di colore, diventa una metafora folgorante di questa domanda: il corpo che si dissolve in puro ritmo, l’individuo che si perde nell’energia universale della danza.
Qui, la filosofia dell’artista rivela con massima chiarezza come la sua arte sia un’indagine sulla natura della coscienza, intesa come punto di intersezione tra ordine e caos.
La sua visione della vita sembra suggerire che l’esistenza umana è un costante tentativo di trovare un equilibrio tra la nostra aspirazione alla forma, alla stabilità, alla definizione, come la figura classica, la geometria, e la consapevolezza di essere immersi in un universo dinamico, insondabile, vertiginoso, come il vortice.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è intellettuale e distillato.
La passione non è nell’urlo del gesto, ma nella vertigine controllata del vortice, nella scelta audace delle giustapposizioni cromatiche, come, per esempio, i blu freddi contro i rossi caldi, nella tensione quasi palpabile tra la figura statica e lo sfondo dinamico.
La sua lucida osservazione si traduce nel rigore quasi matematico delle composizioni, in un’intelligenza visiva che orchestra ogni elemento con impeccabile precisione.
Enrica Pirisi è un’artista di rara profondità intellettuale e straordinaria maestria tecnica, la cui arte è un affascinante ponte tra la grande tradizione figurativa e le più radicali esplorazioni astratte del Novecento, eppure la sua sintesi è così personale da generare un linguaggio del tutto nuovo.
Le sue tele non sono immagini da consumare passivamente, ma enigmi visivi, macchine-pensiero che ci invitano a riflettere sui nostri modi di percepire il mondo e di situarci al suo interno.
In un’epoca di facile sentimentalismo e di caos informale, il suo richiamo all’ordine, alla struttura, al pensiero, anche quando ci conduce sull’orlo delle vertigini, costituisce un atto di coraggio e di profonda, necessaria intelligenza.
ENRICO PIZZOLI


LA CARTOGRAFIA DELLA PSICHE
L’arte di Enrico Pizzoli non è una finestra sul mondo, ma una sezione della coscienza.
Ciascuna sua tela è una mappa geologica dell’interiorità, un sismografo che registra le più sottili vibrazioni del pensiero e dell’emozione, traducendole in un linguaggio di pura traccia, strato e colore.
La sua è un’arte che ha radicalmente abbandonato la mimesi per intraprendere un’indagine ben più ardua e necessaria: quella della struttura della percezione. Pizzoli non dipinge ciò che si vede, ma l’atto stesso del vedere, del sentire, del ricordare, colto nel suo divenire, nella sua simultaneità caotica e meravigliosa.
Le sue opere sono palinsesti dell’anima, dove ogni strato è un ricordo, ogni graffio un’intuizione, ogni tonalità una febbre di sensazione.
La visione artistica di Pizzoli non interpreta la realtà come un repertorio di forme stabili, ma come un campo energetico, una rete di connessioni infinitamente complessa, di qui, il suo approccio al mondo, che è quello di un cultore di fenomeni, che sa che l’esperienza non è un’immagine nitida, ma un accumulo di tracce, un groviglio di impressioni passate e presenti.
La sua personalità artistica, riflessa nel suo linguaggio, che è quasi un rituale di addizione e sottrazione, è quella di un archeologo dell’istante, uno scriba monastico dell’era informale, che non copia testi, ma trascrive il flusso ininterrotto della coscienza.
Nel suo lavoro, c’è una coesistenza di abbandono quasi automatico e un controllo tagliente, una danza tra caos e ordine che diventa la metafora della vita mentale.
Sul piano stilistico, l’opera di Pizzoli affonda le radici nell’Espressionismo Astratto e nell’Art Brut, ma li trascende in una sintesi altamente personale che potremmo definire “astrazione neurologica”.
La sua tecnica è quella della stratificazione ossessiva, meditativa, fatta di graffi, segni, colore.
La superficie non è mai un punto di partenza neutro, ma un campo che viene lavorato, vissuto, quasi consumato, dove incontriamo fondi cromatici, a volte tenui e polverosi come affreschi antichi, a volte vibranti e densi, sui quali l’artista interviene con un gesto grafico compulsivo, un reticolo di linee, cerchi, scarabocchi sovrapposti in strati quasi inestricabili.
Non è un disegno che definisce la forma, ma una traccia che registra l’energia, il movimento, la traiettoria del pensiero.
L’uso di tecniche miste, quali pittura, inchiostro, matite, pastelli o grafite, esalta questa dimensione polifonica e stratificata.
I tratti stilistici ricorrenti funzionano come elementi di un lessico filosofico-percettivo, dove il cerchio, o la sua iterazione quasi cellulare, è l’atomo fondamentale del suo universo – non la forma platonica perfetta, ma un’entità organica, un nucleo, una cellula, un mantra visivo, il battito primordiale da cui sorge la complessità.
La linea, lo scarabocchio, costituisce il secondo elemento cruciale: è il pensiero in movimento, l’impulso nervoso, la connessione sinaptica, la traiettoria errante della memoria.
A volte queste linee si coagulano in griglie distorte, suggerendo un tentativo d’imporre un ordine, una struttura razionale a un flusso altrimenti caotico.
Spesso, l’opera diventa un “dipinto nel dipinto”, una potente dichiarazione metalinguistica, la coscienza che osserva se stessa, la percezione che incornicia la percezione, trasformandosi in meta-comunicazione.
La semiotica della sua pratica costituisce una profonda indagine sulla natura della memoria e del tempo.
Il messaggio di Pizzoli è che il presente non esiste come istante isolato, ma è sempre denso del passato che lo ha generato. Perché ciascuno di noi fa, pensa, crede ciò che la storia e la memoria vi hanno iscritto dentro.
Le sue tele visualizzano proprio questa nozione. Ciò che vediamo in superficie è solo l’ultimo strato di un processo, eppure, è la presenza invisibile, o semi-visibile, degli strati sottostanti a conferire all’opera la sua profondità e la risonanza emotiva.
L’artista riesce a trasformare il colore in tempo solidificato.
Le sue opere non vanno semplicemente guardate, ma “lette” in profondità, come uno scavo archeologico.
L’emozione che trasmettono non è un sentimento semplice e immediato, ma una sensazione complessa di densità, di storia, di vita accumulata. È la vertigine scaturita dall’osservare dall’interno un cervello che pensa o un cuore che avverte sentimenti.
La sua filosofia è un’estetica della complessità che rifiuta ogni forma di semplificazione, in una visione della vita che sembra suggerire che l’essere non è un’entità statica, ma un processo, una rete, un ecosistema in perpetuo, dinamico equilibrio e la sua arte ne è la rappresentazione più fedele.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è segnato da una sincerità che sfiora il brutale. Non c’è mediazione, non c’è abbellimento e la passione sta nel gesto ossessivo, nella febbre del segno che satura ogni millimetro della superficie.
La sua osservazione cristallina, d’altro canto, si manifesta nella straordinaria intelligenza strutturale con cui orchestra questo parossismo, creando composizioni che, nonostante l’estrema densità, non collassano mai nel caos, ma mantengono una tensione, un ritmo, una coerenza interna quasi musicale.
Enrico Pizzoli è un artista di straordinaria integrità e profondità, un filosofo che ha scelto la pittura come strumento d’indagine sulla coscienza, la cui arte offre un antidoto necessario alla cultura dell’immagine istantanea, piatta e facilmente consumabile.
I suoi pezzi sono oggetti difficili, esigenti, che richiedono tempo e attenzione, ma che ci ricompensano con un’esperienza percettiva ed emotiva di rara intensità, perché non forniscono risposte, ma ci costringono a chiederci cosa sia la realtà, se non l’infinita rete di tracce che lascia dentro di noi.
Guardare un’opera di Pizzoli significa immergersi, intraprendere un viaggio fino al vortice centrale del sentire e della realtà più vera e autentica che esista.
SIMONA SARAO


IL LINGUAGGIO DELL’ANIMA
L’espressione artistica di Simona Sarao è un’affermazione coraggiosa della libertà espressiva come strumento d’indagine esistenziale. Analizzare il suo linguaggio cromatico non significa seguire un percorso lineare, ma avventurarsi in un arcipelago di stati emotivi, dove ogni tela è un’isola a sé, con un proprio clima, una propria luce e un proprio idioma distintivo. Molti mondi in un unico universo.
Ci troviamo dinanzi a un’artista che rifiuta la gabbia dorata di uno stile univoco per rivendicare il diritto, e forse il dovere, di modulare la propria voce pittorica a seconda dell’urgenza del racconto interiore.
La sua è una pittura-diario, di un’artista-cronista dell’anima che registra, con uguale onestà e intensità, la desolazione della solitudine e l’eruzione della gioia, la tenerezza dell’intimità e la violenza del ricordo.
La sua coerenza, profonda e inattaccabile, non si trova nella forma, ma nell’autenticità dello sguardo e nell’interrogazione incessante su cosa significhi essere al mondo.
La visione artistica di Sarao interpreta la realtà come un’esperienza soggettiva ed emotiva e il suo rapporto con il mondo non è di chi cerca di catturarne l’aspetto oggettivo, ma di chi si sforza di rendere visibile il proprio modo di sentire il mondo.
La sua personalità artistica, riflessa in questa polifonia stilistica, è quella di una nomade dello spirito, un’esploratrice che non teme di attraversare paesaggi emotivi contrastanti. Non a caso, il suo lavoro è segnato da una totale assenza di filtri o compiacimenti estetici. Al contrario, c’è una disarmante vulnerabilità, una volontà di mettersi a nudo attraverso la pittura, atto che è, in fondo, di grande forza e generosità.
Sul piano stilistico, questa ricerca si traduce in una pluralità di linguaggi che l’artista domina con notevole disinvoltura. Troviamo una vena di Espressionismo Astratto, potente e materico, in opere come la grande tela dominata dai gialli e dai viola, dove il colore si emancipa da ogni vincolo figurativo e diventa pura energia, steso in strati densi e sovrapposti che generano una profondità vibrante, quasi musicale.
È la rappresentazione di uno stato d’animo puro, un’immersione nel colore come esperienza totalizzante.
All’estremo opposto dell’astrazione si colloca una Figurazione Lirica e Simbolista. L’immagine della coppia nel letto, resa interamente in gradazioni di blu, è un’icona dell’intimità pervasa da una tenerezza struggente.
La pennellata, pur rimanendo visibile e materica, si piega alla necessità di definire la forma, creando un’atmosfera onirica, quasi acquatica, come se l’amore fosse un rifugio, un’isola protetta dal mondo esterno.
A questo registro appartengono opere come il paesaggio desolato con l’albero spoglio o quello con il cielo infuocato. Non sono descrizioni di luoghi reali, ma paesaggi dell’anima, potenti metafore della solitudine, della perdita o del dramma incombente.
Infine, emerge un linguaggio che potremmo definire Concettuale-Materico, nel lavoro in cui un frammento di muro in mattoni affiora dall’intonaco scrostato, una potente allegoria della memoria, della storia, di ciò che resiste sotto la superficie del presente, e anche della verità, nascosta dallo strato superficiale delle cose, dalle facciate, dalla propaganda.
L’inserimento di oggetti reali, come una foglia o una stella marina su fondi pittorici astratti, costituisce un altro gesto di straordinario peso concettuale. È l’irruzione del concreto nell’astratto, di frammenti di esperienza vissuta nel flusso della pittura, un mezzo per indagare il rapporto tra arte e realtà, tra memoria e presente.
I tratti stilistici ricorrenti diventano gli strumenti di questo vocabolario emotivo, dove Sarao dimostra una straordinaria sensibilità per l’essenza.
Che sia nella scabrosità di un muro, nella densità di un impasto o nella delicatezza di un prato fiorito, la superficie delle sue opere è sempre viva, vibrante, come a sollecitare non solo la vista, ma anche il tatto.
La sua palette di colori è radicalmente emotiva e antinaturalistica: i rossi sono passionali e a volte violenti; i blu introspettivi e malinconici; i gialli esplosioni di gioia; le terre evocano attaccamento ai valori e storia.
La semiotica della sua produzione è una meditazione sul dualismo dell’esperienza umana: gioia e dolore, presenza e assenza, comunità e solitudine, costruzione e rovina.
Il messaggio filosofico di Simona Sarao è una lucida e coraggiosa accettazione di questa complessità.
Le sue opere non offrono né facili risposte né consolazioni a buon mercato.
Il prato fiorito, con la sua esuberanza quasi infantile, non nega l’esistenza del paesaggio desolato sotto il cielo rosso, così come l’intimità della coppia non cancella la realtà del muro che ci separa gli uni dagli altri.
L’artista ci mostra che tutte queste realtà coesistono, dentro e attorno a noi.
Lei riesce a trasformare il colore in un’affermazione filosofica per cui l’esistenza è un tessuto di contraddizioni, e la bellezza non significa negarle, ma abbracciarle per concedere loro una forma.
La sua filosofia è una forma di esistenzialismo empatico, una visione della vita che non colloca il senso in un ordine superiore, ma nell’intensità del singolo istante, nella pienezza di ogni emozione, sia essa positiva o negativa.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di totale e trasparente onestà. La sua pittura è un atto di testimonianza, e la passione si traduce in una gestualità libera e a volte quasi violenta.
La sua acutissima lucidità di osservazione, d’altro canto, si rivela nella capacità di creare immagini simboliche di straordinaria forza, icone che, pur nate da un’esperienza personale, parlano un linguaggio universale.
Simona Sarao è un’artista di rara sensibilità e di profondo coraggio intellettuale. La sua arte è un viaggio commovente e spietato attraverso i territori dell’anima umana.
Un’artista che reinventa, ogni volta, il linguaggio necessario per raccontare l’indicibile.
Le sue tele sono frammenti di un discorso interiore che si fa dialogo universale, specchi in cui ogni spettatore può riconoscere un pezzo della propria storia, una sfumatura della propria sensibilità.
In un mondo che esige costantemente coerenza ed eroi, l’arte di Sarao è un inno necessario e liberatorio alla complessità, alla contraddizione e alla fragile, meravigliosa incoerenza dell’essere umano.
MASSIMILIANO SCIUCCATI


IL GRIDO E LA CENERE
Il linguaggio cromatico di Massimiliano Sciuccati è un’esplosione, un grido di colore che squarcia il silenzio, un’affermazione feroce e incontenibile di vitalità che si manifesta attraverso il corpo, il volto e, soprattutto, la capigliatura incandescente di icone femminili.
Eppure, sotto questa superficie parossistica di energia, sotto la detonazione di rossi, blu e gialli iridescenti, si cela un’anima crepuscolare, una profonda meditazione sulla caducità e sulla memoria, incarnata in un gesto alchemico di rara forza concettuale e filosofica nell’esplorazione dell’identità umana: l’uso della cenere dei suoi sigari come pigmento.
L’arte di Sciuccati è un’arte della contraddizione, un’estetica del contrasto in cui l’istante estatico della vita e la residua polvere della sua combustione non si negano, ma coesistono in una tensione dialettica che costituisce la vera, originale firma filosofica dell’artista.
Sciuccati concepisce la realtà come un evento energetico in perenne divenire, dove la verità si nasconde dietro e sotto la superficie. Non gli interessa descrivere l’apparenza, ma catturare l’aura, l’emanazione, la vibrazione di un’emozione al suo culmine, la vera essenza.
La sua personalità artistica è quella di un creatore che vive agli estremi, un espressionista vulcanico, che aggredisce la tela con una gestualità quasi selvaggia, ma anche un alchimista malinconico, che raccoglie con pazienza i resti di un piacere consumato, come i suoi sigari, per esempio, per trasmutarli in arte.
Questo dualismo, tra azione esplosiva e riflessione rituale, è la chiave per comprendere la sua complessa poetica.
Sul piano stilistico, Sciuccati si colloca alla confluenza della sintesi grafica della Pop Art, dell’urgenza dell’Espressionismo Astratto e dell’eleganza lineare dell’Illustrazione di Moda, elementi che lo rendono tanto attuale quanto sperimentatore intrigante della nostra epoca.
La sua tecnica è un amalgama di controllo e caos dove le figure femminili sono spesso delineate da un segno nero, tagliente, quasi calligrafico, che ne traccia i contorni con una precisione che ricorda il fumetto d’autore.
Quest’impalcatura grafica, che conferisce alle sue donne un’aura iconica, quasi intoccabile, viene sistematicamente invasa, travolta, a volte quasi cancellata, da un’esplosione gestuale di colore, che è scagliato, gocciolato, spatolato, per generare fondali dinamici e, soprattutto, capelli che non sono più capelli, ma vere e proprie nebulose di colore, estroflessioni dell’anima.
E poi, c’è la cenere. Il suo uso non è un capriccio, ma il nucleo concettuale della sua opera. La cenere, impiegata per creare neri, grigi, ombre, introduce un’ambiguità profonda, perché non è una tinta inerte, ma una materia pregna di storia, il fantasma di un piacere, il residuo di un tempo vissuto e andato in fumo.
Un espediente che, tecnicamente, conferisce alla superficie una scabrosità opaca, polverosa, fragile, un contrasto potente con la lucentezza e la violenza dei colori fiammeggianti. È un cortocircuito percettivo e filosofico per cui la materia della morte è usata per conferire profondità e ombra alla celebrazione della vita.
I tratti stilistici ricorrenti sono gli archetipi di questo universo bipolare, per cui la donna è la sua ossessione, non come individuo psicologicamente definito, ma come ideogramma di forza vitale, passione, estasi.
I suoi volti sono spesso rovesciati all’indietro, occhi chiusi o sguardo perso, colti in un momento di abbandono totale, di piacere, di trance. Le labbra rosse, carnose, a volte isolate su fondo nero come un’icona Pop, sono simboli di sensualità, di parola, di respiro, del grido.
I capelli sono il vero palcoscenico dell’anima: non obbediscono a leggi di gravità, ma esplodono, si irradiano come vettori di forza, si avvolgono in vortici. Sono la manifestazione visibile dell’energia invisibile che attraversa la figura.
La semiotica della produzione di Sciuccati è una potente affermazione dell’unione degli opposti e il suo messaggio filosofico è che vita e morte, il piacere e la sua cessazione, l’istante e la memoria non sono termini antitetici, bensì facce della stessa medaglia.
L’artista riesce a trasmutare colori e materiali pittorici in una tesi vivente su questa idea. L’esplosione di colore è l’esistenza, l’istante irripetibile dell’orgasmo, della gioia, della creazione, mentre la cenere è il ricordo dell’impermanenza, il promemoria che ogni istante brucia e si consuma, lasciando solo una traccia fragile e polverosa, e la vita non è risparmiata da questo paradigma.
Le donne di Sciuccati non sono figure tragiche, ma esseri pienamente consapevoli di questo dualismo, che vivono l’istante con tanta intensità proprio perché sanno che è effimero.
In fondo, la filosofia di Massimiliano Sciuccati è un esistenzialismo edonista e malinconico. La sua visione della vita è un invito a bruciare, a divampare con la massima intensità, accettando che ogni fiamma, per quanto abbagliante, è destinata a spegnersi e a diventare cenere.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di una disarmante sincerità. La sua pittura è un atto di esorcismo; la sua passione sta nel gesto liberatorio, nell’urgenza quasi fisica di gettare colore sulla tela.
La sua lucida osservazione, d’altro canto, emerge nel rigore del segno sottostante, nell’eleganza delle composizioni e, soprattutto, nella scelta profonda, rituale, concettuale, di usare la cenere come pigmento, gesto che trasforma l’atto del dipingere in una cerimonia di commemorazione dell’istante.
Massimiliano Sciuccati è un artista di straordinaria originalità, dotato di potenza espressiva, che ha forgiato un linguaggio unico capace di unire l’impatto visivo della cultura Pop con la profondità esistenziale dell’Informale.
Le sue opere sono icone post-moderne della passione, eppure icone fragili, consapevoli della propria mortalità, che non ci offrono un’immagine rassicurante della bellezza, ma si confrontano con la sua natura incandescente e furtiva.
Guardare un’opera di Sciuccati significa essere colpiti da un’onda d’urto di energia vitale, capace di farti assaporare l’amaro, quanto prezioso, sapore della cenere.
ENZA TERMINI


IL VORTICE DELL’ESSERE
L’arte di Enza Termini è un viaggio nei recessi dell’anima, un universo pittorico saturo, vibrante, quasi assordante, dove ogni centimetro di tela è invaso da un’urgenza espressiva che rifiuta il vuoto, il silenzio, la neutralità.
È un’artista che ha fuso, in una sintesi altamente personale ed esplosiva, il rigore del realismo accademico con l’energia liberatoria, quasi allucinatoria, di un’estetica psichedelica.
La sua pittura non è una finestra sul mondo, ma un vortice che trascina lo spettatore in un cosmo dove realtà oggettiva e percezione soggettiva non sono più distinguibili, ma si intrecciano in un arabesco inestricabile di forme, colori e simboli.
Ogni tela è un manifesto, una narrazione, un atto di fede, e, spesso, un grido di protesta.
La visione dell’artista interpreta la realtà come un flusso energetico che pervade e connette tutte le cose, e il suo approccio al mondo non è quello di un’osservatrice distaccata, ma di un medium attraversato dalle correnti visibili e invisibili dell’esistenza, come gioia, dolore, fede, memoria storica, impegno civile, e che l’artista traduce sulla tela in una forma di realismo magico, sinestetico.
La sua personalità artistica è quella di una narratrice appassionata e di una moralista che non predica ma mostra. Il suo lavoro rivela una generosità quasi barocca, un desiderio di includere, di raccontare tutto, di non lasciare nulla fuori dal quadro, come se ogni dettaglio fosse indispensabile alla comprensione del vasto, intricato mosaico della vita.
Sul piano stilistico, l’opera di Termini poggia su una costante dialettica tra centro e periferia, figura e fondo.
Al centro delle sue composizioni si incontra quasi sempre un nucleo di impeccabile realismo: un volto, una scena, un paesaggio, resi con classica maestria tecnica, profonda conoscenza dell’anatomia, della prospettiva, del chiaroscuro.
Questi elementi figurativi, come il volto di Cristo, i ritratti di Falcone e Borsellino, la donna vittima di violenza, fungono da ancore di realtà, fulcri tematici ed emotivi dell’opera, e testimoniano quanto l’artista sia ancorata al nostro tempo, quanto sia vera narratrice contemporanea.
Eppure, questo nucleo realista non è mai isolato. Viene sistematicamente assediato, avvolto, quasi generato da un’esplosione di forme astratte, motivi ornamentali, flussi cromatici e simboli che appartengono a un linguaggio del tutto diverso, debitore della Street Art, dell’Art Nouveau, delle visioni psichedeliche degli anni Sessanta.
Questo “fondo attivo” non è mera decorazione, ma la visualizzazione del contesto emotivo, culturale, spirituale in cui la figura è immersa.
È il rumore del mondo, il flusso dei pensieri, l’energia dell’anima resa visibile.
Le linee curve, le spirali, le costruzioni floreali e i costrutti geometrici non sono ornamenti, ma vettori di forza, onde energetiche che connettono ogni elemento della composizione, e i suoi tratti stilistici ricorrenti costituiscono gli elementi di una sintassi visiva densa, stratificata.
La palette è audace, quasi violenta, costruita su giustapposizioni di colori primari e complementari alla massima saturazione, che dotano le opere di un’energia quasi febbrile.
Il collage visivo è la sua strategia compositiva prediletta: all’interno di un’unica opera possono coesistere ritrattistica, paesaggio, simboli araldici, citazioni cinematografiche, elementi sacri e profani, una tecnica che non genera caos, ma piuttosto un’armonia complessa, una polifonia visiva che riflette il caos intricato del mondo contemporaneo.
La semiotica della sua produzione articola un potente discorso etico e sociale, velato da un’estetica gioiosa, quasi fiabesca, il cui messaggio filosofico è un costante appello alla responsabilità della memoria e alla necessità dell’empatia.
Le sue opere non sono mai neutre.
La tela, dedicata a Falcone e Borsellino, incastonata in un trionfo di colori e di simboli della Sicilia, e dei Carabinieri, non è una mera commemorazione, ma un atto di trasfigurazione, un modo di strappare i due magistrati alla fissità luttuosa della cronaca per restituirli a una dimensione mitica, eroica, vitale.
L’immagine della donna con il volto tumefatto, che implora silenzio, circondata da un’esplosione di fiori e colori, è devastante nella sua potenza, perché il contrasto tra la violenza subita e la vitalità dello sfondo non mitiga il dramma, ma lo amplifica, esponendo la dissonanza tra il mondo interiore della vittima e l’indifferenza di quello esterno.
La filosofia di Enza Termini è una forma di umanesimo combattivo, una visione della vita che non si sottrae al dolore e all’ingiustizia, ma li affronta armata di colore, di bellezza e di una incrollabile fiducia nella capacità dell’arte di generare consapevolezza e speranza.
Il rapporto con l’emozione è di totale immersione, eppure questa immersione è lucida e controllata, in una passione che si traduce nell’esuberanza barocca delle composizioni, nella paura del vuoto come metafora di un cuore che vuole abbracciare tutto.
La sua chiarezza di osservazione, d’altro canto, emerge nella precisione del segno realista, nella complessa architettura delle allegorie, nella capacità di orchestrare decine di elementi in una coerente, potente sinfonia visiva.
Enza Termini è un’artista unica e necessaria per il nostro tempo, una narratrice moderna che ha forgiato un linguaggio capace di affrontare temi complessi, spesso drammatici, con una forza visiva che cattura, inquieta e costringe alla riflessione.
La sua arte è un ponte tra la grande tradizione della pittura storica e le forme più vitali della cultura visiva contemporanea. Le sue tele non sono oggetti da contemplare a distanza, ma manifesti da leggere, storie da ascoltare, mondi in cui entrare.
In un’epoca che spesso si rifugia nell’astrazione asettica o nell’intimità autoreferenziale, la sua scelta di fare della pittura un veicolo di impegno civile, spirituale ed emotivo è un atto di coraggio e di profonda generosità intellettuale, che la rende un’Artista con la A maiuscola.
PATRIZIA TESTONI


LA DOPPIA ANIMA
L’universo artistico di Patrizia Testoni è un campo di forze in perpetuo scontro dialettico, uno spazio dove due anime apparentemente antitetiche, quella geometrica, costruttivista, e quella informale, fluida, non si scontrano, ma dialogano, si intrecciano e si fecondano a vicenda.
Ci troviamo di fronte a un’indagine pittorica di straordinaria complessità intellettuale ed emotiva, articolata attraverso due registri distinti, eppure filosoficamente complementari. Da un lato, come Patrizia Testoni, l’artista costruisce universi figurativi decostruiti, debitori delle avanguardie storiche, dove la razionalità della linea e della forma cerca di imporre un ordine al caos dell’esistenza.
Dall’altro, come Pikios, si immerge pienamente in quel caos, diventandone una cantante del flusso primordiale, della pura energia che precede e dissolve ogni forma.
Analizzare l’arte di Testoni significa sondare questa doppia anima, che è, in ultim’analisi, una metafora della condizione umana, è la nostra perpetua oscillazione tra il bisogno di struttura e il desiderio d’abbandono, tra la costruzione di senso e l’immersione nel mistero.
La visione artistica di Testoni/Pikios interpreta la realtà come una tensione costante tra Logos e Caos. Il suo approccio al mondo non è univoco, ma quello di una pensatrice che riconosce la validità e la necessità di entrambi i principi.
La sua personalità artistica è duplice: da un lato, una mente analitica, quasi architettonica, che seziona e ricompone la realtà secondo leggi geometriche; dall’altro, un’anima lirica, passionale, che si lascia travolgere dalla danza imprevedibile del colore che fluisce.
Questo dualismo non è segno d’indecisione, ma di rara e matura completezza, la consapevolezza che la verità non si nasconde in nessuno degli estremi, ma nei vari punti tra di essi.
Come Patrizia Testoni, il suo stile costituisce un omaggio colto e profondamente personale al Cubismo Sintetico e al Purismo. Le sue composizioni figurative sono segnate dalla frammentazione della forma in piani geometrici, dall’uso di colori piatti o leggermente sfumati, e da un audace segno nero di contorno, che funge da armatura, da scheletro strutturale dell’immagine.
Intrecci cromatici smussano gli spigoli e spuntano le misure taglienti. In queste opere, il mondo, un volto, un mare, non sono resi nel loro aspetto visivo, ma ricostruiti secondo un ordine intellettuale. È un’arte della struttura, dell’equilibrio, della sintesi.
Eppure, anche in questo universo controllato, s’insinuano elementi di rottura, di lirismo: onde sinuose, volti malinconici e, soprattutto, le piccole, quasi infantili barchette di carta.
Come Pikios, l’artista cambia radicalmente registro. Abbandona la linea, la forma, la figura, per abbracciare l’Informale nella sua declinazione più fluida e organica: la Pouring Art, dove la tecnica diventa un’alchimia controllata.
Il colore liquido è versato, inclinato, soffiato, manipolato per generare flussi, venature, cellule cromatiche che mimano processi naturali: la nascita di una galassia, la corrente di una marea marina. È un’arte dell’abbandono, in cui l’artista non impone la sua volontà alla materia, ma vi collabora, guidandone e assecondandone le inclinazioni. È un’arte che parla del divenire, della metamorfosi, dell’energia pura.
I tratti stilistici ricorrenti agiscono come ponti segreti tra questi due mondi. La linea sinuosa, presente sia nelle onde delle opere figurative che nei ruscelli delle astrazioni, è la traccia di un’energia mai interamente imbrigliata dalla geometria. La sua palette, sebbene varia, rivela una predilezione per i blu profondi, i grigi, i neri e le terre, punteggiata da improvvise fiammate di rosso, arancione o bianco, elementi cromatici che alludono ad affetti familiari, ai valori delle radici e della tradizione.
Eppure, l’elemento semiotico più potente e rivelatore è la barchetta di carta. Questo simbolo fragile, quasi naïf, collocato all’interno di complessi paesaggi cubisti, a volte persino minacciosi, costituisce una dichiarazione filosofica di straordinaria densità.
Qui la filosofia e il messaggio dell’artista si manifestano con massima chiarezza: la barchetta di carta è il Sé, la coscienza individuale, la fragilità umana, la memoria, ciò che avrebbe potuto essere, e non è stato.
È il prodotto della ragione e dell’ingegno, un oggetto costruito e piegato secondo un ordine, eppure abbandonato alla mercé di un mare che rappresenta il mondo e l’inconscio, l’esistenza stessa, vasta e soverchiante.
Le opere figurative di Patrizia Testoni, dunque, mettono in scena il dramma della coscienza che cerca di navigare il mondo, di dotarlo di senso, di evitare il naufragio. L’occhio che a volte compare sulla vela della barca ne è il simbolo. Le opere astratte di Pikios, al contrario, sono il mare stesso, la rappresentazione di quel flusso primordiale, di quella realtà liquida e imprevedibile in cui la nostra piccola barchetta di carta della ragione è costretta a navigare.
Non sono opere temibili, ma, al contrario, d’una bellezza ipnotica e meravigliosa.
Pikios ci rivela la bellezza del caos, la logica interna del flusso, l’armonia complessa del divenire.
Queste due modalità espressive formano un dittico filosofico completo. Testoni parla della condizione umana dal punto di vista dell’Io, della sua lotta per l’ordine e il significato, mentre Pikios parla della stessa condizione dal punto di vista del Mondo, dell’inconscio, del grande flusso cosmico.
L’artista, nel suo insieme, ci dice che la vita è questa navigazione, questo precario equilibrio tra la nostra volontà di plasmare il mondo e la consapevolezza di essere parte di un processo che ci trascende e ci determina.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è, di conseguenza, duplice: nelle opere figurative, l’emozione si manifesta come malinconia controllata e tensione intellettuale; nelle opere astratte, diventa un’immersione quasi estatica, un abbandono sensuale al puro piacere del colore e della forma organica.
Patrizia Testoni/Pikios è un’artista di rara profondità concettuale, che ha avuto il coraggio di esplorare non uno, bensì due linguaggi artistici per dare voce alla complessità della sua visione del mondo. La sua sintassi cromatica è un invito a riconoscere e abbracciare la nostra doppia natura: siamo esseri dotati di ragione e di istinto, di costruzione e di abbandono; siamo la barchetta di carta, ma siamo anche l’oceano.
E la sua arte sembra suggerire che il saggio non è chi sceglie un universo anziché l’altro, ma saggezza è imparare a navigare, con coraggio e meraviglia, la tensione che lega indissolubilmente la varietà degli universi.
SALVINA VALASTRO


ENERGIA VIVENTE
L’espressione artistica di Salvina Valastro è un’immersione coraggiosa e gioiosa nella corrente primordiale dell’energia vitale, attraverso una grammatica cromatica che non cerca di rappresentare il mondo, bensì di incarnarne il processo generativo, di cogliere sulla tela l’istante aurorale in cui l’energia si condensa in forma, la luce diventa colore e la materia comincia a pulsare.
Valastro ha scelto l’astrazione non per fuggire dalla realtà, ma come mezzo più diretto per accedere alla sua essenza più profonda e invisibile, per perforare lo strato apicale della superficie.
Ogni sua tela è una cosmogonia in miniatura, un’esplosione stellare, un’improvvisa fioritura, la testimonianza di un atto creativo che celebra la vita nella sua manifestazione più pura, dinamica e irrefrenabile.
La visione artistica di Valastro interpreta la realtà come un campo di forze in perpetua interazione e il suo approccio al mondo è quello di una mistica della natura, di una poetessa che percepisce l’universo con la partecipazione totale dei sensi e dell’anima.
La sua personalità artistica, riflessa nella sua radiosa sintassi cromatica, è quella di una creatrice animata da un ottimismo di fondo, da un’incrollabile fiducia nel potere rigenerante della bellezza e della creatività.
Il suo lavoro è segnato da una totale assenza di cinismo o angoscia intellettuale, e afferma, invece, in modo pieno e incondizionato, la gioia dell’esistenza.
Sul piano stilistico, Salvina Valastro si muove nell’ambito dell’astrazione lirica e materica, elaborando un linguaggio che unisce la libertà del gesto a una profonda sensibilità per la dimensione e la sostanza del colore, dimostrando una tecnica che diventa un dialogo costante tra impulso e costruzione.
Molte sue opere rivelano una superficie densa, quasi scultorea, ottenuta attraverso impasti spessi che trasformano la tela in un’epidermide sensibile, in un terreno fertile da cui le forme sembrano germinare.
Su questa base materica, l’artista interviene con il colore, a volte steso in ampi e decisi guizzi cromatici, altre volte applicato con una precisione più grafica e lineare, altre ancora, inciso o graffiato per rivelare strati sottostanti.
Questa polifonia tecnica le permette di creare opere di grande complessità visiva e percettiva.
Non esiste uno stile unico, ma un approccio multiforme che si adatta all’energia specifica che ogni opera intende incarnare.
Si passa dalla sintesi quasi grafica del fiore-sole bianco e giallo, alla complessità stratificata, quasi geologica, di altre composizioni, alle cromie delicate, quasi puntiniste, del nucleo radiante rosa e giallo.
I tratti stilistici ricorrenti diventano gli archetipi di questo universo energetico.
La forma radiante, il centro da cui emanano linee di forza, è forse il suo simbolo più potente e pervasivo, che riappare costantemente nella sua divulgazione cromatica; che sia sole, fiore, stella o nucleo cellulare, questa struttura centripeta e centrifuga è la metafora visiva dell’origine, del punto zero da cui scaturisce ogni forma di vita, ogni forma di energia.
È il Big Bang, il cuore che consente la vita, la sorgente.
A completare e integrare questa forma sono altre dinamiche, come le linee curve e sinuose che evocano il flusso, la crescita organica, la danza, nonché strutture orizzontali o diagonali che suggeriscono paesaggi, orizzonti, campi di forza più stabili, ma non meno energetici.
Il ventaglio cromatico di Valastro è un’esaltazione del colore puro come veicolo d’emozione.
Non ci sono mezzi toni né esitazioni.
I suoi gialli sono solari, i suoi rossi passionali, i suoi blu profondi, i suoi verdi vitali.
Spesso, queste tinte primarie sono posizionate su fondi scuri o arricchite da pigmenti metallici, come oro e bronzo, che ne amplificano la luminosità e conferiscono all’opera un’aura che sfiora il sacro.
La semiotica della sua produzione è un omaggio alla forza che ha creato l’universo, mentre il messaggio filosofico dell’artista è una potente affermazione del vitalismo, radicata nella convinzione che l’intero universo sia percorso da una forza vitale che si manifesta in infinite forme.
L’arte di Valastro non illustra semplicemente quest’idea, ma si sforza di incarnarla direttamente, riuscendo a trasformare il colore in pura energia.
L’opera con il nucleo rosso incandescente su fondo nero non rappresenta un vulcano o una stella, ma è l’energia del calore, della passione, della genesi.
L’opera con le linee multicolori che si irradiano da un unico punto non descrive un fiore o un fuoco d’artificio, ma l’atto dell’espansione, della differenziazione, della manifestazione della gioia ed è proprio qui che la sua filosofia si rivela in tutta la sua coerenza e positività.
La sua visione della vita è ciclica e generativa. Anche quando lavora su fondi scuri, si nota sempre una luce, un colore, una forma con cui l’artista afferma il trionfo della vita sull’inerzia.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di totale e beata coincidenza, così come la sua pittura è la traduzione immediata, non mediata, di un sentimento di meraviglia e di gratitudine davanti al mistero della creazione.
La sua passione prende forma nell’esuberanza del colore e nella sensualità della materia, in un’osservazione lucida che si manifesta nella padronanza con cui orchestra queste esplosioni di energia.
Le sue composizioni, per tutta la loro apparente spontaneità, possiedono sempre un punto di fuga visivo, un ritmo, un equilibrio dinamico che impedisce loro di dissolversi nel caos.
Salvina Valastro ha saputo creare un linguaggio astratto di grande potenza lirica e dotato di una profonda risonanza emotiva.
La sua arte è un potente antidoto al cinismo e all’aridità spirituale del nostro tempo, un invito a riscoprire le nostre radici nelle forze primordiali della natura e del cosmo, con tele che non sono oggetti decorativi, bensì accumulatori di energia, talismani cromatici che irradiano calore, luce e vitalità.
Contemplare un’opera di Salvina Valastro è un’esperienza rigenerante, un bagno di puro colore che ci ricorda la verità più semplice e profonda. Ci ricorda che essere vivi è già, di per sé, un atto di esplosione irrefrenabile e meraviglioso.
MURIEL VILLA


MONDI INTERIORI
La vena espressiva di Muriel Villa nasce da un’indagine silenziosa, profonda, sulla condizione umana, perseguita attraverso il prisma di una sensibilità squisitamente romantica e introspettiva, quasi d’altri tempi.
Ogni tela è un frammento di una narrazione interiore, una scena sospesa in un tempo e in uno spazio che non appartengono né al mondo esterno né al nostro tempo, ma al teatro della memoria e dell’emozione, in una dimensione senza tempo.
Ci troviamo di fronte a un’artista che impiega il linguaggio della figurazione per evocarne l’anima, con scarso interesse a rappresentare la realtà come appare, ma con l’intento di dare forma a quegli stati liminali del sentire, come la malinconia, l’attesa, la nostalgia, la passione trattenuta e inespressa, sentimenti e sensazioni che sfuggono alle parole e trovano la loro unica possibile esaltazione nella luce, nell’ombra e nel colore.
La visione artistica di Villa interpreta la realtà come un’eco dell’emozione. Il suo approccio al mondo non è quello di una cronista o di una fotografa, ma di una poetessa che attinge all’esperienza quotidiana la sua essenza emotiva, trasfigurando stati d’animo ed emozioni in allegorie visive d’una bellezza intensa, crepuscolare, nonché sensuale e raffinata.
La sua personalità artistica, riflessa in questa costante tensione verso l’interiorità, è quella di una contemplativa, un’osservatrice che non cerca la bellezza nel clamore degli eventi, ma nella quiete di un gesto sospeso, nella luce che scolpisce una schiena nuda, nel silenzio che emana da uno strumento musicale silenzioso.
La sua è un’arte che non grida, ma sussurra, ed è proprio in questo sussurro che si coglie la sua straordinaria potenza e la raffinatezza del suo linguaggio.
Sul piano stilistico, Muriel Villa si muove nella corrente di un Realismo Lirico radicato nella grande tradizione pittorica europea, da Caravaggio a de La Tour, nell’uso drammatico della luce, alle sfumature atmosferiche del Simbolismo di fine Ottocento. La sua tecnica è impeccabile, costruita su una profonda conoscenza del disegno e su una padronanza del chiaroscuro che diventa la sua peculiarità più riconoscibile, insieme alla perfezione vellutata della pelle dei suoi soggetti.
Nelle sue opere, la luce non è mai un dato naturalistico, ma è una luce psicologica, una luce da cinema che scolpisce le forme dal buio, che rivela un dettaglio, nascondendone un altro, che stabilisce gerarchie emotive all’interno della composizione.
Le sue figure e i suoi oggetti non sono semplicemente illuminati; sono rivelati da una luce che sembra emanare da una fonte interiore.
La materia pittorica è trattata con una morbidezza e una maestria dello sfumato che conferiscono alla pelle una sensualità e una vitalità quasi palpabili. Che sia nella schiena dorata di una modella o nel corpo grigio, statuario di un nudo, la pelle non è mai una superficie inerte, ma una membrana sensibile che sembra vibrare al tocco della luce.
Questa perizia tecnica non è mai fine a se stessa, mai mera dimostrazione di abilità, ma è sempre al servizio dell’intenzione espressiva di rendere visibile l’invisibile, per dare corpo all’anima.
I suoi tratti stilistici ricorrenti formano un vocabolario simbolico ed emotivo di notevole coerenza. Il corpo femminile, quasi sempre solitario e introspettivo, è il soggetto privilegiato, il tempio dove va in scena il rito silenzioso dell’esistenza. Spesso raffigurato di spalle o con il volto parzialmente celato, non è offerto a uno sguardo voyeuristico, ma presentato come un paesaggio interiore, un terreno di vulnerabilità e di forza segreta.
La musica è l’altro grande archetipo che attraversa la sua sintassi. Il violino, in particolare, non è mai un mero oggetto da natura morta, ma l’alter ego dell’artista, un simbolo della passione, della disciplina e della capacità dell’arte di dare voce sia al dolore che alla bellezza del mondo.
La natura morta con violino, rosa e candela è una raffinata meditazione sulla fragilità della bellezza, sulla caducità dell’esistenza umana e sulla permanenza dell’arte.
La semiotica della sua produzione costituisce una profonda esplorazione della solitudine come condizione esistenziale; le sue figure non sono mai sole in senso negativo, ma immerse in una solitudine fertile, uno spazio di raccoglimento, di autocoscienza, come monaci-guerrieri in una dimensione parallela, assorti in meditazione.
La donna che suona il violino in riva al mare, il volto nascosto da un cappello, non posa per noi, ma è intenta a un dialogo intimo con la sua musica e con la vastità della natura. L’uomo seduto nell’oscurità, dallo sguardo malinconico, non è un ritratto, ma la personificazione del pensiero, dell’attesa, di quel momento sospeso in cui l’azione cede il passo alla riflessione.
Muriel Villa riesce a trasformare la materia pittorica in veicolo di messaggi filosofici profondi, interrogando temi universali: la memoria, nel diario abbandonato; il tempo, nella donna-strega con l’orologio sullo sfondo; il rapporto tra corpo e anima, nella donna avvolta dallo spartito musicale.
Perciò, la sua filosofia è un’indagine sulla natura della percezione e sulla capacità dell’arte di rivelare la verità emotiva che giace dietro la superficie delle apparenze.
Villa abbraccia una visione della vita in cui i momenti più significativi non sono quelli dell’azione o della comunicazione verbale, ma quelli del silenzio, della contemplazione e dell’ascolto interiore, quei silenzi in cui riesce a esprimere ciò che il linguaggio parlato non può.
La sua arte è un invito a rallentare, a distogliere lo sguardo dal rumore del mondo per concentrarsi sulle sottili risonanze dell’anima.
Il rapporto tra la sua espressione artistica e l’emozione è di squisita raffinatezza ed esplode in una passione che non è mai ostentata, ma è un fuoco che brucia sotto la cenere, una corrente profonda percepita nella tensione dei corpi, nell’intensità degli sguardi, nel dramma della luce, così come la sua acutissima osservazione si traduce in una perfezione quasi iperrealista del dettaglio che non è mai sterile, perché dona a ogni soggetto il giusto peso esistenziale.
Muriel Villa è un’artista di rara profondità e di rara sensibilità, una cantastorie visuali malinconica, intesa nel suo senso più nobile e antico, capace di costruire accessi privilegiati alla conoscenza di sé.
La sua arte è un potente antidoto alla banalità e alla superficialità dell’immagine contemporanea, grazie a un linguaggio che unisce il rigore della tradizione accademica a un’anima profondamente romantica, con cui dà vita a un universo pittorico altamente personale e immediatamente riconoscibile, popolato da figure silenziose che interrogano la nostra stessa capacità di ascoltare il silenzio, di abitare la solitudine, di trovare bellezza nell’ombra.
Le sue tele sono finestre sull’anima altrui, ma ancor di più, specchi in cui scorgere la nostra e conoscerci.
PATRIZIA VILLANI


LA MATERIA DEL SENTIRE
L’arte di Patrizia Villani è un corpo a corpo con la pittura, un atto viscerale, di testimonianza, in cui la tela diventa l’arena di un dramma interiore che rifiuta la mediazione della forma per manifestarsi nella sua immediatezza più pura e potente.
Ci troviamo di fronte a un’artista che non ha abbracciato l’astrazione per un capriccio stilistico, ma come necessità esistenziale, come l’unico linguaggio capace di dare voce al magma di percezioni, conflitti ed emozioni che ribollono sotto la superficie della sua coscienza razionale.
Ogni opera di Villani è un evento da esperire, un campo di forze cromatiche e materiche che travolge lo spettatore, un evento che non si accontenta di essere compreso, ma pretende di essere interiorizzato, perché la visione artistica di Villani interpreta la realtà come uno stato interiore, come una dimensione emotiva.
Il suo approccio al mondo è quello di un’osservatrice dell’anima, capace di registrare i tremori, le tensioni, le eruzioni della psiche, per poi tradurle in un linguaggio di pura intensità.
La sua personalità artistica, riflessa in un gesto che a volte è violento, a volte lirico, è quella di una creatrice che non teme il conflitto, anzi, talvolta lo riconosce come motore, tanto della vita quanto della creazione.
Sotto la grammatica cromatica di Villani c’è un’onestà brutale, una totale assenza di compiacimento estetico, che la colloca nella nobile stirpe di quegli artisti per i quali l’arte non è una professione, ma una forma di sopravvivenza, un’estroflessione viscerale del sé.
Sul piano stilistico, Villani opera nell’alveo dell’Espressionismo Astratto e dell’arte informale, ma vi imprime un brio che oscilla costantemente tra registri differenti, mediati da una tecnica eminentemente fisica, fondata su un’interazione diretta e quasi aggressiva con il colore, che, molte volte, è applicato in strati spessi, sovrapposti, più con la spatola che con il pennello, generando superfici ruvide, corrugate, quasi ambito della geologia.
Questo approccio materico conferisce alle sue opere una presenza palpabile, un peso, una concretezza che nega la bidimensionalità della tela, trasformandola in un bassorilievo di emozioni.
Accanto a questo gesto materico, affiorano momenti di maggiore fluidità e lirismo. In alcune opere, la pennellata si ammorbidisce, diventa sinuosa, quasi calligrafica, producendo vortici di colore che evocano moti di marea o danze cosmiche.
Altrove, come in un dipinto con colature, l’artista esplora il potere del colore applicato, ma libero di agire, lasciato all’azione della gravità, in modo tale che la libertà del colore risulta coautrice dell’opera, in un gesto che ricorda l’Action Painting nella sua forma più radicale.
Questa capacità di alternare la densità dell’impasto alla liquidità del colore, il tratto aggressivo della spatola alla carezza del pennello, testimonia una notevole complessità e una ricchezza interiore.
I suoi tratti stilistici costituiscono gli elementi di un vocabolario emotivo, dove la sovrapposizione e il conflitto cromatico ne formano la sintassi fondamentale. Raramente i suoi colori sono puri o isolati, ma si scontrano, si mescolano, si sovrappongono; a volte, si feriscono a vicenda, perfino.
Non si tratta di una mancanza tecnica, ma di una scelta filosofica deliberata, poiché Villani concepisce l’emozione come un groviglio, un campo di battaglia di forze opposte.
Il suo ventaglio di colore è audace e intenso: i rossi sono sanguigni e passionali, i neri profondi e drammatici, i gialli e gli aranci lampi di pura energia, i blu e i verdi sono note introspettive e di speranza. La sua arte non riconosce la neutralità dell’assenza di colore.
La semiotica di Villani è una potente affermazione della realtà del sentire, che veicola un messaggio filosofico per cui le emozioni non sono eventi immateriali, secondari, ma la sostanza più vera della nostra esistenza, sono forze concrete, potenti, che ci plasmano e ci definiscono.
L’artista riesce a trasformare il colore in una metafora vivente di questa idea, perciò le sue tele non rappresentano soltanto un’emozione, ma la incarnano. Un’opera che si presenta come un campo di brace incandescente non è un’immagine del fuoco, ma l’esperienza del calore da vivere, percepire, sentire, l’esperienza della passione, della distruzione che poi diventa generatrice.
Un dipinto dominato da un groviglio di blu e rossi non è la raffigurazione di un conflitto, ma il conflitto che Villani racconta attraverso un’immagine.
È qui che la filosofia di Villani mostra una forma di esistenzialismo catartico, una visione della vita che riconosce il dolore e il conflitto come incontrovertibili, ma che crede nel potere dell’atto creativo come mezzo per elaborarli, sublimarli, fino a liberarsene.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di immediatezza totale, un’arte che è un atto di esorcismo, per cui dipingere non è solo la rappresentazione di un’emozione, ma è il suo sfogo, la sua oggettivazione sulla tela.
La sua passione che si traduce nella fisicità del gesto; la sua lucidità, a sua volta, si manifesta nella saggezza, forse più istintiva che razionale, con cui riesce a conferire a questo caos emotivo una forma che, sebbene lontana dall’essere pacificata, è esteticamente coerente e dirompente.
Le sue composizioni manifestano un equilibrio interno, un’armonia che le tiene insieme e impedisce loro di collassare nell’incoerenza, perché Patrizia Villani è un’artista di rara autenticità, dotata di potenza espressiva e di una grammatica cromatica capace di essere un pugno nello stomaco e una scossa all’anima.
L’artista rifiuta ogni facile seduzione estetica e ci impone la verità cruda di ciò che avverte, senza mediazioni, attraverso tele che non sono oggetti decorativi, bensì frammenti di un diario esistenziale scritto nel linguaggio primordiale della materia e del colore. Non chiedono di essere ammirate, ma di essere affrontate, comprese, assorbite.
Riflettere sull’arte di Patrizia Villani significa accettare di entrare in risonanza con un’interiorità complessa e a volte tempestosa, significa riconoscere in quel dramma, e in quella bellezza, un’eco del nostro universo interiore inespresso.
ALESSANDRO VILLANUCCI


LA GRAMMATICA DEL SILENZIO
L’arte fotografica di Alessandro Villanucci è un’indagine filosofica sulla struttura del visibile e sulla risonanza emotiva del silenzio nel tessuto sociale.
In un’epoca dominata dalla velocità e dalla saturazione iconica di immagini che si consumano in pochi istanti, il suo lavoro è un atto di radicale distillazione, una ricerca quasi ascetica dell’essenza celata dietro il rumore della realtà e lo strato più superficiale della sua superficie.
Villanucci non è un fotografo di eventi, non immortala paesaggi o scene, ma è un fotografo di stati dell’essere; non cattura l’istante, ma la durata di quell’istante e la sua filosofia. Non descrive luoghi, ma ne distilla l’anima metafisica e i suoi messaggi.
Ogni sua immagine è una partitura composta solo dagli elementi della luce, dell’ombra e dei tratti illuminati, una composizione rigorosa che, proprio in virtù della sua disciplina, apre passaggi vertiginosi verso la dimensione del simbolo, del sogno, della percezione pura.
La visione artistica di Villanucci interpreta la realtà come un sistema di geometrie significanti e il suo approccio al mondo non è quello di un documentarista, ma di un architetto della visione, che rifiuta di registrare la realtà così com’è, per disporla, ordinarla secondo una propria logica, isolandola e purificandola dagli elementi aneddotici per rivelarne la struttura scheletrica, l’ordine nascosto.
La sua personalità artistica, riflessa in questa estetica minimale e profondamente meditativa, è quella di un pensatore che trova la massima eloquenza nella parsimonia dei mezzi, dalle cui fotografie emerge un’acutissima intelligenza visiva, una capacità di trasformare una scala, una finestra o il marciapiede di una stazione in un teorema sulla condizione umana.
Sul piano stilistico, la fotografia di Villanucci si muove su una sintesi altamente personale di Minimalismo, Astrazione Geometrica e Fotografia Metafisica, segnata da un controllo compositivo assoluto.
Le sue inquadrature non sono mai casuali, ma architetture visive impeccabili, governate da un uso magistrale delle linee di fuga, delle diagonali, delle simmetrie, delle ripetizioni seriali.
Villanucci possiede una straordinaria sensibilità per il rapporto tra pieni e vuoti, dove il vuoto, che sia un cielo, un muro, una distesa scura, non è mera assenza, ma un elemento attivo, un silenzio che conferisce peso e significato alla forma.
La predominanza del bianco e nero non è un afflato stilistico, ma una dichiarazione filosofica.
Spogliando l’immagine del colore, Villanucci toglie l’emozione più immediata e superficiale, costringendo lo spettatore a un livello di coinvolgimento più profondo, più strutturale, più intellettuale. Infatti, il suo bianco e nero è denso, in contrasto, quasi grafico. I neri sono abissali, i bianchi accecanti, le gradazioni di grigio ricche e sottili.
Quando il colore appare, è un evento raro, ma è carico, come nel calore dorato di un tramonto, o nell’azzurro polveroso di un muro. Non è colore descrittivo, ma è una festa delle emozioni, un’eccezione che conferma la regola del silenzio cromatico.
I tratti stilistici che ricorrono formano un vocabolario simbolico in cui la linea diventa un’ossessione: i binari diritti e convergenti di una stazione, la spirale ipnotica di una scala, la diagonale di un corrimano, la griglia di una facciata moderna… non sono solo espedienti compositivi, ma metafore dei percorsi della vita, delle strutture mentali, dei destini individuali.
L’ombra è l’altra grande protagonista. Non è la semplice assenza di luce, ma una presenza tangibile, un doppio, un mistero. L’ombra proiettata lungo un vicolo, la sagoma di un passante su una scala, non descrivono la realtà, ma la interpretano, caricandola di un’inquietudine e di una profondità che la luce diretta non può possedere.
Quando la figura umana si introduce in un’immagine, è quasi sempre una sagoma, un’entità anonima, universale. Non è un ritratto, ma il simbolo dell’essere umano che si muove in questi spazi, che affronta queste architetture, che proietta la sua fragile ombra sul mondo.
La semiotica dell’arte di Villanucci è una potente meditazione sul rapporto tra l’individuo e lo spazio, inteso sia come struttura fisica che mentale, mentre il messaggio filosofico è una riflessione sulla condizione umana nell’era moderna e postmoderna.
Le sue stazioni deserte, le sue scale infinite, le sue facciate impassibili sono i non-luoghi della nostra esistenza, gli spazi anonimi e geometrici in cui si svolge il dramma silenzioso della nostra solitudine.
Eppure, la sua visione non è pessimista, perché, nelle sue fotografie, c’è sempre una via d’uscita, un’apertura: l’arco di una rovina che incornicia il cielo, la luce in fondo a un binario, la sommità di una scala, tutti orizzonti verso i quali l’artista ci esorta a muoverci.
Villanucci ci mostra le gabbie, ma indica anche la possibilità della trascendenza, secondo una filosofia che rivela una forma di esistenzialismo strutturalista, una visione della vita che riconosce il peso delle strutture che ci condizionano, ma afferma anche la libertà dello sguardo e del pensiero di attraversarle e superarle.
Il rapporto tra la sua arte e le emozioni è sottile, intellettuale, quasi subliminale. Infatti, le emozioni non sono gridate, ma distillate. Sono il vortice davanti a una spirale, l’inquietudine di fronte a un vicolo buio, la speranza davanti a una luce lontana, la pace malinconica di un tramonto.
La concentrazione quasi maniacale con cui ricerca l’inquadratura perfetta indica una passione che va ben al di là della semplice passione per la fotografia e già la sua lucida osservazione del mondo fa parte della sua espressione artistica.
Alessandro Villanucci è un fotografo di rara profondità, dotato di rigore intellettuale, la cui espressione artistica è un potente antidoto all’inquinamento visivo, un invito a reimparare a vedere, a percepire la musica segreta delle forme, persino il peso del silenzio.
Con un linguaggio che unisce la purezza del Minimalismo alla profondità della Metafisica, Villanucci ha creato un universo visivo di straordinaria coerenza e potenza evocativa.
Le sue fotografie non sono documenti, ma icone. Non ci mostrano il mondo, ma ci insegnano un modo più profondo di osservarlo. Ed è in questa capacità di osservare con acume, in questa rieducazione della percezione, che si trova il dono più prezioso che Villanucci veicola al mondo.
ATTILIO ZANANGELI


IL TEATRO DELL’ANIMA
La sintassi cromatica di Attilio Zanangeli attiva un viaggio in una dimensione archetipica, un teatro metafisico dove figure umane, alberi ed elementi naturali non sono raffigurati nella loro contingenza, ma distillati nella loro essenza più pura, usati come simboli silenziosi di un dramma universale.
Questa è un’arte che trascende la narrazione per farsi parabola, che abbandona il realismo per attingere al linguaggio del mito e del sogno, attraverso un idioma originale e riconoscibile, seppur non privo di sottili rimandi a grandi maestri del passato, tra i quali Matisse.
Ogni tela di Zanangeli è un palcoscenico essenziale, quasi desertico, su cui l’artista orchestra una coreografia di solitudini, di incontri, attese e trasformazioni, costringendo lo spettatore a interrogarsi in maniera profonda sulla condizione umana, sulla natura dei rapporti e sul mistero dell’esistenza.
La sua visione artistica interpreta la realtà come un paesaggio dell’anima, non con lo sguardo di chi ne osserva la superficie, ma con la sensibilità di un poeta che riesce a coglierne le risonanze interiori, le segrete corrispondenze tra l’uomo e il cosmo.
La personalità artistica di Zanangeli, riflessa in questa estetica austera eppure preziosa, è quella di un saggio, di un pensatore che ha spogliato il suo linguaggio da ogni elemento superfluo per giungere al nocciolo della questione.
Il suo lavoro respira di una profondissima quiete, di una qualità meditativa che non è assenza di passione, ma passione trasmutata, interiorizzata, trasformata in lucida consapevolezza.
Sul piano stilistico, l’arte di Zanangeli si situa lungo una traiettoria che fonde, in modo del tutto originale, le atmosfere sospese e i paesaggi desertici del Surrealismo di Dalì, la sintesi formale di un Primitivismo colto che ricorda Giacometti o certe fasi di Carrà, e una preziosità materica di risonanza quasi bizantina, anche grazie a una tecnica che è un amalgama di pittura e manifestazione a bassorilievo, con fondali spesso realizzati con pennellate morbidamente sfumate, quasi atmosferiche, che generano un senso di profondità infinita, fino a diventare indeterminata.
Su questo spazio etereo, l’artista innesta le sue figure ricorrenti, quali alberi, uomini, farfalle, realizzati quasi in rilievo e rivestiti di pigmenti aurei.
Questo contrasto tra la bidimensionalità morbida e sfocata dello sfondo e la tridimensionalità materica, luminosa, delle figure in primo piano, non è un artificio, ma il cuore della poetica dell’artista.
Lo sfondo evoca la dimensione del possibile, del sogno, dell’infinito, mentre le figure sono l’atto, l’esistenza nella sua massima manifestazione, nella sua essenza, l’evento che in questo spazio si manifesta e si cristallizza.
L’oro, per Zanangeli, non è un semplice colore, ma una sostanza simbolica che evoca la sacralità, la permanenza, la luce della conoscenza e dell’anima, trasfigurando ogni scena in evento mitico.
I tratti stilistici ricorrenti costituiscono un vocabolario archetipico nelle figure umane, che sono essenziali, allungate, quasi ideografiche. Prive di volti e di tratti psicologici, non sono individui, ma incarnazioni di ruoli universali: il viandante, l’amante, il genitore, il solitario…
Gli alberi, spogli e contorti, non sono elementi botanici, ma alberi della vita o della conoscenza, metafore dell’esistenza, con radici saldamente ancorate al terreno, spesso reso come un piano materico denso, rosso, e con rami protesi verso l’alto, verso l’azzurro della dimensione spirituale.
Le farfalle, anch’esse dorate, incarnano il simbolo platonico dell’anima, della trasformazione, della leggerezza e della libertà. Infine, la barca, che spesso solca la terra rossa come elemento inquietante, è il simbolo del viaggio e del passaggio, ma anche della morte o della ferita che inevitabilmente accompagna l’esistenza.
La semiotica del suo lavoro costituisce una potente meditazione sulla natura delle relazioni umane e sul percorso dell’anima.
La cifra filosofica dell’arte di Zanangeli è una profonda riflessione sulla dialettica tra individuo e comunità, tra solitudine e amore, tra radicamento e trascendenza, e le sue opere non raccontano storie, ma mettono in scena situazioni esistenziali, come la coppia di amanti, in rosso e blu, simboli del maschile e del femminile, della passione e della spiritualità, che stanno uniti in un paesaggio brullo per dirci che l’amore è un rifugio, un’isola di senso in un mondo altrimenti vuoto.
Il genitore che osserva il bambino da lontano parla della distanza generazionale, del delicato equilibrio tra protezione e libertà, mentre la figura solitaria che beve da una coppa sotto un albero piegato dal vento è una potente icona del confronto dell’uomo con il proprio destino, della necessità di “bere” la propria vita fino in fondo, anche nell’avversità.
È qui che la filosofia di Zanangeli si rivela come una forma di esistenzialismo spirituale, attraverso una visione della vita che, pur riconoscendo la tragica solitudine della condizione umana, evocata dalla terra rossa e dalla barca, afferma, con uguale forza, la possibilità della trascendenza, della bellezza, del significato incarnati nel cielo azzurro, nelle farfalle dorate, nell’amore.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è di squisita raffinatezza. Le emozioni non sono mai gridate, ma sublimate, distillate in simboli; la gioia non è un sorriso, ma il volo di una farfalla; il dolore non è una lacrima, ma l’incurvarsi di una schiena.
Zanangeli esprime tutta la sua passione nella scelta alchemica dell’oro, nella cura con cui plasma le sue figure, in una visione cristallina che si manifesta nell’impeccabile composizione di queste scene silenti, in un equilibrio quasi musicale tra figure e spazio.
Attilio Zanangeli è un artista di rara profondità e coerenza, un poeta visivo che ha dato vita a un universo simbolico unico e straordinariamente evocativo.
La sua espressione artistica è un antidoto alla banalità del realismo e all’autoreferenzialità di certe correnti astratte; le sue tele sono icone, specchi in cui lo spettatore non vede la propria somiglianza, ma riconosce la propria condizione.
In un mondo assordato dal rumore e saturo di immagini prive di significato, il suo richiamo al silenzio, al simbolo, alla meditazione è un atto di resistenza, di assoluta bellezza e necessità.
Contemplare un’opera di Zanangeli è come leggere un antico poema, uno di quelli capaci, con poche parole essenziali, di dire tutto.
MARIA GRAZIA ZOHAR DI KARSTENEGG
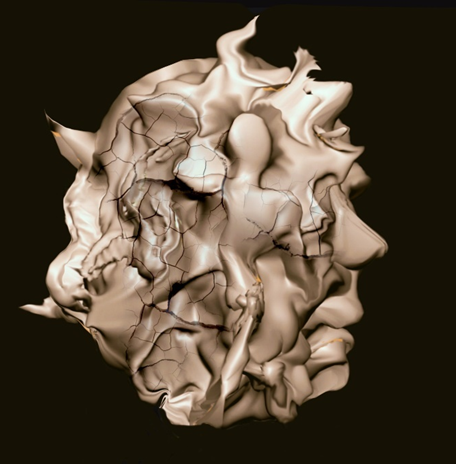

LA METAMORFOSI DELLA PSICHE
L’arte di Maria Grazia Zohar di Karstenegg è un viaggio visionario nei territori inesplorati della psiche.
La sua non è arte digitale nel senso meramente strumentale del termine, ma una vera e propria alchimia computazionale, un processo attraverso cui gli archetipi più antichi dell’inconscio collettivo vengono evocati, decostruiti e trasfigurati per mezzo del linguaggio freddo, apparentemente distaccato del software.
Ci troviamo di fronte a un’artista che ha trasformato il pixel in un medium metafisico, creando un universo di icone ibride, idoli cibernetici e paesaggi mentali in cui materia organica e codice digitale non sono più distinguibili, ma si fondono in una nuova, inquietante e sontuosa ontologia.
La visione artistica di Zohar di Karstenegg non interpreta la realtà come qualcosa di esteriore, ma come un costrutto mentale, perciò interiore, un sogno lucido plasmato dalle forze della memoria, del desiderio e della tecnologia.
Il suo approccio al mondo è quello di una sciamana digitale, di una creatrice che naviga il flusso immateriale dei dati per estrarre forme che recano il peso e la sacralità di una reliquia archeologica. La sua personalità artistica, riflessa in questa estetica che combina una sensibilità quasi barocca con il rigore del Parametric design, è quella di una filosofa che interroga le grandi questioni della condizione umana, quali l’identità, il corpo, la mortalità, il divino, all’interno di un’epoca che sembra aver decretato la loro definitiva smaterializzazione.
Sul piano stilistico, la sua arte potrebbe essere descritta come una forma di Surrealismo Digitale o di Barocco Cibernetico. La sua tecnica prevede un complesso processo di modellazione 3D, texture algoritmiche e composizione digitale, ma, a differenza di molta arte digitale che ostenta la propria natura artificiale, Zohar infonde alle sue creazioni una qualità materica e tattile quasi ossessiva, fondata su disegni eseguiti direttamente dall’artista su tavoletta digitale e successivamente rielaborati.
Le sue superfici non sono lisce o immacolate, ma trasmettono un senso di corrosione, incrinate, organiche, instabili. Il metallo appare liquido, la carne diventa ceramica, la pietra si dissolve in fumo. Questo uso magistrale di materialità digitali diverse non è un mero sfoggio di virtuosismo, ma una scelta filosofica, un mezzo per conferire corpo e storia a entità che, per loro stessa natura, sono incorporee.
Il suo linguaggio visivo è un amalgama di elementi apparentemente disparati: dalla scultura classica all’arte tribale, al design biomeccanico di Giger all’arte informale, fino all’iconografia sacra.
Le sue figure appaiono scolpite, fuse o erose da un tempo digitale che scorre secondo leggi sconosciute, dove la luce non è mai naturalistica, ma un’illuminazione interiore, drammatica, quasi caravaggesca, che rivela e nasconde, creando un’atmosfera di sospensione mistica e di profondo mistero.
I tratti stilistici ricorrenti sono gli elementi di un vocabolario archetipico e post-umano. La figura umana, o ciò che ne resta, è il fulcro della sua ricerca. Raramente completa, appare più spesso come un torso, un volto, una maschera, un’entità in perenne stato di metamorfosi, di frattura o in assemblaggio.
Il profilo di un volto che sembra fatto d’argilla liquida e crepata non è un ritratto, ma la personificazione del pensiero, un’entità immateriale che lotta per mantenere la forma.
La maschera è un simbolo onnipresente: maschere dorate, tribali, maschere che si spezzano per rivelare un vuoto o un altro volto, maschere che si fondono con la carne.
Queste maschere sono figlie delle sensazioni, di percezioni ed emozioni vissute dall’artista nel momento in cui si sente spinta a schizzare forme, volti, costrutti che poi elabora digitalmente.
Non più la maschera pirandelliana che cela un’identità stabile, perché qui l’identità è diventata una successione fluida di maschere.
La dualità e il riflesso sono altri temi cruciali: figure che si raddoppiano, che affrontano il proprio doppio, che emergono da superfici riflettenti, nell’eterno tema del “conosci te stesso” trasposto nell’era digitale, dove il nostro doppio non è più solo un’immagine nello specchio, ma un avatar, un profilo, un’entità digitale che vive di vita propria.
La semiotica della produzione artistica di Zohar costituisce una profonda indagine sulla fragilità e sulla plasticità dell’identità nell’era tecnologica.
Il messaggio filosofico di Maria Grazia Zohar di Karstenegg è complesso e ambivalente al tempo stesso: da un lato, c’è un senso di perdita, di frammentazione, nei suoi corpi spesso incompleti, nelle superfici fratturate, nelle sue figure sospese in un limbo oscuro; dall’altro, c’è un inno alla metamorfosi, alla possibilità di trascendere i limiti del corpo biologico per diventare altro, come un’entità di pura informazione, di pura luce.
L’artista riesce a trasformare il codice binario in un veicolo per esplorare le più profonde questioni spirituali, creando opere che sono idoli per un’epoca che ha perso i suoi valori tradizionali e cerca il sacro nel cyberspazio.
È qui che la sua filosofia si manifesta, in una forma di gnosi digitale, una visione del mondo in cui il corpo è una prigione, o un hardware obsoleto, e l’anima diventa software, aspirando alla liberazione nell’universo immateriale dell’informazione pura.
Il rapporto tra la sua arte e l’emozione è intellettuale e sublimato, un rapporto in cui le emozioni non sono mai esplicite, non si avvertono mai un sorriso o una lacrima, perché le emozioni sono incarnate nella stessa immagine: l’angoscia nella fessura di una superficie, la speranza nel bagliore del metallo dorato, la spiritualità nell’immobilità ieratica di una posa.
Zohar manifesta la sua forte passione per la comunicazione delle sue percezioni nella complessità quasi maniacale delle sue creazioni, dove la sua lucidità cristallina emerge nella coerenza del suo universo simbolico, in un’intelligenza visiva che orchestra ogni pixel in una sinfonia ricca di significato.
Maria Grazia Zohar di Karstenegg è una delle figure più visionarie e intellettualmente profonde dell’arte digitale contemporanea, pioniera di una raffinata Digital Art non copiata da immagini preesistenti, ma che nasce da zero, dalla sua creatività. Un linguaggio artistico coniato anche attraverso la disciplina dei suoi molti anni di attività come violinista professionista.
Maria Grazia Zohar ha saputo creare un idioma unico che unisce una sorprendente maestria tecnica a una profondità di pensiero radicata nella storia della filosofia, del mito e della religione.
Le sue opere non sono immagini da “scorrere” su uno schermo, ma icone contemplative, enigmi metafisici che ci costringono a interrogarci sulla nostra natura di esseri umani, in un mondo che cambia a velocità senza precedenti.
Le sue opere ci pongono davanti a una domanda fondamentale: quando verrà il momento in cui potremo ridefinirci completamente, cosa sceglieremo di diventare? E cosa, della nostra fragile umanità, varrà la pena salvare?